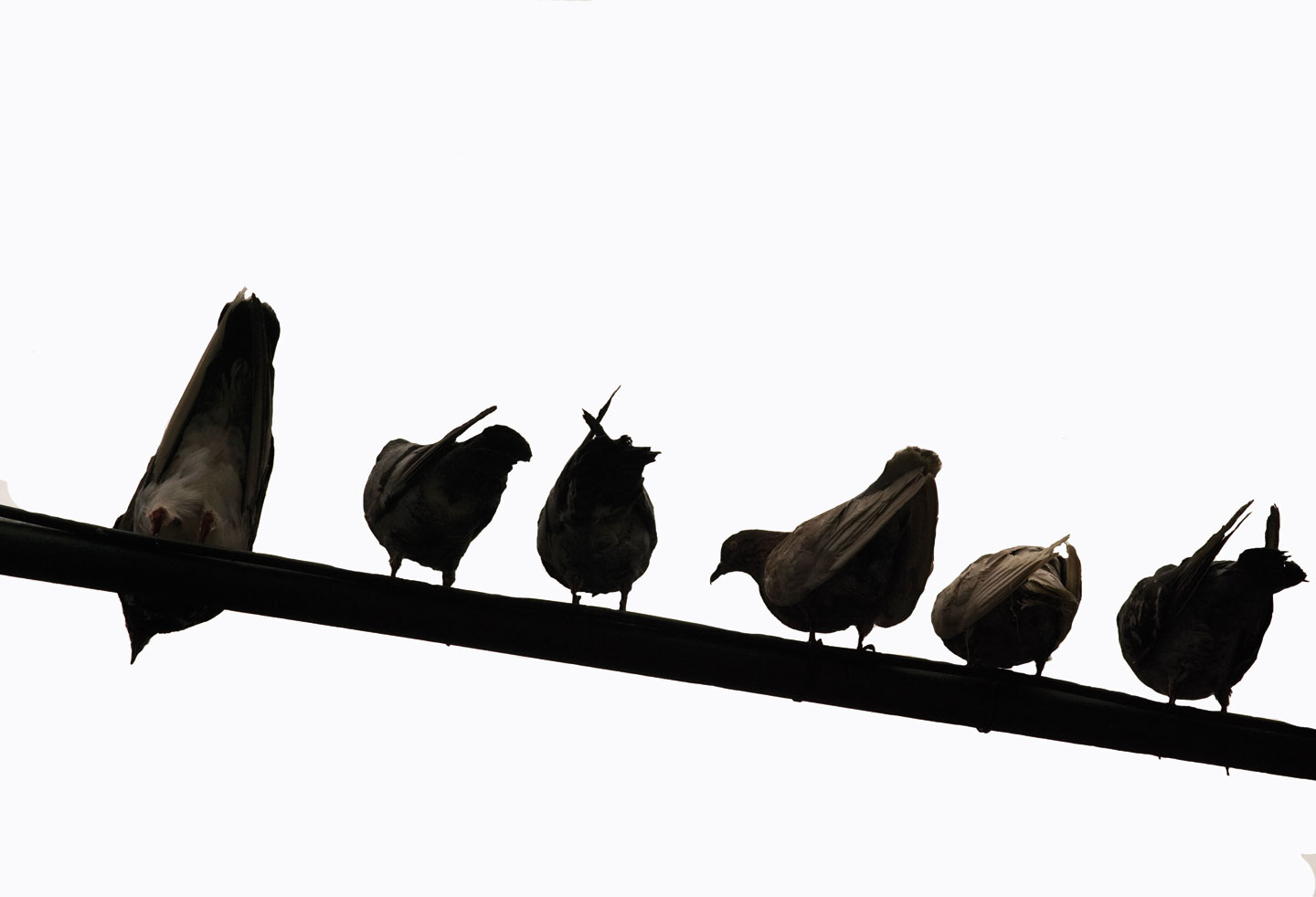Percorrendo la strada aperta dalla Rrose Sélavy di Marcel Duchamp e dalla sua “sorella tragica”, Claude Cahun, l’artista rende oggi esplicito il carattere androgino dell’opera attraverso travestimenti espliciti, ostenta un linguaggio che si interroga sulle possibilità della differenza. Il soggetto contemporaneo, traslato e polisemico, diffuso e fluttuante, nomade e inorganico, deflagra nel corpo dell’arte manifestando una naturalità neutra che sconfina nella deviazione dei ruoli, verso i confini felici dell’indeterminazione. Pierre Molinier (1900-1976) e Urs Lüthi esaltano in una serie di scatti stranianti le proprie caratteristiche intersessuali proponendosi allo spettatore nella versione maschile e nel suo alter ego femminile, antitetico e complementare. Un gioco raffinato di rimandi tra essere e apparire, interpretante e interpretato: uno sdoppiamento costante, perennemente in bilico tra narcisismo autoreferenziale e compiacimento ironico. Di segno completamente diverso i travestimenti di Chan-Hyo Bae, che ripercorre la storia del costume dei secoli passati impersonando aristocratiche donne inglesi. Una ricerca apparentemente innocua che in realtà indaga l’identità etnico-culturale, gli effetti del post-colonialismo e i processi d’ibridazione che attraversano la società contemporanea. Le peregrinazioni identitarie di Chan-Hyo Bae come quelle di Yasumasa Morimura, che invece cortocircuita, attraverso la medesima strategia auto-rappresentativa, il mondo delle attrici di Hollywood con la tradizione giapponese degli Onnagata, mettono in gioco, direbbe Derrida, l’autos dell’autoritratto, il “Sé” inteso come identità consegnata a una definita unità di senso: l’esteriorità indumentale diviene una mera facciata, sintomo di un sé mobile e apparente, espressione di un’identità polimorfa. L’artista si apre in questo modo all’alterità, in uno spazio dove fioriscono l’ibrido, l’impuro e la reinvenzione.
Pur essendo anagraficamente considerabili un uomo e una donna, EVA&ADELE si autoproclamano gemelle ermafrodite dal futuro proponendosi ironicamente come un caso limite di transessualità. Qui la contrapposizione biologica uomo-donna si svuota di ogni significato. Fin dal matrimonio “ufficiale” celebrato nel 1991, EVA&ADELE si sono reinventate una nuova identità caratterizzata da una esteriorità forte, “un’estetica del confetto” che declina le infinite sfumature del lezioso e del kitsch in un processo di simbiosi divertita e beffarda, esternazione del loro mondo incantato, in una sintesi di arte e vita che sfida le convenzionali idee di arte, genere e identità sessuale. Paradigmatica di un sé mobile e apparente è la parabola visionaria di Leigh Bowery, artista in grado di influenzare con il suo stile — una miscela esplosiva di elementi kitsch, suggestioni fetish e provocazione queer — un’intera generazione di creativi: da Boy George a Lucien Freud, da Vivienne Westwood ad Anthony and the Johnsons, da John Galliano e Comme des Garçons a David LaChapelle. Bowery ostenta un’autorappresentazione spietata che inverte i codici vestimentari e destabilizza le norme di appartenenza sessuale, contaminando spregiudicatamente una serie di riferimenti eterogenei: da Botticelli a Botero, dagli azionisti Viennesi a Federico Fellini. Questi artisti mettono in scena una miriade di alter-ego, intraprendendo un viaggio artistico-esistenziale all’interno di tutte le identità possibili, espressione luminosa di quello che mi piace definire un nomadismo identitario, un’attitudine straniante che torna anche nel lavoro di artisti come Steven Cohen, Gilbert&George, ORLAN, Luigi Ontani, Tobias Bernstrup. Prospettive diverse, declinate attraverso le rispettive poetiche ma tutte radicali nell’affermare il diritto irriducibilmente soggettivo di un’identità costantemente in transito, in cui il corpo dell’artista diventa il medium plasmabile per farsi altro da sé, per reincarnarsi in una sorta d’inconscio collettivo in cui si sedimentano le esperienze culturali e sociali della collettività per dare un senso ulteriore al concetto di autorappresentarsi: ovvero rappresentarsi e riconoscersi attraverso la propria rappresentazione.

Le ricerche di questi artisti, posizionandosi oltre le convenzionali identità di genere, intersecano i campi d’indagine della teoria queer, espressione coniata da Teresa de Lauretis con l’intento di ridare centralità alla questione teorica e politica delle differenze, oltre la formula, ormai riduttiva, di studi gay e lesbici. Il termine un-politically correct di “queer” ovvero “diverso”, “strano”, mette in questione il dualismo eterosessuale/omosessuale, promuove un interesse inedito per soggetti sessuali presi nel mezzo di queste due categorie binarie che producono scarti categoriali, ibridi e nuove marginalità corporee: transessuali, transgender, travestiti e travestite, ermafroditi e androgini. I queer studies partono dal presupposto che l’identità artistica si nutra di una miriade di fattori, un amalgama di genere, razza, etnia e sessualità, istanze diverse che concorrono alla produzione di nuovi significati all’interno di un’analisi opposta a quella dominante.
Nella mia pratica curatoriale ho intercettato diversi esponenti di quella corrente che la critica anglosassone definisce “queer artists”, come Ron Athey, Franko B, Lee Adams, o genderqueer performing artist come Vaginal Davis e Pig Pen, altro caso estremo di oscillamento identitario uomo-donna/donna-uomo. Artisti diversi, che lavorano sul tema delle identità e del genere, spesso intercettando il Modern Primitivism, movimento eterogeneo evolutosi da un piccolo sottoinsieme della comunità sadomaso negli Stati Uniti, per poi influenzare il linguaggio delle modificazioni corporali a vari livelli, saturando una certa accezione della Body Art che si carica di un’accezione radicale, estrema.
Ron Athey e Franko B sono due artisti-icona di queste tendenze. Paura, violenza, alienazione, frustrazione e perversione gli elementi caratterizzanti le loro azioni radicali che gettano lo sguardo oltre i limiti della rappresentazione. Protagonista assoluto è un corpo-oggetto espropriato, martoriato, offeso, luogo di malattia e di morte e al tempo stesso strumento di riappropriazione di un’identità finalmente scelta. Entrambi assurgono al rango di Ecce [H]omo brutalizzato e desacralizzato, sul cui corpo si iscrivono i traumi, il dolore e la sofferenza del corpo sociale. Allestiscono un teatro della crudeltà dai toni apocalittici, in cui automutilazioni, tagli, incisioni e perdite di sangue, tracciano i contorni di un’alterità dinamica del corpo e della fisicità.
Catherine Opie è un’artista emblema della comunità queer di San Francisco, che documenta ampiamente sin dai primi lavori, negli anni Novanta. Indaga in chiave politica e polemica un universo di identità alla deriva che sembrano interrogarsi sul proprio senso di appartenenza a una società che tende a patologizzare il “diverso”. Alla stessa temperie appartiene Del LaGrace Volcano, abolizionista del genere, performer, fotografa e attivista ermafrodita che amplifica, autonominandolo, le tracce del proprio corpo.

Nello stesso discorso rientra la vicenda di Genesis P-Orridge, già anima, all’inizio degli anni Settanta, dei COUM Transmissions, gruppo anarcoide volto alla profanazione di ogni genere di tabù, fondato con Cosey Fanni Tutti, a sua volta intenta a scandagliare gli abissi della pornografia. Dopo trent’anni Genesis decide di riscrivere le regole della sessualità iniziando un rapporto simbiotico e allucinato con Lady Jaye Breyer, sua compagna nell’arte e nella vita. Insieme elaborano la pandroginia, neologismo ispirato al cut-up burroughsiano, che da espediente letterario si iscrive direttamente nei loro corpi attraverso la chirurgia estetica, con lo scopo di somigliare sempre di più l’uno all’altra, di creare un terzo individuo ideale, risultante dalla fusione di entrambi. Io è l’Altro, avrebbe detto Rimbaud. Un percorso iniziato ma interrotto dalla morte, nel 2007, di Lady Jaye.
Inglobando alcune suggestioni queer, una generazione più giovane di artisti declina il rapporto, mai scontato, tra arte e omosessualità, nello spirito di un’esperienza estetica e mentale nella quale la difesa dell’omoerotismo, del diritto di praticarlo e di vederlo legittimato, diviene per l’artista omosessuale — e non solo — la punta d’iceberg di una più vasta lotta contro le sovrastrutture di ogni genere, razza, identità sessuale, e contro le convenzionali distinzioni tra arte erotismo e pornografia. Questi artisti irriverenti spingono a una revisione/sovversione degli schemi in funzione di una completa riappropriazione del sé, e penso, per esempio, al lavoro di Dean Sameshima, j-Morrison, Ryan McGinley, Paul Mpagi Sepuya, Ei Arakawa e Sergei Tcherepnin, Xavier Cha, Zackary Drucker, Jibz Cameron, Alexandro Segade, Adam Pendleton, Wu Ingrid Tsang, Mark Flores, Meleko Mokgosi, Kianja Strobert, Wardell Milan, Malik Gaines, Norbert Bisky, Scott Hug e Michael Magnan, Futoshi Miyagi, Alex Mirutziu, Assume Vivid Astrofocus, Remigijus Venckus, Karol Radziszewski, Tanja Ostojiæ, Anastasia Mikhno, Igor Grubic, Maciej Osika, Mark Raidpere.
Un approccio estroso, polimorfico e perverso caratterizza la pratica di Terence Koh, che decontestualizza l’immaginario pornografico di partenza in poetiche narrazioni sulla caducità umana, tra seduzione, lussuria e desiderio. Originariamente noto come “Asian Punk Boy”, Koh restituisce un’atmosfera di sospensione, indaga la sublime trascendenza del vuoto, l’interdizione tra la vita e la morte. Nei suoi lavori l’omosessualità è spesso ostentata, si svincola da limiti ideologici o morali per caricarsi di una valenza esistenziale. Il russo Slava Mogutin dopo una rapida carriera come scrittore e giornalista nella nuova Perestroika di Gorbaciov, a causa dei suoi comportamenti anticonvenzionali e della propria omosessualità di dominio pubblico, diviene persona non grata e costretta a chiedere asilo politico negli Stati Uniti. L’artista racconta sottoculture, provocazioni e feticismi di una gioventù lasciva. Il suo obiettivo ha un approccio brutalmente omoerotico, indaga lo scambio di potere fra dominanza e sottomissione legati all’immaginario sadomaso, all’insegna di un erotismo diretto, prepotente ed estremo.

Paul P. indaga nel suo lavoro numerosi simboli e stereotipi dell’estetica gay contemporanea: contaminando il genere del ritratto, della pornografia e della natura morta, popola i suoi dipinti di delicate immagini di uomini ebbri di desiderio. I suoi ragazzi sono solitamente ritratti nel massimo splendore, disgiunti da qualsiasi contesto drammatico e trasformati in creature esotiche e delicate, immerse in una dimensione incantata. Soluzioni formali che tornando nel mondo fiabesco di Hernan Bas i cui personaggi, sospesi tra adolescenza ed età adulta, innocenza ed esperienza, oscillano tra paesaggio interiore e spazio reale, fisicità e intelletto. Su tutto prevale un sentimento di romantica nostalgia, nutrito di un misticismo languido che tanto appare inopportuno, inadeguato, quanto fascinoso e raffinato, tanto ridondante e retorico quanto attraente e problematico. La strategia di Christian Holstad si nutre invece di elementi grotteschi, fa riferimento a una sfera domestica stravolta da un trauma, mette spesso in scena un’ossessione per l’idea di contagio e infezione, temi ai quali molti altri artisti omosessuali hanno dedicato, allo schiudersi del nuovo millennio, opere importanti. Holstad non sembra però volersi rifare alla riflessione sulla paura dell’HIV che ha influenzato molta arte degli anni Novanta, paura che esorcizza tramite un atteggiamento dissacrante e ironico.
Bas Meerman utilizza una grammatica espressiva che semplifica al massimo l’immagine, forzata nei tratti e animata da una cromia elementare, spesso violenta. I suoi disegni, votati a una omosessualità esuberante e polimorfa, costituiscono un vero e proprio “diario privato”, legato alle fantasie e alle ossessioni dell’artista.

Nel panorama italiano, sparuti i casi di artisti deliberatamente (ed esclusivamente) omoerotici: attivi nell’ambito della fotografia, dagli anni Settanta, Toni Patrioli e Dino Pedriali, amato da Pasolini. Dallo stesso periodo Marco Silombria, raffinato disegnatore. Alla generazione posteriore appartengono Francesco Impellizzeri e Mataro da Vergato e a quella ancora successiva i più giovani Jacopo Benassi, fotografo metropolitano che intercetta senza mediazioni suggestioni queer, comunità bear e feticismi contemporanei, Andrea La Rocca, che restituisce un universo languido e romantico dai toni delicati; Nicola Ruben Montini nella cui pratica performativa l’omosessualità è spesso trattata in chiave polemica e politica, e Luigi&Luca, il cui stile eclettico riattraversa la grande tradizione della fotografia omoerotica. Icona “omomediatica” del Bel Paese è tuttavia Francesco Vezzoli, il cui celebrato modus operandi si nutre di cinema d’autore e riferimenti desunti dalla storia dell’arte, defunzionalizza icone pop o riattualizza divi in disarmo. Il suo citazionismo spregiudicato imbastisce un racconto intriso di bellezza e decadenza, percorre viali del tramonto e scaturigini dell’animo umano. L’artista si appropria di tutti i cliché logorati dai mass media, con ironia caustica e disincantata ne suggerisce una disamina inquietante. La carriera folgorante di Vezzoli decolla nel 1997 con un video che cita Luchino Visconti, ha per protagonista Iva Zanicchi e celebra Mario Praz (An Embroidered Trilogy. OK, the Praz Is Right!), diretto da John Maybury (icona della scena gay underground londinese, suoi i video clip dei Pet Shop Boys, e di Sinead O’Connor, nonché regista cinematografico di successo). Un mix di cultura cinematografica alta e di trash televisivo che diventa il leit motiv del suoi lavori, le cui punte più alte, a oggi, sono caratterizzate, in termini di estetica gay, dal Trailer for the Remake of Gore Vidal’s Caligula (2005) e dall’esilarante Marlene Redux: a True Hollywood Story (2006). Il primo ispirato al controverso film di Tinto Brass Io, Caligola (1979), sceneggiato da Masolino D’Amico e dallo stesso Vidal, che vanta la partecipazione di una serie di star hollywoodiane come Benicio Del Toro e Milla Jovovich, oltre che di Courtney Love e della nostrana Barbara Bouchet, mentre i costumi sono realizzati da Donatella Versace; nel secondo l’artista imbastisce una compiaciuta parodia sensazionalistica dei documentari televisivi americani. Realizzato in memoria di se stesso, ricostruisce la sua carriera e la sua stessa morte attraverso le testimonianze di amici e nemici, spezzoni d’archivio ed estratti delle sue opere.

Queste le tracce di un percorso per immagini necessariamente parziale e frammentato, volto a ripercorrere attraverso exempla, l’evoluzione della percezione e la conseguente rappresentazione della diversità esistenziale dall’inizio del XX secolo a oggi. Una breve carrellata che non può, non pretende, né potrebbe dare ragione della ricchezza e della complessità del panorama attuale. Arduo aspirare a “mettere ordine”, elaborare rigidi canoni interpretativi, fornire visioni sistematiche e definitive. La realtà in movimento si presta poco a queste operazioni. Il sistema odierno dell’arte ancor meno. Ancora più arduo interrogarsi sulla legittimità di un’estetica gay o sul suo ubi consistam.
Rinunciando ad ambiziose ipotesi interpretative ho mirato, più modestamente, all’individuazione di grumi tematici e linee di tendenza.
In via generale, mi sembra evidente che abbia senso parlare, senza remore, di “arte omosessuale” almeno per un determinato contesto storico-culturale recente, a cavallo tra XX e XXI secolo, così come penso sia possibile rintracciare una generica “sensibilità omoerotica” nel passato, anche se le valenze culturali che esprime e i significati che sottende sono il riflesso di specifici contesti storici e socio- culturali. In sostanza per tutta l’arte precedente la cosiddetta after Stonewall era può esistere uno “specifico omosessuale” ma non (tranne che in sparuti casi) una “specifica” arte omosessuale. Diversamente si corre il rischio di ipostatizzare un’arte omosessuale, si crea il paradosso di postulare criteri interpretativi diversi da quelli applicati alle opere di artisti eterosessuali. È necessario resistere alla tentazione di includere nel concetto di “arte gay” ogni opera che mostri due persone dello stesso sesso in atteggiamenti intimi o che presenti un uomo nudo. Questo eccesso di zelo non solo non è d’aiuto nella definizione dei confini e delle caratteristiche di un’arte omosessuale, ma rende anzi impossibile distinguere la semplice convenzione iconica dal vero e proprio messaggio in codice, destinato a una specifica sensibilità erotica minoritaria.

Non credo inoltre all’arte come biografia e ancor meno come “test proiettivo”. Indubbiamente, quando si tiene conto degli elementi extra testuali dell’opera e della biografia distintiva dell’autore, si nota che gli elementi costitutivi di una biografia omosessuale presentano alcune particolarità, enfatizzano in maniera diversa certi aspetti, presuppongono un’organizzazione tassonomica “altra” del vissuto. Anche se l’orientamento sessuale rimane sullo sfondo, la considerazione paritaria degli orientamenti sessuali non esclude tuttavia l’esistenza dei due punti di vista e la loro sostanziale diversità, apprezzabile soprattutto sul piano del significato. Su quello del significante non vi sono differenze sostanziali, anzi prevalgono caratteristiche intersessuali. Difatti, artisti omosessuali e artisti eterosessuali fanno uso di forme, strumenti e tecniche espressive identiche: il frequente ricorso alla decostruzione in ottica destrutturante, rimandi intertestuali, citazionismo ma anche contaminazioni di forme, stili e generi, canonizzazione di una serie di stilemi acquisiti, slittamenti temporali accrescitivi di effetti stranianti, gusto per la provocazione, propensione per l’eccesso. Ma anche all’estremo opposto una poetica minimale, un alto rigore formale, messaggi a mezza voce all’insegna dell’understatement.
L’arte è un linguaggio che racconta, innanzitutto, l’epoca che l’ha prodotta. Solo alcune opere lasciano trasparire il modo di essere dell’artista che le ha generate e tra gli artisti soltanto alcuni svelano un interesse per aspetti dell’Eros umano che non sono tipici di uno “sguardo medio”, rivolto alla bellezza del proprio sesso. Uno sguardo che nelle persone eterosessuali è solitamente distratto, se non apertamente disinteressato, a considerare un corpo del proprio stesso sesso come “desiderabile”. Solo un artista che dedichi particolare attenzione a registrare la bellezza e la desiderabilità di un corpo o di un volto del proprio sesso rivela, a chi condivide la sua prospettiva, la sua alterità esistenziale, qualcosa che invece sfugge a uno sguardo cosiddetto “normale”. E che ovviamente per chi non condivide tale prospettiva appare irrilevante, sicuramente privo d’interesse.
Si potrà dunque parlare, a mio avviso, di “arte gay” solo nella misura in cui in essa traspaia il modo in cui l’artista vive e considera la tematica omosessuale, che non necessariamente è la sua, nel senso che può essere dettata da motivi molteplici e differenti e non necessariamente da un sostrato autobiografico. Ne deriva che non può essere considerata “arte gay”, tutto ciò che esce dalla mente e dalle mani di un artista omosessuale. Analogamente un’opera decisamente omoerotica, in alcuni casi può addirittura non essere frutto di un artista omosessuale.
Queste le conclusioni cui giunsi quando preparavo la ormai famigerata “Arte e Omosessualità. Da von Gloeden a Pierre et Gilles”, mostra tra le più contestate degli ultimi anni, che tentava di visualizzare, per la prima volta in Italia e in maniera così ampia, questa relazione di lungo corso, prima che fosse travolta, e il suo senso inevitabilmente snaturato, dalle spire dell’amplificazione mediatica, dall’uso politico strumentale e obliquo. La storia è piena di vicende analoghe. Ultima, ma solo in ordine di tempo, la mostra “Hide/Seek: Difference and Desire in American Portraiture”, organizzata alla Smithsonian’s National Portrait Gallery di Washington D.C., centrata sulla ricognizione del discorso sul gender e sull’omoerotismo nell’arte americana degli ultimi cento anni. Pietra dello scandalo, nel mio caso Miss Kitty (2006) di Paolo Schmidlin, scultura colpevole di esibire un grottesco uomo di mezz’età en travesti, le cui fattezze rimandano “pericolosamente” a quelle di Benedetto XVI, opera la cui fama ha travalicato i confini nazionali diventando icona mediatica di manifestazioni come il gay pride; in quello americano A fire in my belly di David Wojnarowicz, video concepito dall’artista dopo la morte per AIDS del compagno, l’artista Peter Hujar, che precede di poco la sua. La sequenza che mostra un crocefisso cosparso di formiche attira minacce di scomunica e, soprattutto, di taglio delle sovvenzioni allo Smithsonian, che preferisce chinare il capo rimuovendo l’opera incriminata. Il sottoscritto in seguito alla censura dell’ex sindaco Moratti, preferì far trasmigrare, incensurata, tra non poche difficoltà, la mostra dal milanese Palazzo della Ragione alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella a Firenze. Ma le vicende in entrambi i casi sono note, inutile tornarvi sopra.
Alla luce della mia esperienza diretta, posso affermare che questi meccanismi sono particolarmente rivelatori del “gioco” dell’arte contemporanea, atto a riattualizzare ciò che l’arte persegue dall’inizio del secolo scorso: trasgredire una frontiera e allo stesso tempo renderla evidente, mettendola, contestualmente, “in mostra”. Questa strategia si completa nell’ermeneutica sottesa al presente dell’arte, che condiziona l’interpretazione e la percezione del lavoro di un’artista da parte di addetti ai lavori e spettatori, la cosiddetta “gente comune”, per la quale l’opera d’arte contemporanea continua a fare scandalo, felicemente per gli artisti, che altrimenti perderebbero ogni potere trasgressivo. Queste reazioni tuttavia non hanno particolare presa su oggetti, opere e azioni dell’artista, tanto oggi è grande la distanza tra “profani” e “specialisti” e tanto questi ultimi beneficiano di una loro legittimità nel mondo colto. Una volta preso nel gioco, ovvero una volta persuaso che in questo gioco ci sono dei valori (artistici) da difendere, perfino degli errori morali — da non ripetere, se si preferisce — il mondo colto si adopera per reintegrare le trasgressioni nel campo del guardabile, del commentabile, perfino dell’ammirevole, in ogni caso dell’interpretabile. Ma non cadrò in questo errore: è con il commento e la ricerca di senso che si fa l’esatto opposto di ciò che l’artista ha appena fatto. Una sorta di “gioco”, in cui a ogni movimento dell’artista corrisponde un movimento del critico, a ogni esposizione un’interpretazione, a ogni trasgressione una re-integrazione. In questa strategia regolata di esplorazione dei limiti, che mette alla prova e allo stesso tempo fa arretrare i limiti dell’accettabilità artistica, il minore di questi “colpi” è una sfida alla critica, operatrice di legittimità. Non si può capire quello che Nathalie Heinich chiama il triplice gioco dell’arte contemporanea3 senza prendere in considerazione la produzione delle opere da parte degli artisti e la loro ricezione da parte dei critici, la sfida al buon senso e la creazione di senso, la distruzione delle regole e la loro ricostruzione, la mano trasgressiva degli uni e la mano integratrice degli altri.
D’altronde il Wesen dell’opera d’arte è costantemente nutrito dalla possibilità di letture molteplici. La polisemia dell’opera scaturisce dall’interazione con lo spettatore, offrendo, di volta in volta, una risposta diversa secondo il tipo di domanda posta. E se l’arte desse risposte diverse a spettatori diversi, e magari tutte altrettanto valide? E se provassimo a chiederci che cosa vogliono le immagini, come fa provocatoriamente W.J.T.Mitchell? E se così fosse che male ci sarebbe a chiedere a un’opera se oltre a essere gay, possa essere religiosa, sociale, perturbante, polemica, etica, politica, finanche inutile o patetica? E se lasciassimo che fosse l’arte stessa a rispondere alle nostre domande, in barba a critici parrucconi, politici che rinverdiscono nefasti dal sapore neo-controriformato e rinfocolati integralismi religiosi?
All’epoca delle famigerate vicende coniai quello che mi sembrava dovesse essere il mio epitaffio curatoriale e che da allora è invece diventato il mio motto: all’artista libertà di espressione, al critico di selezione, al pubblico di opinione. A ognuno la responsabilità morale delle proprie scelte.