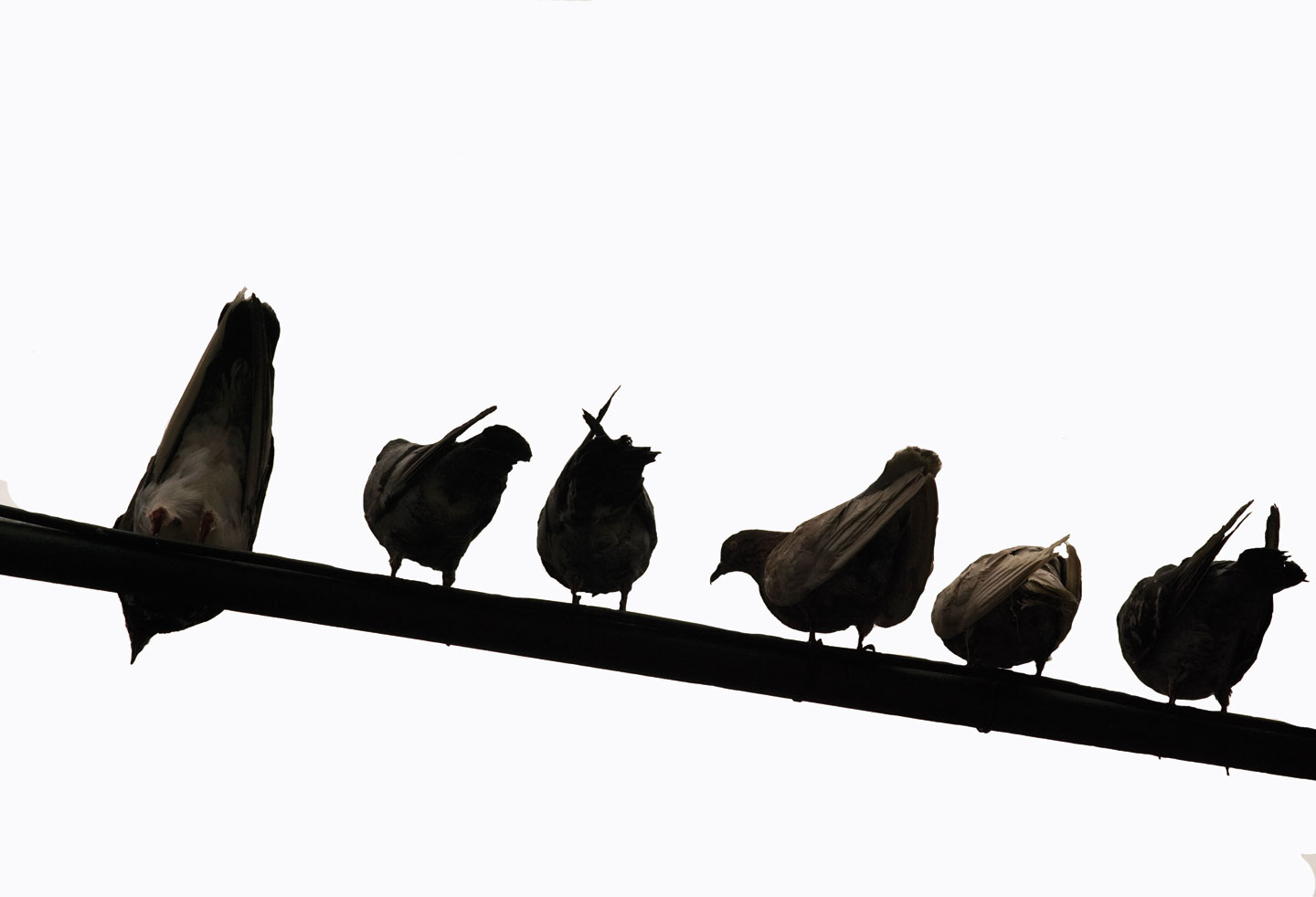Avere a disposizione poco più di un decennio per realizzare la propria opera, in uno stato di frenesia derivante dalla consapevolezza che la vita non avrebbe oltrepassato il traguardo dei trent’anni: questo è stato il destino di Paolo Scheggi, e per ricordarlo e ritrovare il senso ancor oggi bruciante della traccia da lui lasciata nell’estetica del secondo Novecento — sia in quanto ricerca artistica che modo di sentire — non si può prescindere da questa premessa. Al pari di una di quelle figure femminili evocate da Rainer Maria Rilke nelle pagine iniziali de I quaderni di Malte Laurids Brigge, le quali portavano in grembo due frutti, una creatura e una morte, un artista come lui non credo sia comprensibile perdendo di vista questa compresenza di gestazione creativa e di sensazione fisicamente vissuta, al di là di ogni presa di posizione filosofica, di “essere per la morte”. Si sbagliò di pochi mesi: il suo cuore, dilatatosi oltre misura per una patologia tragica e bizzarra, si fermò sulla soglia del suo trentunesimo anno.
Approdato a Milano dopo gli eroici furori repressi negli anditi e negli ansiti delle contrade fiorentine e dopo il liberatorio respiro di un soggiorno a Londra, il ventunenne Paolo Scheggi intuisce prontamente che, per superare il guado ormai stagnante dell’Informale, il faro da individuare per orientarsi e trovare una nuova rotta ha un nome ben preciso, e si chiama Lucio Fontana. Non sarà dunque un caso che, superata quasi come un residuo adolescenziale la fase dei quadri “a lamiere sovrapposte”, a presentare la sua prima mostra importante e le sue prime opere dalla personalità ormai delineata, le “intersuperfici a zone riflesse”, intervenga di persona, nel 1962, proprio il maestro dello Spazialismo. Il quale rimarcherà due motivi che definiscono en abrégé il senso e il succo delle opere dell’artista toscano: la “profondità” cromatica e il loro emergere da un sottofondo di febbrile ricerca e di permanente inquietudine. La sperimentazione si sviluppa infatti, senza tregua, su più fronti, affrontando implicazioni architettoniche e soffermandosi, in quegli stessi anni, nella stesura di un romanzo in forma di poesia concreta.

Courtesy Niccoli Arte Moderna, Parma; Archivio Scheggi.
La superficie del quadro, con il suo carico di eredità e di convenzioni rappresentative, una volta lacerata, perforata, accoltellata da Lucio Fontana, si rivela un campo di ricerca usurato. In questo desiderio di andare oltre la piatta rappresentabilità offerta dalla superficie pittorica, Scheggi concorda con gli altri giovani leoni della scena milanese: Castellani, Bonalumi, Alviani e Manzoni, con i quali entra in contatto e si lega in un rapporto di frequentazione e complicità. Ma mentre questi indugiano prevalentemente su una sorta di protrusione modulata, di aggetto multiplo o anche su una disciplinata confricazione luminosa, Scheggi, che era il più giovane fra di loro, si volge risolutamente verso il dentro del quadro, a cogliere e registrare una sua risonanza interna, quasi a farvi circolare delle bolle d’aria, dei respiri di spazio. Il quadro ha un altrove, dentro di sé, la scena della rappresentazione diventa un palcoscenico praticabile esso stesso: proprio dallo spettatore, che con il suo sguardo può sintonizzarsi sulle variazioni e modulazioni programmate del pattern dei ritagli e dell’alternarsi dei piani. La superficie si triplica, attraverso i varchi di una tela che si apre non più, come in Fontana, secondo una lacerazione primaria e quasi tellurica, ma con studiati accorgimenti, con algebrica premeditazione. Ecco allora che ciò che nell’ammirato maestro era stato uno squarcio o una sequenza di punture diventa una musica e un ritmo, la tela si dilata secondo una direttiva orbitale, si impreziosisce di eleganti alveoli ovoidali, modulati e modanati con manuale accuratezza. I bordi del taglio vengono rimboccati, arricciati su se stessi con un accorto procedimento che non lascia alcuna slabbratura. E il tutto è coeso entro l’uniformità di una monocromia tassativa. Eppure sempre di “quadro” si tratta: tre tele sovrapposte, con dei vuoti incisi, il cui contorno ricorda ora dei triangoli dai bordi allentati e come centrifugati in un sovrapporsi di ottiche sghembe, ora degli ovoidi più o meno compressi, offerti a una luce che vi sbava contorni d’ombra di volta in volta diversi. Dunque, sebbene queste aperture nel tessuto del quadro siano realizzate sulla base di algoritmi e sequenze algebriche, si incarnano in un prodotto manuale e quindi accidentale, e si relazionano a un ambiente e a una percezione. E infatti uno dei pensatori che più attirano l’attenzione del giovanissimo artista è Maurice Merleau-Ponty, il quale parla di uno spazio esistenziale, di tanti spazi quante sono le esperienze spaziali che di volta in volta si verificano fenomenicamente. Dunque da una parte una meditazione che oggettivizza e verifica, una ricerca d’ordine, un progetto e una programmazione; dall’altra un abbandonarsi al fenomeno, al divenire dello spazio, a quello spazio in cui, per usare le parole di Michel Foucault, “si svolge concretamente l’erosione della nostra vita, del nostro tempo e della nostra storia, questo spazio che ci rode e ci corrode”. Ecco, proprio questo senso di corrosione incessante, degna della più funebre fantasia barocca, non dobbiamo dimenticare parlando di Scheggi, dato che lo ritroveremo, purtroppo, esplicitato ed esibito, ben presto.
A partire dal 1964 ecco apparire le “intersuperfici modulari”, ancora più risicate nelle loro variabili. Ancora tre piani: sul primo, composto da un assemblaggio ortogonale di moduli quadrati, è fustellato un cerchio, cui corrisponde un semicerchio di pari circonferenza nello strato intermedio, cosicché ciascuno di essi si trova come sbarrato, aperto a metà, come una luna perennemente dimidiata, come un oblò semi-cieco. Oppure, al cerchio aperto sul primo livello ne segue un altro ritagliato nello strato sottostante, più piccolo e decentrato, secondo vari orientamenti, come oculi in stato di permanente strabismo. In una dialettica, come sempre, di vuoto-pieno, di ombra-luce, di superficie-profondità, si staglia un quadro-oggetto a percezione variabile, fatto di ritmi preordinati e di letture imponderabili da parte di chi guarda, a seconda della luce e della posizione, come se l’oggetto della percezione fosse stato modellato, impassibile e liscio, attraverso una tramatura elementare ma giocata secondo una logica combinatoria che variamente direziona diametri e posizioni entro la cornice di vuoto delineata da ogni singolo modulo in primo piano, e suscettibile di innumerevoli combinazioni, o contaminazioni atmosferiche. E dobbiamo qui ricordarci delle prove di letteratura concreta e poesia visiva, per ribadire come fra scrittura e geometria vi siano sempre stati continuità e interscambio. Lara Vinca Masini, che poté prendere visione di una pagina di questo lavoro rimasto inedito, notava come esso, realizzato con la macchina da scrivere, fosse dominato dalla presenza della lettera “e” minuscola e come, formalmente, ciò potesse essere considerato un’anticipazione grafica delle immagini a cerchio spezzato delle intersuperfici modulari.

Questo secondo tipo di intersuperfici, razionalizzate nel susseguirsi dei moduli, realizzate in cartone fustellato e soprattutto in alluminio smaltato, rivelavano un maggiore automatismo, avvicinandosi a un’arte più algidamente programmata e asettica, senza quel “di più”, come notava qualche anno fa Agostino Bonalumi, che rendeva le tele ancora soggette all’imprevisto della manualità, irretite in uno statuto di sottile, accattivante imperfezione.
Tuttavia, a compensare questo raffreddamento, ecco che l’altra componente, vitalistica, fenomenica ed esistenziale, si dilata oltre il quadro-oggetto. Prende consistenza architettonica, si espande nell’ambiente, investe il percorso dello spettatore, per poi definitivamente coinvolgerlo in azioni di risoluto impianto teatrale.
Con Intercamera Plastica, realizzata nel 1968, la scansione delle intersuperfici si dilata in uno spazio percorribile. Scheggi ne aveva già fatto esperienza durante la sua collaborazione con architetti e designer e con la ristrutturazione dell’atelier di moda di Germana Marucelli, sua conterranea e lontana parente, nonché sua liberale ospite nel primo periodo del soggiorno milanese. La sua attenzione si focalizza su quelle che egli chiama “interferenze volumetriche”, superfici architettoniche lasciate normalmente inerti e passive e che invece possono e debbono essere riqualificate come momenti significativi dell’abitare e del vivere. Lo stesso può dirsi dell’attività di scenografo, in cui si cimentò collaborando con Giuliano Scabia a una rilettura de L’isola purpurea di Bulgakov. Anziché limitarsi a riempire uno spazio, la scenografia è tenuta ad “abbandonare l’illusione ed entrare nella realtà, trasformare lo spazio virtuale in spazio reale, spostare lo spazio reale in tempo visibile e vivibile, rifiutare la contemplazione per l’azione, lo statico per il dinamico”. E in questa nuova prospettiva, alimentata dal bisogno di ampliare il raggio d’azione proprio dell’artista, per un più soddisfacente rapporto di interrelazione con un pubblico chiamato a divenire attivo e complice, si fa strada l’idea di dover riempire, più che uno spazio, un tempo. Siamo al 1969, con Autospettacolo Scheggi si fa pioniere di modi e segnali antesignani di quell’arte “relazionale” oggi così sulla bocca di tutti, coinvolgendo gli abitanti di un’intera cittadina, Caorle. Nel frattempo continuava il processo di osmosi fra scrittura e spazio, intersecandosi, sempre di più e sempre più freneticamente, col fattore temporale: scrittura fluttuante, in movimento, che interfolia in un’unica pagina spazio e tempo, come in un libro in perenne divenire, nel combinarsi e decombinarsi delle possibilità. Lo spazio del libro in cui ci troviamo a pronunciare le parole della nostra esistenza aspira così a tramutarsi, come in quel “Libro” definitivo di cui parla Hegel, in puro tempo.

In azioni memorabili — ancora palpitanti e struggenti nelle foto in bianco e nero che ne restano fragile documento — come per esempio Oplà-Scheggi, messo in scena per le strade di Firenze, i caratteri a stampa che formano le parole, ingigantendosi in bianche sagome da portare a braccia ed esibire in corteo assumono una consistenza plastica, come solidificati in una geometria ondivaga, scomponibile e variabile secondo l’imprevedibile combinatoria di un fluire processionale, fra spensieratezza e sacralità, vitalità solare e notte incombente: oplà! Parola liberatoria e magica in cui non è possibile, per un meccanismo che non so se sia stato inconscio o “programmato”, non vedere anagrammate le lettere del nome proprio, Paolo, identità vitale e operante, che si sfaldano e si ricompongono in una liturgia del perenne divenire: Paolo, che nella Marcia funebre o della geometria, processione secondo Paolo Scheggi aveva prefigurato il suo stesso funerale, cubi e coni, cilindri e piramidi portati in processione in una piazza cittadina, a Como. E poi, ancora più conciso e profetico, l’ultimo suo intervento, primi mesi del 1971, 6profetiper6geometrie, alla Galleria del Naviglio di Milano. Solidi geometrici, lisci e perfetti, esposti su una base scura, sostenuta da leggeri cavalletti d’acciaio e tripartita, tramite delle cerniere, in modo che le due sezioni laterali, incavate secondo i contorni delle rispettive sagome supportate, potessero richiudersi come due mascelle dalla presa millimetrica, pronte a fagocitare nel buio dell’indistinto ogni ipotesi di geometria, di scansione vitale delle forme, come se il michelangiolesco “soverchio” della materia riprendesse il sopravvento su ogni ipotesi di individuazione e di identità. Guardando queste immagini, le scarne parole con cui Carlo Emilio Gadda condensa il momento dell’approssimarsi della fine, quando la realtà intorno si de-categorizza e rientra nell’informe, il momento in cui “diedri e prismi, luci ed ombre vanivano”, vengono in mente in guisa di epigrafe a un presentimento incombente. E quando, pochi mesi dopo, si svolse a Roma il funerale di Paolo Scheggi, predisposto e “programmato” dall’artista come un’estrema opera in absentia, tra musiche di Chopin e aromi di rose sfiorenti nella calura di prima estate, si ebbe quasi l’impressione, secondo la testimonianza di Vincenzo Agnetti, di assistere a un falso, a “una copia della copia… realtà come ripercorso di una recente simulazione… recuperata solo dalle ordinate valenze dell’apparire e sparire nella geometria dell’essere”.