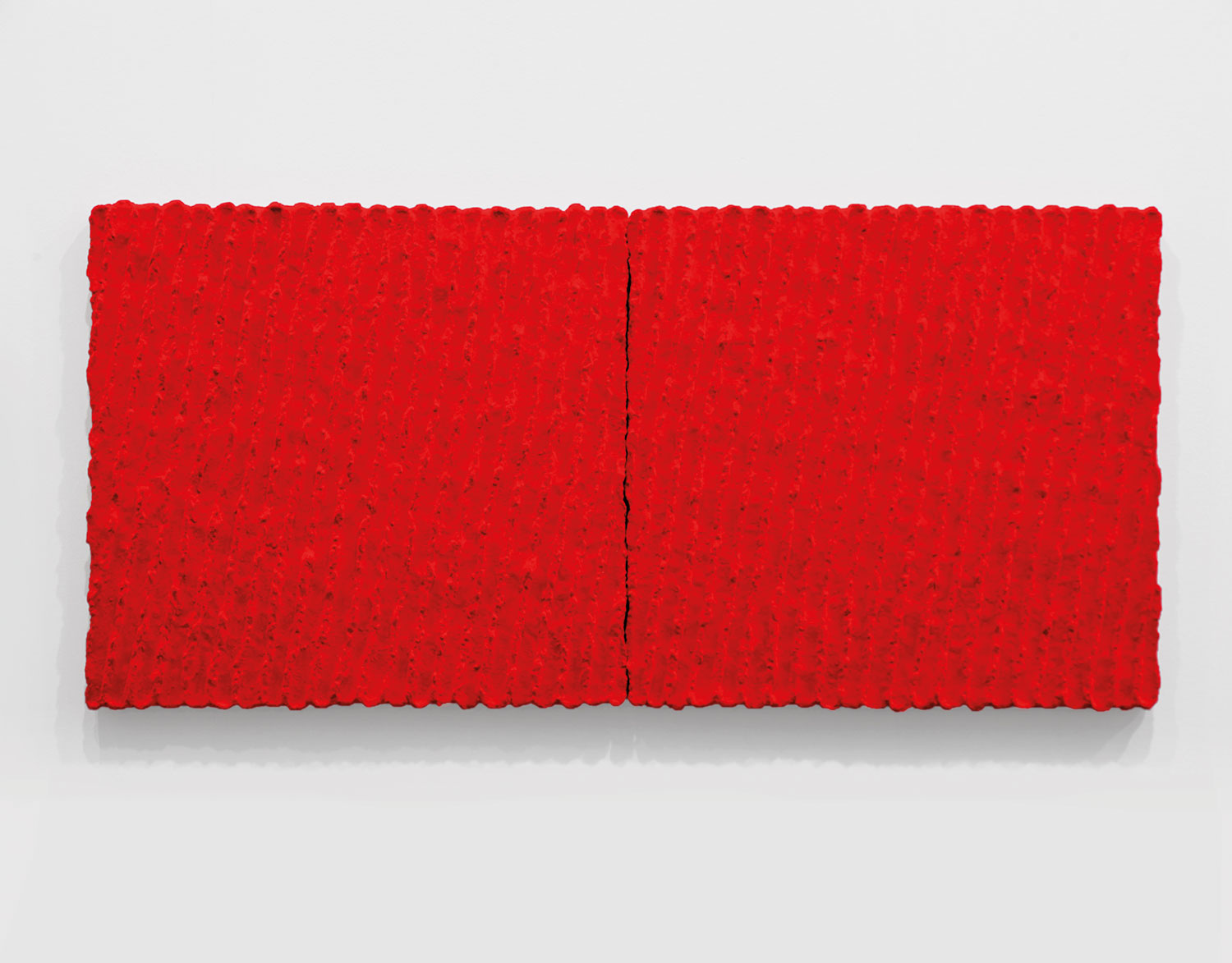A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso rappresentanti e teorici della moda e del design si sono interrogati, con modalità ed esiti diversi, sull’esperienza del vestire/rsi come espressione saliente della relazione che intercorre tra le forme dell’abitare e le rappresentazioni della propria attualità. In particolare, il dressing design degli Archizoom Associati, l’abito reale del gruppo Superstudio, il design indemodabile[1] di Nanni Strada e, contestualmente, il modello del prêt-à-porter perfezionato da Walter Albini, hanno messo in discussione il sistema della moda mainstream, rivendicando dalle rispettive posizioni una più adeguata aderenza alla “vita”. La relazione tra corpo, abito e ambiente diventava, di fatto, in quegli anni, centrale alla configurazione di nuove possibilità vestimentarie, anche sulla scia degli stili controculturali che, dalla seconda metà degli anni Cinquanta fino all’emersione del punk, avevano puntualmente agitato le acque stagnanti della politica dell’apparenza.
A questa distanza temporale è interessante guardare al sentimento di discontinuità che ha allora animato queste coeve visioni ed esperienze progettuali. Dall’inizio degli anni Ottanta, sulle pagine della rivista Domus sotto la direzione di Alessandro Mendini, il dibattito culturale sull’abito avrebbe via via interiorizzato la consapevolezza che la moda, pur esprimendosi attraverso il meccanismo selettivo dell’inclusione e dell’esclusione, si alimenta di ogni forma presente dell’abitare. Osserva a questo riguardo Alberto Abruzzese:
Se un essere è fuori moda significa che occupa un’altra spaziatura mondana spontaneamente o intenzionalmente diversa, eccentrica, alternativa, ma comunque è circoscritto nelle forme dell’abitare. La storia dell’industria culturale ci ha tuttavia mostrato con dovizia di processi esemplari – basti pensare al ruolo delle avanguardie storiche – che questi atteggiamenti di rifiuto, attivo o passivo, sono il bacino creativo a cui attingono le mode per produrre il nuovo che le contraddistingue come emergenza, nel fluire del tempo, di un presente ostentato, esaltato ed esibito, simbolicamente rafforzato (e così illuminato di futuro, per simulare un suo più forte distacco dal passato a cui il presente deve tuttavia la propria riconoscibilità, la sua capacità affettiva). Dunque la moda – l’essere al presente – lavora sulle differenze spazio-temporali: non solo sul passato che evoca per contrasto e affinità ma anche sul presente che le resiste, le sfugge, la sorpassa.[2]
Gli anni Settanta sono stati considerati dagli studiosi di moda come un decennio schizofrenico, non connotato da uno stile ben definito, e perfino un decennio in cui la moda è andata paradossalmente fuori moda. Nel 1972, la rivista in. Argomenti e immagini di design ha dedicato il numero monografico di novembre–dicembre al tema “Moda e società”. Coordinata da Gillo Dorfles, la pubblicazione – preziosa antologia di contributi firmati da intellettuali militanti, architetti, designer, artisti – muoveva dalla preoccupazione per la crescente influenza che la moda, emblematica espressione di un’attitudine alla “preferenzialità portata alle sue ultime conseguenze”[3] a scapito della “migliorità” (betterness), esercitava capillarmente sul contesto socioculturale. Dorfles riconosceva a quel fenomeno onnipresente l’energia di una “forma ancora vitale”: “la moda – scrive nell’articolo che introduce la rivista – si traduce in quello per cui di solito nessuno la riconosce: la più autentica forza propulsiva capace di spingere l’uomo alla scelta di alcunché per una ragione di pura preferenza, non per motivi razionali, né etici, e neppure, tutto sommato estetici”.[4] È dunque la moda, forma simbolica di incostanza e arbitrarietà in nome del mutamento per il mutamento, a essere stigmatizzata: “la moda non è solo quella dell’abito, della haute couture e del prêt-à-porter, ma è quella che s’infiltra nei mobili, nelle case, nei gusti artistici o an-artistici, fino a diventare la vera padrona persino delle nostre ideologie: politiche, economiche, sociologiche, linguistiche”.[5] In particolare, il critico d’arte sottolineava come la nozione di stile– “quello per cui la moda s’accosta di più ai diversi fenomeni artistici”[6] – avesse subito uno sbilanciamento a favore della crescente affermazione dello styling, termine che volgeva l’opera del designer verso la cosmesi dell’oggetto, “l’abbellimento d’una forma utilitaria per renderla più attraente e appetibile al consumatore”.[7] La crescente tendenza a incorporare nel prodotto un alto contenuto immateriale ed emozionale permetteva al linguaggio della moda, a differenza di altri, di “istituzionalizzarsi d’emblée, […] quasi per un’affermazione e una proliferazione spontanea e di risultare decriptabile prima ancora d’essere stato del tutto formulato e formalizzato”.[8] Dorfles avvertiva perciò il rischio di un gusto sempre più eterodiretto e della difficoltà di distinguere nel prodotto di design “l’aspetto artistico da quello modale”, “i valori autentici dai disvalori legati a fenomeni epocali”.[9]

Se la visione dorflesiana registrava il prevalere della capacità rappresentativa dell’oggetto indumentale sulla sua funzione d’uso, i gruppi Archizoom Associati e Superstudio guardavano al ruolo dell’abito dalla prospettiva della relazione tra chi progetta e chi fruisce all’interno di una stagione di avanguardia diffusa, aperta allo sperimentalismo e a nuovi rapporti con l’industria. Pur riconoscendo all’abito la funzione di uno strumento creativo e comunicativo nelle mani dei fruitori, gli Archizoom Associati prefiguravano il dressing design come un modello progettuale in cui lo stilista o il designer, “a monte delle singole individualità”, aveva il compito di ideare capi “flessibili a un uso specializzato e indifferenziato contemporaneamente”.[10] La produzione industriale dell’abbigliamento andava rigenerata attraverso materiali e modalità costruttive alternative alle tecniche e alle figure della tradizione artigiana. Su un versante diverso ma parallelo, il gruppo Superstudio, a fronte dei “sogni di false identificazioni” indotti dal sistema della moda, proponeva “una semplice attività decondizionante tesa ad abolire l’iperconsumismo, i travestimenti sottili e le civili solleticanti gratificazioni”.[11] La loro posizione si caratterizzava per un tratto decisamente radicale: “Il problema è quello di eliminare noi stessi come facitori di immagini, di eliminare noi stessi come sostenitori di questo sistema di violenze che è la progettazione. […] Non occorre che ci sia alcuno che disegni cose per gli altri […]. L’unico progetto è disegnare noi stessi, l’unico oggetto della progettazione è la nostra vita”.[12] La progettazione vestimentaria andava così sottratta al tentativo “nevrotico” degli architetti “di controllare totalmente l’environment” e doveva limitarsi a realizzare l’abito reale: “una semplice produzione di vestimenti fondamentali, razionali, di basso o nessun costo, anonimi”.[13]
Ma cosa accadeva contestualmente sul mercato reale dell’abbigliamento, alla cui progettazione si guardava come a uno degli strumenti “per modificare la qualità della vita e del territorio”?[14]
Nell’ottobre del 1967 Vogue Italia presentava ai lettori dell’ancora fresca edizione domestica della rivista i modelli del giovane stilista Walter Albini che all’alta moda aveva preferito il prêt-à-porter, perché – come recita il redazionale – “va incontro alla vita, è per tutte le donne e le aiuta a vivere”.[15] Ma questo slancio, fin troppo ecumenico per lo stile comunicativo della rivista, era in realtà sintomatico della profonda rivoluzione che stava investendo tanto la filosofia vestimentaria del tempo che le sue modalità produttive. Albini aveva compreso che bisognava consolidare il processo di democratizzazione della moda non solo sulla scia della lezione modernista di Chanel, ma introiettando le istanze antimoda presenti sulla scena sociale, a partire dalla rivendicazione dei giovani di allora, dagli hippies ai loro epigoni, decisi ad armonizzare sul proprio corpo – “come un oggetto d’arte tridimensionale, da ammirare e da toccare”[16] – capi diversi per stile e contesto culturale, assecondando un libero e personale gusto per il montaggio indumentale. Dai banchi dei mercatini delle pulci si riportavano in vita abiti dimenticati, parti di vecchie uniformi e costumi etnici che, una volta spogliati delle loro originarie connotazioni simboliche, aprivano le porte a un esotico spaesamento spazio-temporale tutto proiettato sulla propria apparenza. Albini intuì che quel gusto per il rétro, sempre meno ingenuo e sempre più espressione di una sofisticata e ironica sensibilità camp, andava considerato una sorta di ribellione nei confronti di un mercato dell’abbigliamento incapace di farsi interprete di modalità d’essere ancora latenti. Il momento storico era dunque maturo per “andare a recuperare nella memoria ciò che [mi] piace”: “noi stilisti – afferma Albini – non sappiamo progettare nulla nella moda, ma sappiamo progettare lo stile della moda”[17]. Sicché il nuovo corso andava giocato sulla centralità dello stile/stilismo, nozione che rimandava tanto all’attualizzazione delle voghe del passato, attraverso un processo di rieditazione metalinguistica delle forme sedimentate nel patrimonio culturale della moda, quanto al progetto di singolarità dei fruitori prevalentemente orientati alla valorizzazione di se stessi e all’estetizzazione del quotidiano. Lo stilismo lavorato dalla tecnologia vincente del prêt-à-porter poteva costituire il terreno d’incontro tra chi disegnava la moda e chi la fruiva, nella misura in cui fosse riuscito a far coincidere il progetto sartoriale con la costruzione narrativa del “personaggio”, dispositivo fictional capace di innescare la dimensione desiderante che sottende la relazione tra la persona, il look e l’ambiente. Le linee sartoriali furono così concepite per modellare un repertorio di pose e stili di vita grazie allo sviluppo articolato, coordinato e virtuoso dei distretti industriali e dei media della comunicazione, a cominciare dal potenziamento narrativo del figurino e della fotografia. La decisione di Albini di abbandonare Firenze e la storica e gloriosa Sala Bianca di Palazzo Pitti per presentare a Milano, presso il Circolo del Giardino, la collezione Autunno/Inverno1971-72 non solo costituì un atto trasgressivo, ma ufficializzò il suo metodo di progettazione che prevedeva di disegnare un’intera collezione in esclusiva per cinque aziende di moda, pronte a realizzarla nel loro rispettivo ambito produttivo, perfezionando un sistema industrialmente efficace e pronto a soddisfare le esigenze di un eterogeneo e crescente pubblico di consumatori.

Se la svolta di Albini ha certamente dato una risposta al diffuso sentimento di crisi che aveva investito la produzione di abbigliamento, da quello stesso terreno prendeva audacemente vita anche la moda-design di Nanni Strada. Cogliendo in parte le problematiche già espresse dai teorici del design, ma interpretandole e declinandole all’interno di un’originale sintassi creativa pronta a sfidare il mercato, la designer ha dato espressione a una cultura progettuale alternativa al contestuale emergente sistema dello stilismo. Rispetto alla formula albiniana, Strada ha decostruito radicalmente il paradigma del “personaggio” che teneva performativamente insieme l’abito e la persona. Con la realizzazione della collezione “Giù dal corpo” per il marchio Sportmax di Max Mara e della “Collezione Etnologica”, disegnate entrambe sempre per la stagione Autunno/Inverno 1971-72, Strada individuava una propria metodologia progettuale rigorosamente incentrata sull’identità dell’abito. A differenza degli stilisti, la designer non mirava dunque alla costruzione dell’immagine e del look, ma a valorizzare la biografia del capo operando un vero e proprio close-up sull’oggetto e non sul comportamento. L’abito “impersonale” di Strada è bidimensionale, sganciato dai punti di riferimento dogmatici della configurazione anatomica e dalle sue misure; è provvisto di allacciature regolabili e assemblato tramite soluzioni tecnologiche quale la cucitura a saldatura; è realizzato in tessuti e materiali ad alta performatività; è pensato per durare nel tempo e sfidare l’uso stagionale; aspira a un basso impatto ambientale. Istituendo una relazione non proiettiva tra l’indumento e la persona, la designer ha inteso creare delle strutture abitabili, non prescrittive ma funzionali all’uso creativo dei fruitori e alla loro personale elaborazione estetica.
Dal metaprogetto “Il Manto e La Pelle” (1973) (Premio Compasso d’oro 1979) – sistema di indumenti costituito da un abito a pelle, il primo al mondo progettato senza cuciture e realizzato con macchine circolari per calzetteria (Calza Bloch) e dall’abito mantello, tagliato in un unico pezzo di tessuto, senza scarti e assemblato con cuciture avveniristiche[18] – ai “Torchon” (1986), i primi abiti per viaggiare, stropicciati e comprimibili, incarnazione materica del nomadismo, ai modelli “Pli-Plà” (1993), modulari e flessibili che si aprono e si richiudono come ventagli, le creazioni di Nanni Strada sono dotate della resilienza necessaria ad affrontare le problematiche dei tempi di crisi: “Questi abiti-oggetto sembrano la risposta formale – ma anche emblematica – a una condizione di precarietà che permea gli eventi di questi anni”.[19]
Questa breve ricognizione storica ha inteso descrivere per grandi linee ideologie e progettualità che pur nella loro diversità si sono confrontate sulla complessità di rigenerare il paesaggio culturale vestimentario. Dello stilismo tocchiamo oggi, nella realtà effimera e quanto mai frenetica del fast fashion globale, l’eredità di un’energia creativa che, pur avendoci a lungo addestrati al potenziamento delle capacità performative, mal si concilia con l’attuale esaurimento delle risorse naturali, con il grave inquinamento ambientale e, last but not least, con lo sfruttamento sociale del lavoro a ogni latitudine. Alcune delle critiche mosse al sistema della moda dai gruppi radicali degli anni Settanta e il design di Strada possono costituire un campo esperienziale di riferimento quando ci si interroga sul ruolo della cultura materiale rispetto alle criticità ambientali. In occasione di un dibattito, aperto dalla rivista Domus nel 2009, sugli effetti prodotti dalla devastante crisi scoppiata nel 2008, il designer Clino Castelli ha dichiarato: “Purtroppo la creatività, quando diventa puro dato quantitativo, sembra raggiungere la sua massa critica nel momento preciso in cui il conformismo delle idee e l’univocità dei comportamenti vengono a coincidere. Questa simultaneità si ritrova spesso nel Lifestyle, condizione autoreferenziale fondata sull’appagamento immediato di tendenze istintive. Poiché proprio su queste forme di retorica comportamentale si fondano molte scelte del mondo della produzione e della comunicazione, suggerirei di guardare invece a quelli che avevo definito Living Model: modelli di vita in cui è implicito anche un progetto – non solo individuale – oltre che un modo di vivere aperto, partecipativo e responsabile”[20]. Emerge dal pensiero di Castelli la necessità di individuare un nuovo modello di civiltà materiale che innanzitutto dovrà mettere in discussione il formidabile ruolo che il valore emotivo[21] ha ormai da tempo assunto nell’economia del consumo.