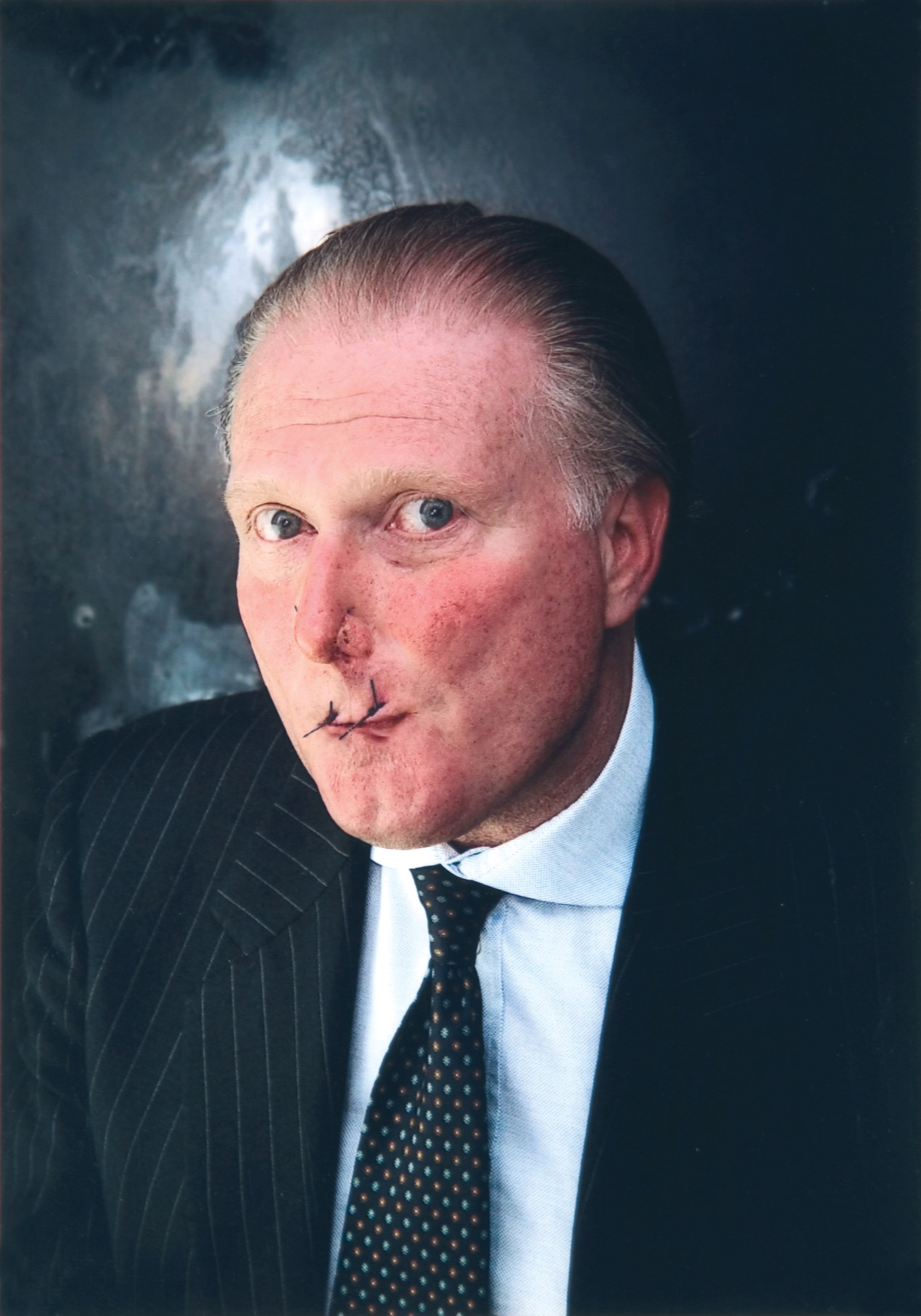Barbara Casavecchia: Vorrei partire da un tuo vecchio lavoro, un dittico di foto scattate in un parco giochi: da un lato c’è un buco, dall’altro una collinetta. S’intitolano Playground (Less) e Playground (More), con ovvio riferimento al motto di Mies van der Rohe. Racchiude molti temi della tua ricerca: l’interesse per il territorio “abitabile”, anche ludicamente, dello spazio pubblico, l’estetica modernista, l’attenzione per una fase critica in cui le utopie della modernità vengono messe in discussione. Un’epoca ben precisa, a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, che torni a scandagliare spesso. Insomma, ti fermi prima dell’affermazione del Postmoderno come esperanto globale. Perché?
Riccardo Previdi: Malgrado con gli anni siano emersi tutti i limiti del Modernismo e sempre più artisti lavorino sul suo fallimento, l’ipotesi di una sua totale messa in discussione per me resta difficile. Da ottimista, continuo a credere che un utilizzo più assennato delle risorse e un ripensamento dell’ambiente e degli oggetti che ci circondano potrebbero contribuire a un miglioramento della società. Ma il Modernismo mi piace di più quando cerca di quando trova, o diventa sistema (come con l’International Style, un vocabolario rigido di forme e materiali). Trovo interessanti quegli anni perché mi fanno pensare a un cantiere in cui molti soggetti diversi lavoravano alla costruzione di un’immagine possibile del futuro: cinema di fantascienza, moda, letteratura, arte e architettura. L’impatto dei gruppi radicali rimescolava nuovamente le carte, provava a ripartire con lo stesso piglio polemico di chi aveva fondato la scuola di Dessau!
BC: Radicale è un aggettivo che va molto di moda. E che sembra oggetto — almeno in termini formali — di un vero e proprio “recupero”. Cosa ne pensi?
RP: Per prima cosa, è un termine che va storicizzato. E che esprime più una voglia di non scendere (intellettualmente) a compromessi, che un’inclinazione all’estremismo. In Italia, sotto l’etichetta di “Radicals” hanno operato persone che provavano ad abbattere i confini tra arte, architettura e design, cercando di utilizzare queste tre discipline come uno strumento di riscatto sociale. Ettore Sottsass, Archizoom, Gianni Pettena sono stati e continuano a essere per me un riferimento costante. Con Gianni ho partecipato recentemente a una mostra curata da Guido Molinari alla Galleria neon>fdv di Milano. Il titolo di un suo vecchio lavoro, Applausi (1968), mi ha portato all’installazione I Have A Dream in cui ho manipolato la registrazione del famoso discorso di Martin Luther King al Lincoln Memorial di Washington (1963), cancellandone la voce e portando in primo piano le manifestazioni del pubblico. Il risultato è un file audio in loop, fatto di lunghe pause e applausi scroscianti.
BC: I tuoi “omaggi” sono sempre palesi, dichiarati, come Supercolosseo.
RP: Supercolosseo e Doubling The Size of Supercolosseo li ho pensati per una mostra nel quartiere Monti, a Roma, nel 2004. Consistevano nella sostituzione temporanea di uno dei cartelli d’ingresso alla stazione della metropolitana Colosseo. Un progetto di Superstudio immaginava un ampliamento e una riqualificazione funzionale del Circo Massimo, trattato come una fabbrica qualsiasi; a distanza di circa trent’anni ho immaginato che fosse stato realizzato, che la fermata del metrò ne portasse il nome, e che lo sviluppo industriale richiedesse un suo ulteriore ampliamento. È un gioco linguistico, ma è anche un invito a riconsiderare il valore che diamo ai monumenti, un modo per mettere in evidenza il feticismo che li avvolge.

BC: Non c’è anche un po’ di nostalgia per un ipotetico bel tempo che fu?
RP: No. La citazione, il prelievo — dovuti anche alla facilità con cui le fonti sono diventate reperibili. Per quanto mi riguarda, Internet 2.0 potrebbe essere la risposta, il copy-paste la pratica — funzionano da punto di partenza, forse da incidente/incontro. Per esempio, al cortometraggio del ’76 di Lelouche, C’était un rendez-vous, intorno al quale ho costruito la mia prima personale da Francesca Minini, sono arrivato grazie a un blog di appassionati di guida sportiva. Documenta racconta un attraversamento a gran velocità del centro di Parigi; un pilota misterioso (il regista? Jacky Ickx?) alla guida di una macchina sportiva (una Ferrari 375 GTB?) cerca di arrivare puntuale a un appuntamento galante. Censurato dopo la prima proiezione per il contenuto diseducativo, il film è rimasto visibile solo clandestinamente, grazie a gruppi di fan che hanno custodito copie della pellicola, caricandone l’intero contenuto sul web. E così la storia del cortometraggio mi interessa più del cortometraggio stesso.
BC: È una storia scaturita da una community, una comunità. Come ai Radicals (confluiti nell’esperimento di progettazione collettiva “Global Tools”), anche a te sembra piacere il lavoro di gruppo. Quando e come è nato SUPER!?
RP: Nel 2001, per “Tune/Up Clip/On Plug/In”, Massimiliano Buvoli, Patrick Tuttofuoco e io abbiamo collaborato alla realizzazione di Hardcore, una struttura per il tempo libero realizzata con materiali da cantiere e installata in un parcheggio pubblico di Scandicci. Ma è solo con Hardcore 2004, alla mostra “Z. A. T.” a Gallarate, che ci siamo presentati ufficialmente come gruppo. L’idea di lavorare collettivamente nasce dalla voglia di operare nello spazio pubblico come artisti, ma anche sfruttando i mezzi propri dell’architettura. Durante “Circular”, a Milano nel 2005, SUPER! ha illuminato l’improvvisata pista da ballo di alcuni breakers e un corridoio a fondo campo nello Stadio Meazza. Il nostro ultimo progetto, Hovercraft, presentato in aprile allo Spazio Lima di Milano, è un prototipo in scala 1:1 di un sistema modulare per la costruzione di pedane galleggianti.
BC: Costruire piattaforme mobili, soprattutto se servono ad accogliere interventi altrui, è un’altra delle tue abitudini.
RP: È vero, è un’idea che accomuna molti miei lavori: la serie di pedane fisse per concerti e azioni intitolata Palco (2002), così come la sua versione mobile, montata su un furgone, Volksbühne (che l’anno scorso ha accolto le performance di Luca Trevisani & BHF, Alex Cecchetti con Orlando, Kammerflimmer Kollektief), oppure le strutture Tatami, che hanno fatto da supporto alle immagini di Deborah Ligorio e Farid Rahimi. Poi c’è il Green Light Pavilion (2005), nato quando due giovani curatrici, Caroline Eggel e Christiane Rekade, mi hanno invitato a pensare uno spazio temporaneo in cui presentare la mostra “Sehnsüchtig Gleiten Ballone Rund um Die Welt”, in uno spazio di risulta tra due edifici in Mitte, il vecchio centro di Berlino. Ho progettato la struttura più semplice possibile — due container circondati da una costruzione lamellare di legno, illuminata da neon verdi — perché fosse pronta in meno di due mesi; ha funzionato per un anno, accogliendo 13 artisti, tra cui Tomas Saraceno, Knut Henrik Henriksen, Lara Schnitger, Monika Sosnowska.

BC: Vivi a Berlino dal 2001, negli ultimi due anni hai tenuto mostre a Karlsruhe e Londra, ma Milano resta una presenza ricorrente nel tuo bagaglio.
RP: A Milano ho studiato. All’Accademia di Brera e al Politecnico, arte e architettura. E quando ho deciso di andare a vivere a Berlino, l’ho fatto insieme a un gruppo di amici “milanesi”: Simone Berti, Stefania Galegati, Deborah Ligorio, Diego Perrone. Sono tante le cose della mia città che porto con me e che spesso riaffiorano: austerità, rigore, una certa pesantezza, ma anche gioco e leggerezza. Ci sono gli ikebana d’insalata e i gattini acrobatici di Bruno Munari, il cestino per la carta inclinato e la decostruzione della falce e martello di Enzo Mari, il cinema Arlecchino con le maioliche colorate di Lucio Fontana, il profilo del grattacielo Pirelli…
BC: Gli hai dedicato un lavoro, Tatami + Pirelli.
RP: Sì, che ho presentato proprio a Milano nel 2005 nella collettiva “Dojo”, a cura di Luca Cerizza. Proiettavo su una superficie filtrante (strisce di PVC adesivo applicate su una vetrina) la sequenza iniziale de La Notte di Michelangelo Antonioni, in cui la camera scorre verticalmente lungo la facciata dell’allora più alto grattacielo in cemento d’Europa. Una carrellata che rivela gli arredi moderni degli uffici, ma grazie al riflesso sui vetri, anche il paesaggio di una Milano cantiere, in cui il centro direzionale era ancora in costruzione. Come in quel film, anche nel mio lavoro s’innesca un gioco di riflessi e di sguardi filtranti.
BC: Forse potresti spiegare così anche il tuo ultimo progetto, per gli “Statements” di Basilea.
RP: Tutto nasce da Oversizing Aconà Biconbì (2005), un lavoro in cui giocavo a mescolare due linguaggi — da una parte il multiplo Aconà Biconbì di Bruno Munari, dall’altra le immagini futuristiche di Superstudio — per generare un’immagine che trasforma un oggetto di carta in una “superstruttura” fluttuante. Ho continuato a rielaborare quel multiplo, alterandone le dimensioni, utilizzando materiali diversi, realizzando installazioni luminose (AconA BiconB, 2005) e trasparenti (Made Air Visible, 2006), fino ad arrivare al progetto per Basilea, Walking Clouds: un ulteriore sovradimensionamento in cartone bicolore ultra economico, illuminato con tubi bianchi fluorescenti e installato all’interno di uno spazio specchiante, che serve a raddoppiare, ancora una volta, dimensioni e percezioni.