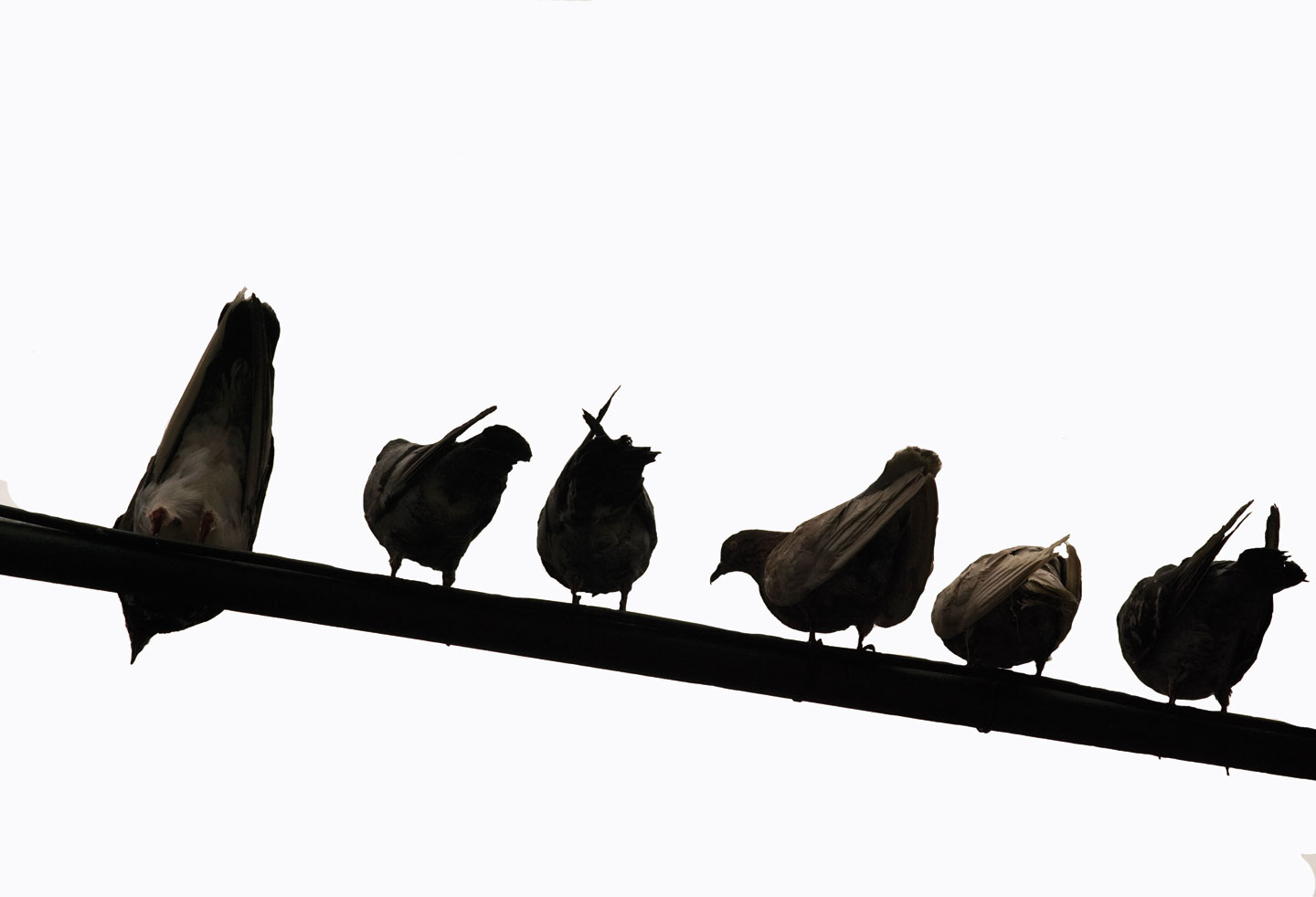Nel 2002, il teorico dei media Lev Manovich formulò un’ipotesi sorprendente: che i nuovi media, e non l’arte, fossero i veri eredi della rivoluzione iniziata dalle avanguardie. Secondo questa ipotesi, il progetto modernista troverebbe la sua attualità non nei capolavori del contemporaneo, ma nel mouse, nell’interfaccia grafica, nel World Wide Web, in Photoshop. Manovich non è un burlone né un provocatore, e sebbene molte sue tesi siano state prese fin troppo sul serio, questa — la più radicale — non ha mai avuto molto seguito nel dibattito culturale. C’è voluta la morte di Steve Jobs perché il termine “artista” si riaffacciasse alla ribalta per descrivere un creatore di media, nella retorica gonfia dei coccodrilli pronti da mesi e nelle esternazioni spontanee di milioni di fan. Anche solo per questo può valere la pena di tenere accesa la fiaccola del dibattito, prima che si affievolisca e che tutti tornino alla rassicurante certezza che l’arte sia solo ciò che vediamo nei musei e nelle gallerie.
In realtà, il rapporto di Steve Jobs con l’arte è così complesso e stratificato che lo stesso termine “artista” suona come una indebita semplificazione, accettabile solo, in una fase di beatificazione postuma, per l’aura di sacralità che questo termine porta, ancora e nonostante tutto, con sé.
In primo luogo, è la stessa biografia di Jobs a somigliare, fino a un certo punto, a quella di un artista. Nato nel 1955, viene dato in adozione dalla propria famiglia biologica. Problematico e volitivo, abbandona presto l’università, vivendo di espedienti e scegliendo di seguire per intero un unico corso, quello di calligrafia. Attratto dalle controculture giovanili dei primi anni Settanta, fa esperienza dell’LSD e compie, nel 1974, un viaggio spirituale in India. Nel 1976 fonda, con dei compagni di college, la Apple, che ha come base operativa il garage dei suoi genitori. Il suo primo progetto, l’Apple II, fa sensazione. La compagnia cresce, viene lanciata in Borsa, ma il suo capolavoro sarà prodotto, nel 1984, da un piccolo team guidato da Jobs che issa bandiera pirata. È il Macintosh, il primo personal computer a interfaccia grafica a larga diffusione. Insanely Great, e non era solo uno slogan pubblicitario.
I decenni successivi vedono Jobs impegnato nella difficile missione di diventare, come è stato detto, il più grande CEO del mondo: non il più ricco, ma il più carismatico, influente, osannato, controverso capitano d’industria del suo tempo. Esserlo, vestendo sempre blue jeans, e a volte a piedi nudi, o con la barba incolta, faceva parte del suo stile irresistibile, che si dispiegava appieno nei suoi interventi pubblici. Questa vicenda umana e professionale sembrerebbe aprire una cesura insormontabile tra il creativo hippie degli anni Settanta e il manager autoritario dei decenni successivi, ma non è così semplice. Non si tratta solo del fatto che nessun noioso capitalista sarebbe stato in grado di dare vita, come ha scritto Steven Levy, non a uno, non a due, ma a ben sei “game changing products”: dall’Apple II al Macintosh, dalla Pixar all’iPod, dall’iPhone all’iPad. Il fatto è che, in ciascuno di essi, c’è Steve Jobs. Ciascuno di essi è figlio dell’hippie appassionato di calligrafia, che si perde nell’LSD, legge il Whole Earth Catalogue e considera i suoi dipendenti artisti. Poco importa che Jobs non abbia inventato, né realizzato direttamente, nessuna di queste cose: che sia stato Steve Wozniak a costruire l’Apple II, George Lucas a fondare la Pixar, e che gli smart phone fossero già sul mercato quando è comparso l’iPhone: Jobs è stato in grado di permeare questi oggetti della sua personalità e del suo gusto, e di fargli realizzare i suoi sogni. La tipografia elegante del primo Mac è figlia di quel corso di calligrafia; iTunes e l’iPod, per sua stessa ammissione, delle sue visioni lisergiche.

Tutto ciò non prova che Steve Jobs fosse un artista, ma nemmeno lo smentisce. I più grandi artisti sono stati anche grandi imprenditori; nessuno di loro ha inventato ciò che li ha resi grandi: l’hanno rubato e rilanciato con una energia tale da far dimenticare il lavoro dei veri inventori. In fondo, quando dichiarava “non ci siamo mai vergognati, a rubare le grandi idee” Jobs citava, consapevolmente, Picasso.
Rimane però da sciogliere un nodo cruciale. Jobs non ha creato opere, ma strumenti, utilizzabili e utilizzati da altri artefici — artisti, musicisti, architetti, designer — per creare. Questo fatto lo lega in maniera indissolubile alla storia dell’arte occidentale, ma ne fa un artista? In fondo, perché rivendicare per lui quello che non è accaduto per Johannes Gutenberg, Louis Daguerre o i fratelli Lumiére? Perché farne per forza un nuovo Leonardo, invece di considerarlo semplicemente un grande inventore?

In realtà, quando cercava un modello, Jobs non pensava a loro, ma a Edwin H. Land, inventore della Polaroid. È un segnale che non dovremmo trascurare. La Polaroid non è una normale macchina fotografica. Come tutti i prodotti di Jobs, è un oggetto che ha creato la propria necessità; è un capolavoro di design; è uno stile di vita; ed è un mezzo che lascia sui suoi prodotti un’impronta indelebile. Più che un medium, è un’interfaccia; e un’interfaccia è più di un medium: non è soltanto, nella definizione di McLuhan, una protesi, l’estensione di una funzione o di un arto. È un artefatto progettato da uomini, che vi hanno immesso, nel bene e nel male, la propria visione: una visione che condiziona qualsiasi cosa venga prodotta con essa. Come una Polaroid, il prodotto di un’interfaccia porta il marchio indelebile della stessa, è il frutto della visione di chi l’ha progettata: Zaha Hadid, ma anche Steve Jobs; Takashi Murakami, ma anche Steve Jobs; Moby, ma anche Steve Jobs. Più che un artista, e più che un inventore, Steve Jobs — e con lui, tutti i grandi progettisti di interfacce — è un meta-artista. Per questo era così arrogante, e così serio, nel suo accanimento contro le compagnie che progettano tecnologia senza visione, senza cultura e senza idee: da meta-artista, e ammiratore degli artisti, sapeva quanto questi strumenti potessero condizionarne, in bene o in male, il lavoro.

Infine, a chiudere il cerchio, c’è il Jobs ossessionato dalle immagini, e innamorato della bellezza. Presentando, nel 1984, il Macintosh, proclama con sicurezza: “Tutte le immagini che vedrete saranno generate da ciò che sta in quella borsa”. Il coraggio con cui, licenziato dall’azienda che ha fondato, investe in un oscuro studio di computer graphics, facendone il principale responsabile di una rivoluzione nella storia del cinema di animazione, è frutto di questa immensa fiducia nella capacità del computer di generare immagini. La cura maniacale del dettaglio, l’ostinazione nel creare oggetti “belli” non solo nell’aspetto, ma anche nel modo di funzionare è frutto di un’etica progettuale che ha tenuto alta la fiaccola del design in un mondo che sembrava poterne fare tranquillamente a meno. Tecnologia straordinaria, semplicità d’uso, design mozzafiato, volontà di sposare la tecnologia alle arti liberali per “far cantare i nostri cuori”: sono queste le linee guida che si riverberano in ogni suo progetto, e che ne fanno non un semplice oggetto di buon design, ma un contributo indelebile alla cultura pop. “Business artist” come Warhol, generatore di icone pop come Lennon, Steve Jobs è decisamente più di un artista. Ma è solo, su questa strada? A questo livello di completezza, probabilmente sì. Eppure, forse il suo carismatico esempio può farci da guida nel riconoscere l’impatto decisivo sulla cultura contemporanea di altre figure e altri strumenti, che sono altrettante opere d’arte: Linux, Photoshop, Google, The Sims, 4chan, il Kindle e la Wii, solo per citarne alcuni. Forse, la sua morte indurrà finalmente qualcuno a credere che i criteri di valore e le categorie con cui affrontiamo la cultura contemporanea sono troppo vecchi, troppo rigidi, troppo ancorati nell’era industriale per servire ancora a qualcosa nell’età dell’informazione.

Intanto, quel che è certo è che qualcosa di brutto, Steve Jobs, l’ha generato: gli omaggi postumi degli “artisti”, che stanno spuntando come funghi in coda ai necrologi. Ragazzi, piantatela. Fate dell’arte “Insanely Great” con gli strumenti che vi ha regalato. È l’omaggio migliore che un artista possa rendere a quel meta-artista che è stato Steve Jobs.