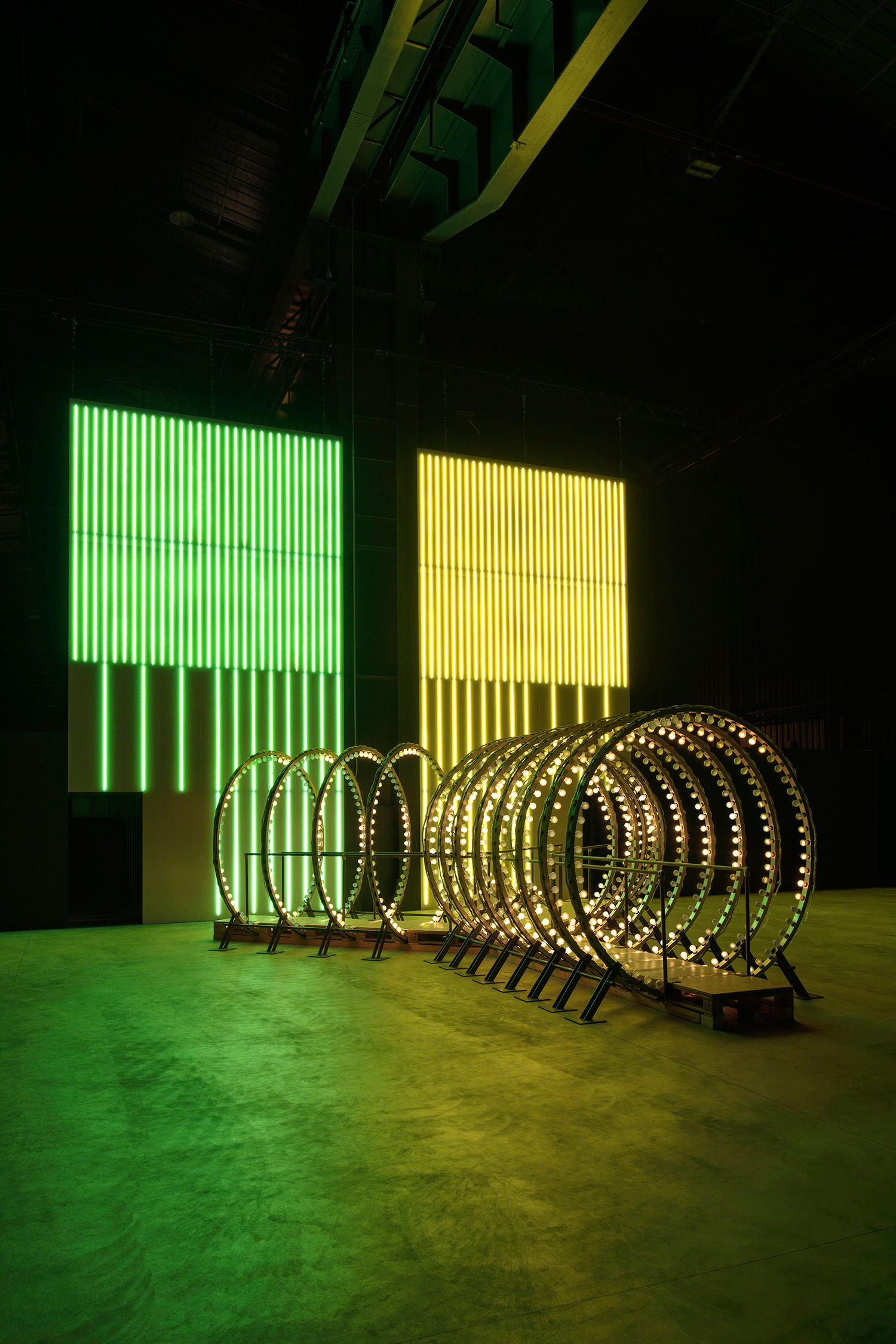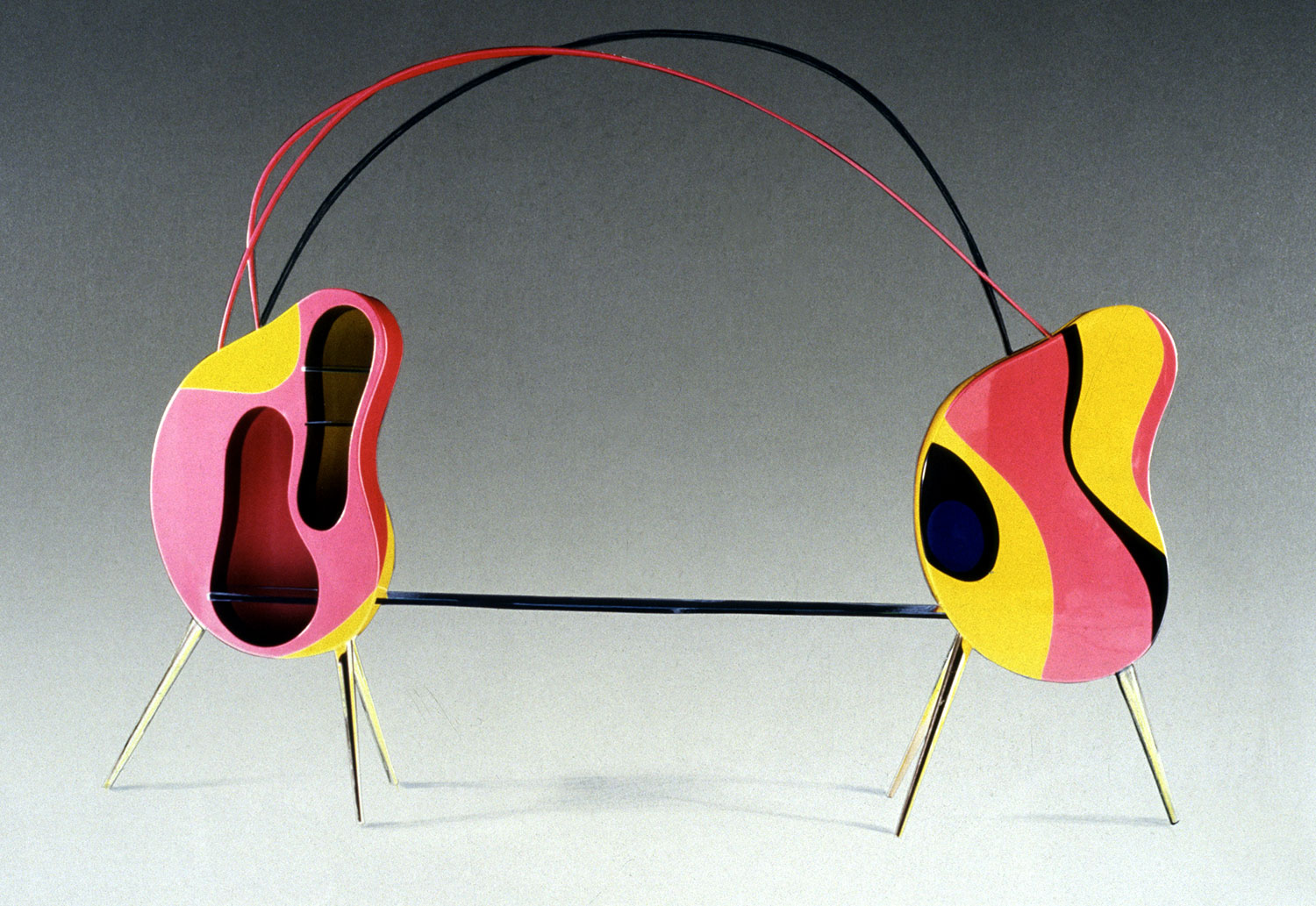Negli ultimi anni, numerosi scrittori hanno cercato di inglobare l’arte contemporanea nei dei loro romanzi — tra loro Michel Houellebecq, Jonathan Franzen ed Enrique Vila-Matas. Tuttavia, solo raramente queste descrizioni trascendono i cliché; e l’arte è in genere utilizzata come espediente per trasmettere un’ossessiva preoccupazione del sé dei personaggi (Anabel in Purity di Franzen) o come trovarobato di metafore per castigare il mondo moderno (come in La mappa e il territorio di Houellebecq). Di rado un romanzo affronta l’arte contemporanea guardando allo specifico delle vite delle persone coinvolte nel mondo dell’arte e al modo in cui l’arte, come disciplina, cerca di dare un senso al mondo.
Nel suo ultimo romanzo, Tiziano Scarpa (Venezia, 1963) fa proprio questo. Il brevetto del geco (Einaudi 2016) segue i percorsi convergenti di Federico Morpio, un artista visivo che, raggiunta la mezza età, inizia a interrogarsi sulle sue scelte e sulla sua carriera, e Adele Cassetti, una donna vicina ai trenta che conosce una conversione religiosa e finisce per fondare un movimento cattolico sovversivo. I due non hanno interagito quasi mai direttamente, ma sono entrambi votati a ricercare un senso in dettagli minimi e apparentemente insignificanti. Il loro desiderio – a tratti troppo serio, a tratti troppo speranzoso, sporadicamente assurdo – sembrerebbe essere un pelo fuori sincrono con la vita moderna, e questo è parte della sua forza. Le loro storie – quella di un artista contemporaneo e di una bizzarra missionaria auto-proclamatasi tale – sono entrambe storie di fede.
Ho parlato con Scarpa del suo romanzo e del modo in cui l’arte contemporanea viene rappresentata nella letteratura.
Vincenzo Latronico: Quando mi è arrivato il tuo libro, l’ho iniziato e letto con grande passione fino a circa la metà. Poi l’ho mollato con rabbia e frustrazione. Mi è sembrato pervaso da una sorta di scoramento circa il senso e le possibilità di fare letteratura di un certo tipo, oggi, in Italia. C’entra la figura di Morpio, in cui naturalmente, con qualche distorsione, da persona che scrive mi sono proiettato.
Tiziano Scarpa: Ehi, un attimo. Che c’entra Morpio con te? Federico Morpio è un artista visivo. Tu sei uno scrittore. Io invento personaggi che non sono miei portavoce, non rappresentano la mia situazione personale, tantomeno quella di scrittore. Cerco di traslocare negli altri, di immedesimarmi in qualcun altro che non sono io. Poi, te lo concedo, per entrare in loro uso degli ingressi; sfrutto le affinità che posso avere con loro. Per capire Morpio e le sue insicurezze, ho tenuto conto delle mie; per esempio: chi mi garantisce che quello che scrivo abbia valore?, avere qualche lettore ed essere tradotto all’estero cambia qualcosa?, aggiunge o toglie anche un solo milligrammo di qualità alle mie pagine? E provo anch’io frustrazioni e invidie e risentimenti simili a quelli che prova Morpio. Questo per quanto riguarda gli stati d’animo. Poi però c’è la professione, la situazione concreta. Io sono un autore, pubblico libri, il mio ambiente è diverso da quello di Morpio: l’editoria è proprio un altro mondo rispetto all’arte contemporanea.
VL: Ma c’entravano anche una serie di segnali nella prefazione, o nei commenti del personaggio chiamato l’Interrotto. Il fatto che a esprimere questo scoramento fossi tu – che lo facessi in un libro che mostra un controllo linguistico così profondo e uno sguardo tanto acuminato, una padronanza stilistica vertiginosa, mi sembrava renderlo doppiamente intollerabile. Come a dire: se è scoraggiato lui, io cosa devo dire?
TS: Forse avresti potuto ricordarti di quella pagina dello Zibaldone sulle opere di genio. Leopardi dice che le “opere di genio” – cioè i testi letterari, le opere d’arte fatte con le parole – anche quando esprimono disperazione e scoramento, alla fine consolano e accendono l’entusiasmo. Come mai? Perché uno le legge e pensa: “questo qui scrive che non c’è niente che valga la pena di fare, ma intanto si impegna tantissimo per scriverlo meglio che può: quindi qualcosa che valga la pena l’ha trovata! E quanto è vivace e stimolante il suo discorso, anche se parla solo di morte e resa!”
VL: Fra le cose che mi hanno più colpito nel romanzo c’è stata la tua capacità di raffigurare il “mondo dell’arte contemporanea” prendendolo al contempo in giro e sul serio: cioè vedendone tutti i tic, le meschinità, l’ossessione per il denaro, ma anche riconoscendone un anelito e dei moventi sovrapponibili a quelli della letteratura.
TS: L’arte contemporanea è la mia seconda passione. Ma il suo mondo non si può sovrapporre a quello della letteratura. Sì, va bene, artisti e scrittori si assomigliano: anche gli scrittori sono artisti; sono artisti delle parole. Ma il “mondo dell’arte contemporanea” e il “mondo della letteratura” sono due cose profondamente diverse. La letteratura ha a disposizione l’editoria, che offre agli artisti della parola un pubblico, mentre il mondo dell’arte offre agli artisti visivi soltanto dei mediatori. Sia chiaro, l’editoria non è il paradiso, è un sistema mercantile che raramente dà sostegno ai migliori. Ma il pubblico della letteratura ha voce in capitolo: ogni lettore investe personalmente soldi e tempo in un libro, molti lettori scrivono recensioni in rete, danno giudizi e voti; nel fare tutto questo, sentono che stanno contribuendo alle sorti di quel libro. Il pubblico dell’arte, invece, anche quando è numerosissimo non ha nessuna rilevanza, non conta nulla, si limita a subire le scelte dei mediatori. Anche se il pubblico dell’arte scrivesse giudizi e recensioni e si prodigasse nel passaparola, nessuno lo ascolterebbe, non cambierebbe di una virgola il destino di un’opera. Basta un collezionista potente, uno solo, e un curatore influente, e un gallerista, per decidere che un artista ha un peso.

VL: Scrivendo – da narratore, non da critico – di arte contemporanea mi ha sempre colpito molto la sordità e spesso anche il disprezzo che le viene rivolto dal “pubblico colto” in generale e specialmente dagli scrittori. Leggendo Vila-Matas sembra un’allegra ciarlataneria, leggendo Houellebecq sembra tutt’al più un trovarobato di metafore. Secondo te da cosa dipende questo rifiuto? C’entra il risentimento economico? O il tono spesso iniziatico, ostile, di gran parte del discorso intorno all’arte? Solo la matematica è stata espulsa in modo altrettanto netto dalla sfera della cultura ufficiale.
TS: Veramente il rifiuto l’ha fatto il mondo dell’arte, al quale non interessa nulla di ciò che pensa il pubblico, nemmeno quando lì in mezzo ci sono i migliori scrittori al mondo, si chiamino Villa-Matas o Houellebecq o in altro modo. E anche gli artisti hanno la loro parte di responsabilità; non hanno alcun rapporto con il pubblico, non lo tengono in nessun conto. E sarebbe un bene, questo, se significasse che hanno un rapporto esclusivo e assoluto con le loro opere, cioè senza subire nessun tipo di condizionamento da parte di nessuno, mai, tantomeno del pubblico. Il problema è che gli artisti ormai il pubblico l’hanno sostituito con curatori e galleristi e collezionisti… Il loro pubblico reale è quello. Sono concentrati esclusivamente sulla propria carriera, nel peggior senso del termine, e per certi versi sono costretti a farlo; debbono ottenere approvazione e sostegno da parte di qualche decina di persone che presidia i gangli nevralgici. Una delle cose più significative che ho letto in questi anni è stata l’autobiografia di Enzo Mari: “Perché devo convincere qualche ricco a scucire milioni per un mio dipinto?”, si è chiesto Mari da giovane, e ha deciso di fare il designer. Oppure ci sono i graffitisti, che sono usciti dal “mondo dell’arte” e sono andati nelle strade. Con risultati estetici, per i miei gusti, non sempre entusiasmanti. Ad ogni modo, confrontarsi con il pubblico non è semplice, bisogna essere disposti ad affrontare situazioni non protette. Guarda quello che è successo a Cosenza l’estate scorsa. Flavio Favelli, artista che ammiro tantissimo, ha dipinto un murale in memoria di un campione del calcio cittadino morto da poco. Favelli ha fatto una bellissima opera concettuale che ai tifosi locali è sembrata un’irrisione. Ha rischiato il linciaggio.
VL: Però nel tuo romanzo spesso si legge lo sforzo di spiegare i processi mentali di lettura di un’opera contemporanea, per sottolinearne la continuità con l’arte precedente e la legittimità.
TS: È anche per questo che il mio romanzo racconta la storia di un artista ridotto alla disperazione: perché pur avendo da offrire le cose che dici tu – processi mentali consapevoli e continuità con l’arte precedente – non trova legittimazione. E d’altronde l’arte contemporanea è così: è evidente che non c’è nessun, dico nessun motivo che giustifichi il successo di un artista rispetto a un altro. Ci sono solo opere e nomi che sono stati miracolati da circostanze fortuite. Nel complesso, agli artisti è stata tolta la possibilità di prendere l’iniziativa per legittimarsi da sé: in pochi decenni, da soggetti attivi di cultura si sono trasformati in puri oggetti passivi di mercato. In questo sono molto affini agli attori, che sperano che gli vada bene un provino: Mi voleva Strehler, era un monologo teatrale che ha avuto mille repliche in Italia, e secondo me con quel titolo coglieva bene il senso di passività degli attori, e, aggiungo io, degli artisti, di molte altre professioni e dell’intera nostra epoca, mostrando il metro di misura universale con cui si valutano le opere, le persone, le merci, il valore dei gesti: non il volere, il proporre, l’agire hanno valore, ma l’essere voluti, l’essere scelti, venduti, amati, desiderati, ricercati: Mi voleva Germano Celant. Mi voleva Bice Curiger. Mi voleva Charles Saatchi. Mi voleva François Pinault… Anziché: sono io che ho voluto fare questa mostra, o: ho allestito autonomamente il Pavillon du Réalisme; oppure: ci siamo chiamati Die Brücke e abbiamo esposto in una fabbrica di lampadari; oppure: abbiamo fondato il movimento per l’Arte Concreta, eccetera… Essere scelti da chi ha il potere di inserirti nel suo casting culturale: da questo dipende l’affermazione di un artista oggi. Perciò guardo con interesse a certe iniziative che cominciano a pullulare in Italia in questi anni in cui gli artisti si coalizzano e uniscono le forze.
VL: In un certo senso è qualcosa di simile a quello che fa Morpio.
TS: Sì, questo è un nodo della seconda parte del mio romanzo. Quando Federico Morpio accetta di partecipare a una mostra indipendente nei giorni dell’inaugurazione della Biennale di Venezia, fa qualcosa che assomiglia alle avanguardie, anche se in maniera un po’ caricaturale. L’avanguardia moltiplicava le forze dei singoli, spesso scavalcando i mediatori, i critici, i curatori… Finché non è diventata, negli anni ’50 e ’60, una procedura un po’ meccanica. Certo, continuava a essere un metodo collaudato che garantiva dei risultati: ti mettevi insieme a un po’ di colleghi, proclamavi che con voi cominciava un’epoca nuova dell’arte e dell’umanità, irrompendo sulla scena con un lancio autopromozionale che quasi sempre funzionava… Ma manifesti e proclami collettivi e nuove poetiche si succedevano a una velocità sempre maggiore, rendendo quasi parodistico il dispositivo-avanguardia. Perciò, più che di morte dell’arte, nel postmoderno si può veramente parlare di fine dell’avanguardia: questo è stato già detto tante volte, è ovvio; ma il punto che mi interessa far notare qui è che la morte dell’avanguardia ha prodotto artisti soli, senza potenza propositiva autonoma, in balia dei collezionisti, dei curatori, dei galleristi. L’apice sublime di questo paradosso è che all’Accademia studi il Novecento, secolo della massima intraprendenza, fierezza e autonomia degli artisti, ti formi sulle loro biografie, vieni incitato ad ammirare il loro esempio, per poi finire a sperare nella chiamata di un curatore.
VL: Ma questa differenza che vedi nel rapporto col pubblico di scrittori e artisti visivi, da cosa dipende? Mi viene il sospetto che abbia a che fare con l’idea di modernismo che ha generato quelle avanguardie. Se ci pensi, per quello che fa oggi un romanziere, la sperimentazione del primo Novecento è stata un’esperienza, se non sterile, almeno non seminale, non tanto forte da spazzare via tutto ciò che è venuto prima. Personalmente, sento di dovere a Balzac e a Boccaccio più di quanto non debba a, per dire, Marinetti; e penso che questo valga per quasi tutti i romanzieri di oggi.
TS: Be’, forse i romanzieri no, ma noi tutti, come cittadini, siamo debitori e vittime di Marinetti: quell’immenso potenziamento della parola si è dispiegato al di fuori della letteratura, nella propaganda mercantile, ideologica, mediatica. Ciò che ha fatto il Futurismo è paragonabile alla scoperta dell’energia atomica. Poi, applicando le formule futuriste, le bombe termonucleari le hanno fabbricate – e gettate – i pubblicitari.
VL: È vero: però forse in letteratura l’influenza è ben diversa dalla filiazione. Certi esiti (Finnegans Wake di James Joyce, Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo) sono riconosciuti universalmente come vertici ma non veramente seguiti.
TS: Le istanze del modernismo le ha accolte la poesia. Usando una metafora pittorica, potremmo dire che sì, è vero, i romanzieri sono rimasti sostanzialmente figurativi: ci sono ancora i personaggi, le storie… Forse anche per una causa materiale: la lingua è figurativa, è intrisa di antropologia, di metafore umane; molte lingue hanno addirittura desinenze sessuate… Non è come una scultura che può essere puro oggetto, archetipo non umano. Ma anche quando hai mostrato l’alienazione della lingua, e la destrutturazione del soggetto… be’, non per questo poi smetti di vivere e innamorarti e pagare le tasse! Insomma, il vecchio dispositivo figurativo del personaggio immerso in una storia continua a essere la nostra condizione. Comunque, Joyce e D’Arrigo, e Arno Schmidt e Robbe-Grillet e tutti gli altri sono essenziali. Prima di loro, i romanzieri pensavano di abitare una valle; dopo di loro è risultato chiaro che si trattava, da sempre, di un falsopiano sospeso su un abisso.

VL: Però è stato comunque un ritorno a forme tradizionali, seppur arricchite da una consapevolezza dell’abisso di cui parli. Nel caso delle arti visive invece si è andati avanti a inventarne di nuove, di forme, o forse ci si è fermati a quelle là: Duchamp, Dada, Fluxus – le esperienze di rottura drastica con il gusto dominante sono quelle che sono percepite come fondative delle pratiche di oggi. Penso che pochissimi artisti attivi in Italia sentirebbero di dovere più a Medardo Rosso che a Gino De Dominicis.
TS: Seguire la via di Duchamp e De Dominicis è diventato manieristico; ormai il pubblico è addestrato, e anche un po’ saturo e intorpidito. E poi, quella via induce pigrizia negli artisti: il pubblico non capisce nulla dell’opera, ma tanto poi a spiegargliela ci pensa il curatore – che giustamente si prende tutto il potere che gli deriva da questo ruolo di mediazione… Un po’ come, in letteratura, è successo alla poesia.
VL: Non è questo, in fondo, a determinare gli esiti che oggi trovi così lamentabili? La rottura con il grande pubblico non è stata proprio la caratteristica programmatica delle avanguardie che rimpiangi?
TS: Le avanguardie volevano costruire un pubblico, diverso, nuovo: la distruzione in sé non era probante. Erano utopiche. Può essere molto consolatorio scandalizzare, essere autistici, accontentarsi di rompere con il pubblico esistente. Creare un pubblico che non c’è ancora, questo sì che è difficile.
VL: Sì, ma intanto, per ottenere questo risultato, il modernismo ha dovuto abbattere il pubblico che c’era. Magari lo avrebbero fatto anche i romanzieri se le condizioni economiche della loro arte lo avessero permesso. Forse seguono Flaubert e non Robbe-Grillet perché le condizioni di produzione sono quelle che sono, e anche chi vorrebbe fare sperimentazione ha bisogno di un pubblico più vasto per campare.
TS: Non è che il romanziere scriva libri figurativi solo perché deve “campare”, come dici tu, ma perché il rapporto con il lettore, anzi, direi la sua presenza, è una parte essenziale dell’opera d’arte linguistica chiamata “romanzo”. Il romanzo propone al lettore una prestazione speciale delle parole, e cioè la loro capacità di suscitare immagini mentali, di fantasticare a partire da una pura sequenza verbale: è l’esperienza estetica fondamentale del romanzo. E non sempre viene compresa appieno a livello teorico, nemmeno dai critici letterari, che magari tendono ad apprezzare altre prestazioni delle parole: stile, scelte lessicali, ecc. Il modernismo, nel campo narrativo, ha mostrato che anche le parole sono cose. È stato una specie di ritorno alla retorica, al discorso come tecnica testuale, come capacità autonoma del linguaggio di significare. Una mossa antiromantica, se vuoi… Ma il romanzo incorpora il lettore perché lo convoca a fantasticare le figure suscitate dalle parole.
VL: E le opere d’arte no?
TS: L’opera d’arte visiva non ha nessuno intorno, anche quando c’è tanta gente. Lo capisci se consideri le nostre piazze, che sono involontarie installazioni di arte contemporanea: quel Garibaldi di bronzo non c’entra nulla con le auto e i cartelloni pubblicitari, è una presenza aliena. Forse la vertigine che l’arte contemporanea ci procura consiste nel renderci conto che l’opera è radicalmente aliena e ci ignora, non vuole avere alcun rapporto con noi, non può e non deve averlo. È questa l’unica relazione che possiamo sperare di avere con l’opera, ma bisogna avere la forza d’animo di reggerla.