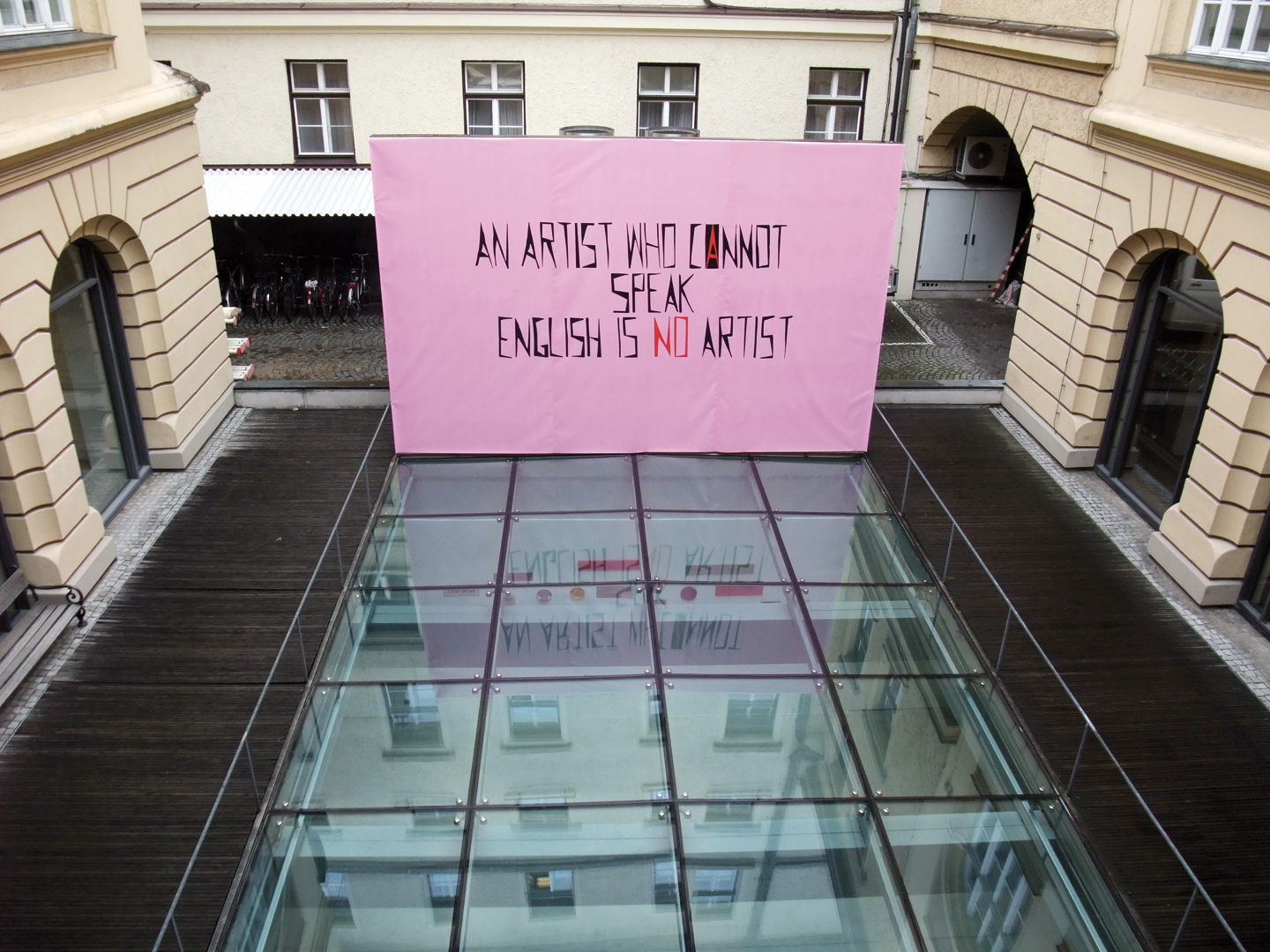Entrare nella galleria oscurata è come entrare nel buio di una sala cinematografica: in un abisso che ci toglie la forma e ci lascia in una dimensione onirica. Tale è l’universo che ci propone Tony Oursler con le sue “videosculture”, o meglio con le sue installazioni sulle quali e dentro le quali girano filmati in “loop”, sempre più complessi, articolati e perturbanti. Essi danno davvero la sensazione di proiezioni che sembrano farsi e disfarsi senza soluzione di continuità. Nel lavoro dal titolo Bitch Cycle le proiezioni sono addirittura due, tanto che le immagini non si fermano sulle superfici (muri in vetroresina, bottiglie dipinte, sfere di cristallo, oggetti trovati), ma scorrono anche sulle pareti e sul pavimento, come presenze fantasmatiche. Nell’altra grande installazione (Solipsistic Sync) le stesse ombre degli oggetti diventano supporto su cui si spostano figure luminose di vagabondi, danzatori, clown. È una festa risibile che si conclude (o inizia?) con uno sfavillare di fuochi d’artificio. Ma a contare non è certo la sequenza dei fatti, quanto la rottura dell’ordine, la sintesi degli scarti; non è neppure lo scenario spiazzante costituito da ultracorpi o da parole frammentate e sconnesse diffuse nello spazio, quanto il fare esperienza di un regno tecnologico che rimodella il nostro modo di essere e di percepire. Così tutto si trasforma in una sorta di teatro virtuale, in cui è possibile soddisfare l’antico desiderio di rendere palpabili le nostre fantasie e le nostre paure, fino a far saltare ogni frontiera tra il sinistro e il meraviglioso, l’ordinario e lo straordinario, la realtà e la finzione. Oursler, anzi, si spinge sempre più avanti nell’utilizzo di dispositivi altamente elaborati (lui stesso afferma:“Il video è già obsoleto: oggi è il digitale, il web, la piattaforma su cui tutti gli altri media si riversano”): ed ecco allora le microsculture di Variant o di Slithery Slope, fatte di un accrochage di materiali vari. Le piccole immagini (trasmesse da un sofisticato microproiettore led) si muovono all’interno come luci di un presepio artificiale, “accentuando il flusso e il riflusso tra tecnologia e umanità”. In questo modo l’artista rende visibile il meccanismo stesso del processo creativo, sonda i trucchi e le mistificazioni con cui le comunicazioni multimediali invadono il nostro inconscio.
In mostra non manca neppure una di quelle sfere (già presenti anche lo scorso anno al Pac) in cui è proiettato un occhio con tanto di pupille che si dilatano e di palpebre che sbattono: esso sembra che interpelli lo spettatore, in realtà sta osservando dei canali televisivi (che vengono registrati dalla retina). Come non manca il primo piano di un volto (Xes, del 2005), che biascica frasi ossessive ed è scosso da un trauma psichico sconosciuto. A importare è certo la sparizione del corpo, quella sua partizione che gli dà un senso muto, chiuso, autistico, ma anche la scultura che si trasforma in qualcosa di immateriale, la forma solida che diventa mobile, inafferrabile. Oursler, in un’intervista, ha detto di essersi ispirato ai primi film, soprattutto a Méliès e ai suoi grandi e bizzarri viaggi visivi: anche il lavoro dell’artista americano non è mai fissato a rendere il “doppio” magico della vita, ma a visualizzare una vita che si spezza nei particolari, una vita “fuori quadro”, una “second life” o, come scrive Danilo Eccher, la “costituzione di mondi paralleli”.