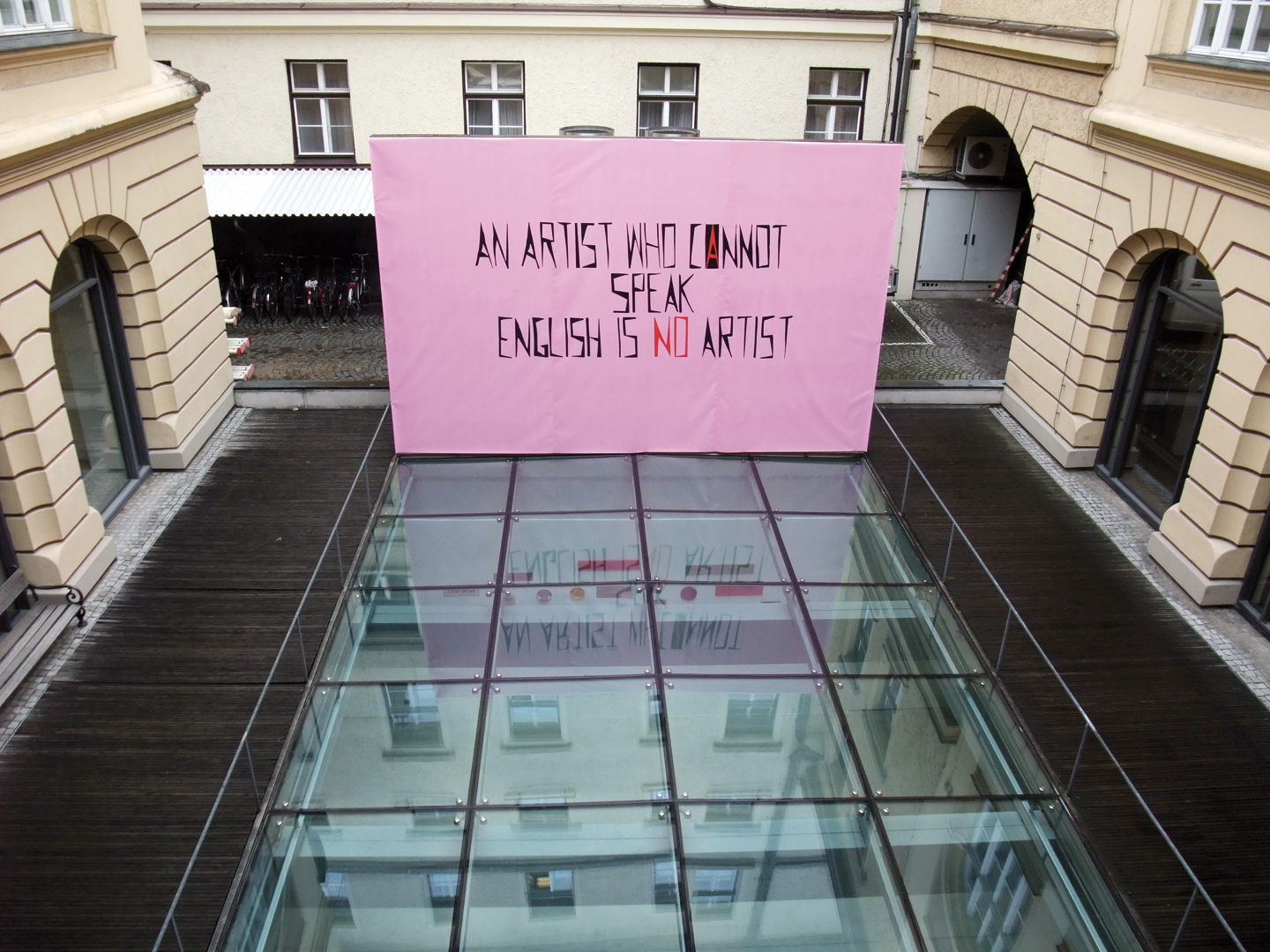Giancarlo politi: Quando hai cominciato a mostrare i tuoi lavori in pubblico, ufficialmente?
Wolf Vostell: La mia prima azione, dé-coll/age-action, che si svolgeva nelle strade di Parigi, risale al 1958. Nel 1961 ho esposto alla galleria “Soleil dans la tête” di Parigi in cui c’era anche Christo. La mia prima mostra in assoluto si tenne comunque un paio di mesi prima, prima del Nuovo Realismo.
GP: Vivevi a Parigi in quel periodo?
WV: Ho vissuto a Parigi dal 1954 al 1958 con alcune interruzioni.
GP: Quali sono stati i tuoi primi contatti a Parigi?
WV: A quei tempi non si parlava molto di Avanguardia. Il tachisme imperava. Io studiavo all’École des Beaux Arts e cercavo di guadagnarmi da vivere, ad esempio nello studio del disegnatore Cassandre. È stato in quel periodo che ho cominciato a interessarmi agli avvenimenti del nostro tempo: incidenti d’aereo, d’auto, guerre… Fin dal 1954 era chiaro per me che il dé-coll/age era un processo, non un’opera statica. Una cosa che mi ha molto influenzato è stata la retrospettiva Dada a Düsseldorf nel 1958. Io credo che sia sbagliato parlare di un’influenza dadaista solo in America come affermava la critica degli anni Sessanta. La storia di Dada mi ha insegnato molto sui fotomontaggi, sull’idea di environment nei Merz di Schwitters, ho visto la bicicletta di Duchamp e altre cose. I due momenti essenziali, nella mia storia degli anni Cinquanta, sono Dada con la sua volontà di non sfuggire la realtà — cosa che nessun altro faceva allora — e il dé-coll/age con la sua attenzione ai fenomeni violenti e distruttivi.
GP: Avevi già una coscienza politica?
WV: No, ho cominciato a formarmela tra il 1958 e il 1961 quando ho smesso di lacerare manifesti perché mi sono accorto che i fenomeni del nostro tempo non si riflettono sui manifesti, ma sui giornali e sulle riviste. Tornando dalla Spagna, sposato, provai a tornare a vivere a Parigi, ma Colonia con i suoi interessanti ambienti radiofonici mi attirava di più. Non vivevo ancora con il mio lavoro di artista e quindi nel 1961 entrai in una rivista di Colonia di cui curavo l’impaginazione. Il direttore era un pacifista e l’archivio della rivista, aggiornato in particolare per i crimini del XX secolo, forniva una documentazione dettagliata sulla violenza della nostra epoca. Mi passavano tra le mani ogni giorno 300/400 foto tra cui dovevo scegliere quelle da pubblicare: è stato un importante tirocinio. Qui, per la prima volta, ho visto le foto di Hiroshima: da quel momento ho deciso di abbandonare i manifesti e di interessarmi ai reportage. Durante quell’anno ho cominciato a fare le cancellature servendomi di liquidi. Ho iniziato con una doppia pagina della rivista che impaginavo. Successivamente ho cancellato un reportage su Paris Match per cui stavo curando alcune impaginazioni. In quel momento, a Colonia dominava la “Fotochina”, ma erano già iniziati gli esperimenti su tela emulsionata. Sono stato uno dei primi a servirmene: ho ingrandito il reportage sulla tela e ho operato le cancellature su questa. Le immagini fotografiche mi hanno sempre affascinato: desideravo tradurle in azione riproduncendone visivamente la violenza e la distruttività. Ho cominciato con il disastro aereo di Parigi.
GP: Hai detto di aver fatto un dé-coll/age a Parigi in seguito a un disastro aereo?
WV: Ho letto per la prima volta la parola “dé-coll/age” sulla prima pagina del Figaro del settembre 1954. Diceva pressapoco: “peu après son décollage un avion superconstellation tombe et s’engloutit dans la rivière…”. Che un aereo si alzasse e nello stesso tempo cadesse era per me una contraddizione dialettica: non conoscevo la parola. In un dizionario ho trovato la spiegazione: décollage significava strappare cose incollate e anche morire. Per me significò impadronirmi del processo distruttivo della vita, me ne sono servito fino al 1962.
GP: Tra i dé-coll/ages e l’azione diretta c’è sempre stato un legame a mio parere, cioè la nozione di violenza e anche di morte. Hai interpretato letteralmente la definizione del dizionario.
WV: Più tardi, in occasione di una mostra, ho fatto un manifesto che specificava il significato di dé-coll/age: è accidente, morte, lotta, vita, cambiamento, riduzione, problema, disturbi, merda, febbre, traspirazione, aborto, esclusione… principi psicologici… la sovrapposizione di visibile e invisibile… dolore, diarrea, pattumiera, il tuo essere strappato.
GP: Si tratta di un manifesto poetico?
WV: Sì, ma riconoscevo come arte anche processi che non erano ritenuti tali. Erano happening, se vuoi.
GP: Quando dicevo manifesto poetico, intendevo anche politico, ideologico. Sei sempre d’accordo?
WV: Sì, perché il mio lavoro si ispira alla vita e questa esiste ancora pur mutandosi nella sua complessità. I due grandi temi del XX secolo sono l’idea di distruzione e di sesso. Anche nella mia vita privata sono sempre combattuto tra violenza e amore: questa lotta si riflette nel mio lavoro. Posso tranquillamente riconoscere di avere una grande paura, per liberarmene la riverso nei miei lavori.
GP: Quando sei venuto a conoscenza per la prima volta del lavoro di Allan Kaprow?
WV: Nel 1962 a Wiesbaden durante un concerto Fluxus. Ho conosciuto Dick Higgins che era là per una performance di un mese: mi ha detto che Krapow faceva cose simili alle mie e che avremmo dovuto conoscerci.

GP: Non avevi mai sentito parlare di lui prima?
WV: No. Ho scritto subito a Kaprow inviandogli un pezzo con un testo dal titolo Mondolocog. Era un happening esterno in nove luoghi diversi progettato per Parigi e mai realizzato per difficoltà economiche. Kaprow mi ha risposto inviandomi un suo lavoro, poi siamo diventati amici. Nel 1963 mi ha invitato a New York in occasione del Festival dell’Avanguardia per cui aveva organizzato la sezione happening. Ho avuto così la possibilità di esporre per la prima volta a New York alla Smolin Gallery alcune cancellature, i primi schermi deformati e di realizzare il mio primo environment con sei televisori deformati. E in seguito un happening con un’azione televisiva. Ho parlato molto con Allan e mi sono trovato d’accordo con lui teoricamente sulla non ripetibilità dell’happening. In ciò ci differenziavamo da Fluxus, Ben ad esempio ancora oggi continua a riproporre più volte uno stesso lavoro. È stato allora che ho deciso di definire i dé-coll/ages, che prima chiamavo “events”, happenings, per inserirmi in un movimento internazionale sulla base della sua unicità e del fatto che si svolgeva fuori da musei e gallerie. Erano cose cui comunque ero già arrivato prima di conoscere Kaprow.
GP: Quale è per te la differenza fra il tuo lavoro e quello di Kaprow?
WV: Kaprow, come Oldenburg e Jim Dine, ha fatto i suoi primi happening in una galleria. Il primo, nel 1959, era ambientale. Io invece volevo continuare l’idea Dada di fare azioni nella realtà. Fin dall’inizio ho lavorato nelle strade, appropriandomi della vita che vi trovavo. C’è una grande differenza tra Duchamp e me: egli ha dimenticato di dichiarare che orinare è un’opera d’arte. Se il cesso è un’opera d’arte, perché orinare, no? La differenza tra me e Kaprow è che la sostanza dei miei happening è la vita. L’atto dell’orinare, la violenza connessa alla nostra società, mentre lui ha iniziato con fatti più individuali e intimi. È importante che sia stato come La Monte Young, allievo di John Cage, che ha sempre lavorato solo in teatro. Ho conosicuto Cage nel 1960 a Colonia e mi è molto piaciuto. Ha influenzato moltissimo tutto Fluxus, il mio lavoro invece si ispira ai futuristi italiani, a Russolo, alle macchine musicali, alla tradizione russa, ai fotomontaggi di derivazione dadaista, a Schwitters, ai Dada berlinesi che fecero azioni politiche come fingere di fucilarsi nel parlamento di Weimar e tutti credevano fosse vero… lavorare suscitando risentimento, ansia e rabbia.
GP: Mi sembra, per puntualizzare, che Kaprow sia un po’ l’espressione dell’ottimismo americano e tu quella dell’ossessione europea. Non si tratta solo di una differenza di luogo. Anche Kaprow ha poi fatto happening all’esterno. È piuttosto una differenza di contenuto: mi sembra che gli happening di Kaprow siano meno drammatici.
WV: Posso cambiare la parola drammatico in tragico? Io sono europeo, sono circondato dalla tristezza e i problemi tragici, li esprimo con la violenza anche se personalmente sono un pacifista, ma la violenza è un carattere documentario del mio lavoro e una delle angolazioni della mia visione oggettiva del mondo. Tutti i migliori artisti europei tendono a conferire all’“inferiorità” tragica un carattere qualitativo sia che si tratti di oggetti (Arte Povera) sia che si tratti di esseri viventi. In generale questa è anche la grande differenza tra Europa e America. Kaprow non è “tragico”, è molto più ottimista e logico, non cerca un lavoro dialettico. Per me se il contenuto è violenza e distruttività, la forma è analogia dialettica. Ecco un’altra differenza: nei giovani artisti americani è assente la ricerca dell’analogia e del rapporto tra la loro opera e la vita. Molti artisti europei sono invece idealisti; si può considerare ciò negativo, ma è comunque interessante. Io faccio tantissime cose perché sono convinto che l’arte oggi è una lotta per la vita, contro la vita, sulla vita, con la vita. Sono un entusiasta della vita, ma non rinuncio al dubbio.
GP: C’è però in Kaprow una nozione che a te manca: il divertissement. I partecipanti ai suoi happening si divertono. Nei tuoi si esige una partecipazione più reale, tragica e complessa. Quali sono, secondo te, le analogie e le differenze con Fluxus?
WV: Bisogna partire dal laboratorio di musica elettronica di Stockhausen, Cage e Michael Koenig, a Colonia. Il primo concerto di Cage in Europa, a Colonia — credo nel 1960 — ha influenzato molto le nuove generazioni. C’era anche però chi voleva una musica naturale accompagnata da azioni del corpo. Ho sentito parlare di musica-azione da Nam June Paik che, come me, era rimasto impressionato dalla retrospettiva Dada di Düsseldorf, che in questa stessa città, alla Galerie 22, aveva già fatto delle azioni-musica e le cui composizioni venivano trasmesse alla radio insieme a quelle di Peterson e La Monte Young. Paik era in contatto epistolare con La Monte Young e Maciunas che arrivò nel 1962. Non ci conosceva, ma iniziammo subito a collaborare. Aveva in progetto un grande festival di musica-azioni in Germania. Era di larghe vedute se ad esempio tieni presente che a Wiesbaden c’era anche Stockhausen che era un nostro nemico. Fluxus ha dichiarato musica tutto ciò che è sonoro, anche il respiro, anche la tosse. Questo è stato il grande scandalo in quella piccola città tedesca, conservatrice: la provocazione di una musica non strumentale. Comunque era per me già chiaro che la struttura Fluxus non avrebbe potuto accogliere i miei happenig, più rivoluzionari, più violenti, nelle strade. Dopo i tre concerti del 1962 a Wiesbaden, Copenhagen, Parigi e dopo la parentesi americana con Kaprow, volevo tornare ai miei happening.
GP: Ma perché parli di struttura? Pensi che esista una struttura in Fluxus?
WV: A Wiesbaden non esistevano delle regole, sarebbe stato contrario a Fluxus. Ma esisteva una struttura dominante determinata dal desiderio di Maciunas di creare un’organizzazione e un’organizzazione non estetica, anzi una struttura molto forte di impronta manageriale. Una sera Paik chiese di avere una serata tutta per sé e Maciunas sostenne che era impossibile perché a una serata Fluxus dovevano partecipare molti compositori. Inoltre era prevista la ripetizione dei pezzi in ogni città. Più o meno come per il teatro, abbiamo ripetuto gli stessi pezzi a Copenhagen e a Parigi.
GP: A quel tempo facevi pezzi Fluxus?
WV: Miei.
GP: Sì, ma nel contesto Fluxus?
WV: Sì. Erano dei pezzi acustici.
GP: Quanto tempo è durata la tua partecipazione a Fluxus? Un anno e mezzo?
WV: Gli anni migliori di Fluxus sono stati il 1962/63. Ben non fu conosciuto fino al 1963.
GP: Fluxus ha influenzato in qualche modo i tuoi happening?
WV: No. La positività di Fluxus è stata la possibilità di incontrarsi e stare insieme. Gli artisti individualmente esistevano prima e sono esistiti dopo, ma per pochi anni hanno condiviso gli stessi ideali anche se non le stesse opinioni. Esistevano divergenze enormi. Per esempio io amavo e amo tuttora Maciunas per la sua profonda conoscenza della Russia e dell’arte rivoluzionaria, amo il suo idealismo che tende a trasformare l’arte in vita. Ero d’accordo con lui che il suo umano era più importante di qualsiasi pezzo accademico e strumentale. Philip Corner invece, per mostrare il principio della distruzione, disfaceva lentamente, per tre ore, un pianoforte. Tali divergenze non sono ancora state bene analizzate.
GP: Pensi che ci fosse alla base un’ideologia politica?
WV: Per me e Maciunas sì. Ma per esempio Ben non conosce la storia della Rivoluzione russa, il manifesto di Ben non comprende il bisogno di un impegno sociale. Non esiste in lui una tragicità, forse perché viene da un paese europeo molto bello. Il problema non è solo Europa-America. Klein e Arman ad esempio utilizzano degli oggetti, ma senza darne il contesto, non vogliono dare il contesto, forse dipende dal loro carattere individuale. Questa è anche la differenza tra alcuni individualisti europei e il Nuovo Realismo. In Fluxus, nel 1962, esistevano almeno tre artisti interessati a dare un contesto sociale ai propri lavori: Maciunas, Higgins e io. In quell’anno non conoscevamo ancora Beuys, altrimenti lo avrei presentato nella mia rivista dé-coll/age che ho pubblicato alcuni mesi prima di Fluxus. Beuys ha partecipato a Fluxus solo nel 1963 e ne rimase influenzato tanto da voler rimanere in contatto. Ricordo che nella sua mostra a Vander Grinten ha cambiato il titolo di alcuni suoi pezzi degli anni Cinquanta con quello di Fluxus. Credo che sia importante definire se Fluxus è un modo di vivere, una filosofia socio-estetica o un’agenzia organizzata di concerti. Io credo sia un po’ tutto.
GP: Cosa pensi del gruppo degli “actionists”? Ci sono delle affinità con gli happenig o no?
WV: Mi sono trovato daccordo con Kaprow nel pensare che non abbiano niente a che fare con noi, anche se hanno sempre cercato un legame. Non lavorano con l’iconografia e i grandi eventi del XX secolo sono più vicini all’azione surrealista… il pranzo surrealista di Dalì con donne nude e cibi… ripetono le loro azioni.
GP: Anche voi ripetete delle azioni: fate un happenig in Germania, poi a Milano.
WV: No, no, ognuno è diverso, anche il principio è diverso.
GP: Sei contro anche la ripetizione in uno stesso luogo?
WV: Sì e non solo, anche il principio deve cambiare. Nitsch ha ripetuto alcune azioni 20/30 volte, per per di più hanno affinità con rituali religiosi non certo attuali o perlomeno tali solo nei dettagli.
GP: Ritieni di giocare un ruolo politico nell’arte? O meglio, fai politica con il tuo lavoro?
WV: No.

GP: Pensi comunque che il tuo lavoro possa contribuire alla politicizzazione della gente?
WV: Certamente. Forse ricordi che la Germania è stata un paese tranquillo fino al 1966, poi è iniziata la contestazione. Io però non ho mai discusso con dei militanti politici, loro verbalizzano mentre io mi occupo degli strumenti estetici per realizzare happenig provocatori, liberatori.
GP: Quanti happenig hai fatto?
WV: In vent’anni circa 80, ma nello spirito giusto direi 50.
GP: Quanto dura la preparazione di un happenig?
WV: Un anno circa, ma posso studiarne molti insieme. La mia vita privata è tutta tesa a questa ricerca di materiali documentari, di informazioni: io sono dove lavoro.
GP: Quando fai un happening all’estero cerchi di registare fedelmente la situazione dimenticando le tue opinioni o no?
WV: Naturalmente non posso cambiare il mio carettere né dimenticarmi, ma non ho pregiudizi e tento di far emergere la situazione locale.
GP: Per “Contemporanea” a Roma nel 1974, ad esempio, ti sei documentato sui problemi, sulla mentalità dei romani o ti sei servito solo delle tue opinioni?
WV: Conosco molto bene l’Italia per esperienza diretta. Per l’environment di Roma ho avuto per la prima volta l’idea di paragonare varie forme di energia. La miseria italiana non è economica, è povertà di energia. Non se ne riconosce l’importanza.
GP: Che cos’è per te l’energia? Ha un riferimento mistico o una definizione scientifica?
WV: Entrambe le cose naturalmente. Ho notato che in Italia si spreca molta energia perdendo tempo. Può darsi che non sia così, ma ho l’impressione che la gente non riesca a trasformare il tempo perduto in tempo creativo. In questo lavoro esiste anche un confronto di idee, per esempio per molte persone un pezzo di pane è la Cadillac della vita.
GP: Ti succede di improvvisare un happening o quasi mai? Si sono verificati cambiamenti improvvisi?
WV: Ci sono stati molto cambiamenti perché nella vita ci sono molti cambiamenti. Io accetto quel caso che è escluso dalle forme artistiche convenzionali come il teatro, il cinema, l’opera. Naturalmente c’è un’idea da seguire, è un gioco, un gioco non competitivo. Non è importante, come nel teatro, se le luci non funzionano bene, se un attore recita male. La gente gioca e deve accettare il caso, la vita stessa non è mai perfetta e quindi anche l’happening non può mai essere perfetto. Ciò che mi interessa è provocare un attimo di irritazione, meglio se sono due, un attimo che riesca a influenzare il carattere.

GP: I tuoi happening sono più utili a te o agli altri? Terapeuticamente intendo.
WV: Se devo dire la verità, sono utili soprattutto a me. Ma non faccio degli happening per darmi ragione perché ormai mi conoscono. Credo che siano vere ambedue le cose: io imparo ma anche il pubblico che può vedervi un modello esistenziale esplicativo. Comunque determinante è la comprensione della mia posizione psicologica.
GP: Quando prepari o fai un happening ti diverti?
WV: È molto difficile, è un lavoro enorme. Per questo faccio al massimo tre happening all’anno accompagnati da una pubblicazione documentaria. Talvolta, durante lo svolgimento, mi è stato chiesto di parlare, ma l’ho sempre fatto di malavoglia, la provocazione non esige una spiegazione.
GP: Pensi che l’arte possa essere anche un mezzo di conoscenza?
WV: Certo, di conoscenza estetica.
GP: Non intendevo questo. Volevo dire come la scienza, un mezzo di informazione.
WV: Sì, una cosa dopo l’altra. Bisogna abituarsi all’idea che esistono alcuni artisti con grandi problemi di breve durata. Coesistono e continueranno a farlo: è molto democratico che sia così!