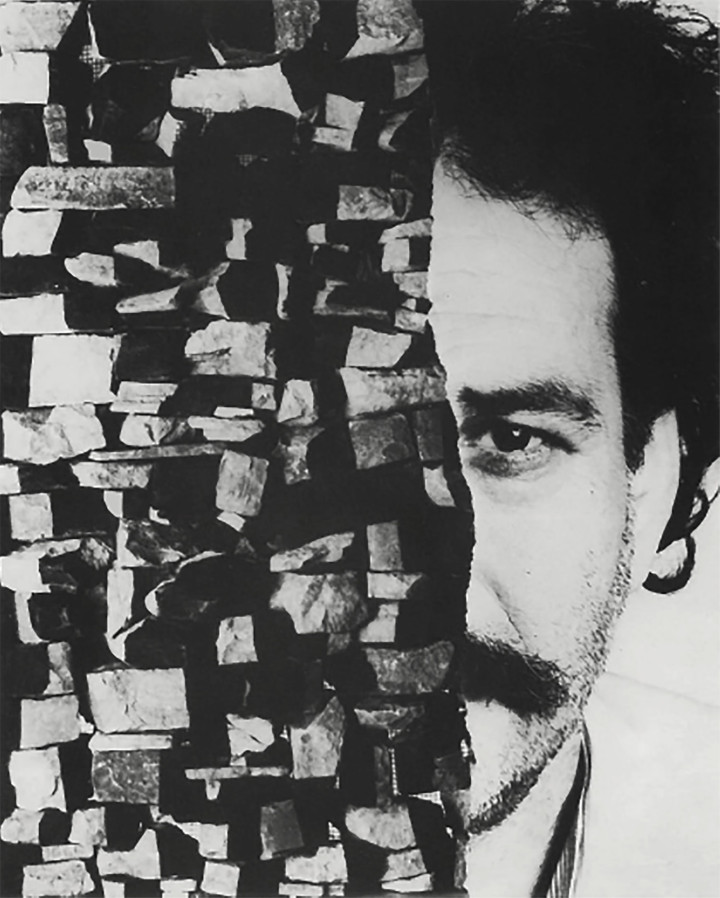Da Flash Art no. 124 Gennaio 1985.
“L’importante nel fare arte è che il bersaglio sia limpido. Per un’opera d’arte esistere significa nascere da una visione storica e appartenervi, nascere per una necessità linguistica reale”.
Giancarlo Politi: Dici di non essere d’accordo sull’interpretazione letteraria che dà in genere la critica sul lavoro di un artista.
Jannis Kounellis: C’è una distinzione da fare. Perché si parla? Si parla se si intravede una possibilità. Un anno fa era una cosa molto lontana mentre adesso è chiarissimo che si vedono i contorni di una situazione che rinasce dappertutto, ci sono dei sintomi molto significativi.
G.P.: Ma tu vedi intorno a te, nel mondo, i sintomi di una rinascita artistica o di una rinascita del modo di fare arte?
J.K.: Le due rinascite si equivalgono: la maniera, la proposta, il modo, la forma, l’idea della forma, è questo che sta rinascendo. È che un certo tipo di improvvisazione formale, con tutti i suoi contorni mercantili, viene ad essere diminuita come forma dominante mentre aumenta la necessità di trovare delle forme credibili nate questa volta da un dibattito strettamente artistico.
G.P.: Gli anni ‘70 erano caratterizzati da un certo modo di fare arte e da un tipo di moralità; oggi quella moralità, o amoralità è cambiata secondo te?
J.K.: No, io penso che sta tornando alla sua versione degli anni 60 perché quegli anni erano legati alla tradizione moderna.
Helena Kontova: Ti riferisci all’Italia o è così ovunque?
J.K.: Ovunque, non soltanto in Italia.
G.P.: Tu che sei stato uno dei maggiori protagonisti europei per un certo tipo di lavoro, come ti senti oggi con questa apoteosi, questa attenzione?
J.K.: Mi sento un protagonista dell’opposizione!
G.P.: Ma come ti senti nella tua pelle di artista in questo momento? Ti senti a disagio in questo momento creativo in cui, diciamo, la media della produzione, della pittura, non è vicina al tuo tipo di lavoro e di ricerca?
J.K.: Anzi è decisamente contrastante, questo lo voglio sottolineare. E penso, anche per paradosso, che quell’operazione ci ha delineato a livello storico e ci ha dato peso morale.
G.P.: Ma ti ha dato anche una maggiore carica?
J.K.: Certo, perché l’importante nel fare arte è che il bersaglio sia limpido.
G.P.: Ti senti più isolato di quanto ti sentivi agli inizi?
J.K.: No, non mi sento isolato e non lo sono. In quella mia visione ho degli amici.
G.P.: Ma ora che è in voga la pittura?
J.K.: Non sono contrario alla pittura, sono contrario a un certo tipo di pittura, non alla pittura per se stessa. Mi considero un pittore. Quello della pittura non è un problema reale così come lo hanno impostato: Les Demoiselles d’Avignon è un grande quadro. Il problema è quando si parla del ritorno della fantasia e cose del genere, mi fanno veramente ridere. E detto poi da noi in Italia è abbastanza umiliante, perché riporta tutto quell’Ottocento che tutti vogliono scordare. È una tendenza veramente terzomondista.
G.P.: Ma quando dipingi che differenza c’è in te da quando fai un’altra cosa, installazione o altro?
J.K.: Io faccio sempre una pittura storicamente possibile. Cosa vuol dire installazione? Non l’ho mai saputo. Probabilmente anche le pitture di Masaccio e tutta la pittura d’affresco italiana sono un’installazione.
G.P.: Si, ma tu hai una diversa tensione tua interna tra il momento “pittorico” e gli altri? Una diversa tensione morale? O è soltanto l’aspetto formale che cambia?
J.K.: Per me non ci sono momenti diversi; ci sono momenti creativi e basta.
G.P.: Quando lavori provi piacere?
J.K.: Nel lavorare in genere provo piacere, piacere e tensione, e poi riesco ad avere una lettura, una lettura della storia e degli avvenimenti. Facendo queste cose ho rinunciato a quello che faceva un pittore tradizionale. Scoprire e riprendere la tradizione non significa che i mezzi siano uguali: ho pensato sempre che la tecnica di Caravaggio è l’ideologia di Caravaggio, che senza quella ideologia della Controriforma non puoi avere un Caravaggio; perciò tutti quelli che cercano di riprendere questo tipo di tecnica senza questo tipo di ideologia sono ridicoli insomma.

G.P.: Pensi che molta della produzione pittorica attuale sia astorica in un certo senso?
J.K.: L’Astorico è stato inventato per giustificare il possibilismo linguistico ed io non credo che esista una esperienza artistica astorica.
G.P.: Ma cosa significa esistere per un’opera?
J.K.: Significa nascere da una visione della storia e appartenervi, che sia nata in una data precisa per una necessità linguistica reale.
G.P.: Esiste un Kounellis pubblico e uno privato?
J.K.: No, questo sarebbe troppo! Ce n’è un unico ed è tutto pubblico. Ci sono anche delle cose che fanno parte del modo di essere artista, un’improvvisa spensieratezza non fa parte dei problemi. I problemi sono altri, cioè gli interessi che un artista fa nascere, quelli che nasconde. In che misura oggi un pittore è visionario?
G.P.: Ma perché parli di interessi?
J.K.: Non voglio negare tutti gli interessi che fanno nascere delle forme e che sono vari, da quelli morali, etici, a quelli economici, politici…
G.P.: Ma non potrebbero essere le forme a far nascere gli interessi?
J.K.: Io penso che le forme dovrebbero fare nascere gli interessi ma purtroppo la realtà è più complessa.
G.P.: Credi in un artista ideologizzato?
J.K.: Per ideologizzato, tu intendi un intellettuale militante mentre io intendo un artista rinascimentale perché la nascita di un’immagine è ideologia.
G.P.: Se ho ben capito un’arte al di fuori di una realtà storica o di una componente ideologica non ha senso?
J.K.: L’Arte nasce da una mancanza come tutte le poesie ed è visionaria anche per questo. Naturalmente la lingua che nasce insieme con l’artista è investita e rappresenta la realtà storica.
G.P.: Ma credi che non possa esistere un fruitore intellettualmente preparato, colto, che possa avere il piacere di guardare un’opera di pittura, lasciarsi andare, come si dice, per trarne giovamento psicologico?
J.K.: Il piacere nella pittura riguarda l’esattezza linguistica e formale. Naturalmente bisogna dare alla lingua e alla forma tutta l’estensione possibile, e questo a mio avviso è quello che si intende per una bella cosa.
G.P.: E secondo te la pittura che si sia facendo oggi manca di dialettica?
J.K.: Nasce come una cosa antidialettica. E questa è ancora la sua forza, ma insieme la causa della sua poca credibilità.
G.P.: Quali sono i pittori, della tua generazione o più giovani, che ti interessano, e perché?
J.K.: C’è una serie di amori di pitture e di pittori del passato: Delacroix, Cézanne, questo si, ma quello che mi interessa oggi… vedi, una serata con un amico con la sottigliezza di molti miei amici mi interessa moltissimo, stimo anche un certo tipo di concetto di fare arte di molti miei amici. Non è che io vedo solo i miei amici, vedo anche gli altri…
G.P.: Quando vedi le opere degli altri, diciamo dalla Transavanguardia ai Tedeschi agli Americani eccetera, senza accomunarli, che tipo di reazione hai?
J.K.: Bisogna fare una distinzione fra opera e opera e fra artista e artista, poi, caso mai, puoi avere una opinione sull’insieme di una tendenza.
G.P.: Pensi che il lavoro degli Italiani, da Chia a Cucchi a Clemente, o di certi Americani, come Schnabel o Salle o Basquiat, nasca da un’adesione al consumismo o ad un clima culturale?
J.K.: Non so, non voglio insistere, anche perché i contrasti sono talmente forti che non vorrei… però penso che quel malinteso nasca in Italia. Prima di tutto alla base c’è un certo tipo di neofilosofia francese in quel programma, poi c’è un certo tipo di sclerosi di sinistra, una reazione insomma in cui una, quella neofilosofia francese, giustifica quel tipo di forma cioè il liberalismo detto in quella maniera, e l’altra dà il perché farlo. Ma questi non sono argomenti.
G.P.: Non credi invece che questo tipo di esperienza nasca, perché non si parla solo dell’Italia, da una congiuntura di tipo particolare per cui in un certo momento, ’78-79…
J.K.: È vero anche questo, si. Ma io penso sempre, non so, per certe cose dici sempre: ma perché non nasce qua e nasce li? E quando nasce e perché?… Baselitz negli anni 60 faceva questi quadri e non aveva presa, mentre più tardi ha avuto successo, anche perché in realtà ci sono due Germanie: una che senza dubbio è una delle patrie del moderno e l’altra dove c’è una tendenza neoromantica della ricerca di un certo tipo di identità. Anche questo è un fenomeno ripetitivo nella storia tedesca e anche nella nostra storia c’è il Novecento. Adesso bisogna vedere se ci aderisci o no, che cosa nasconde il Novecento rispetto al Futurismo.
G.P.: E la critica che ruolo svolge secondo te in questo momento?
J.K.: Non so, penso che ha perduto la credibilità… l’ha perduta di fronte alla lucidità di Manzoni… Questo è il punto, perché ci sono delle improvvisazioni. In Italia con quel tipo di fisionomia che hanno voluto darle, non so, il povero Fontana sembra un estraneo! Come si fa?! Penso che sia assolutamente ridicolo.
G.P.: In una recente intervista Chia mi diceva che se un artista è bravo ha successo e se lui non fosse allo Stedelijk penserebbe di se stesso che qualcosa non va. Tu che ne pensi?
J.K.: Io naturalmente penso il contrario. Non è perché non riconosco i musei o le istituzioni, ma bisogna ammettere che i musei sono legati alla personalità e all’indirizzo culturale di chi li dirige. A me piace il museo con un programma più esclusivo.
G.P.: Ma ci possono essere dei grandi o dei bravi artisti che non riescono ad affermarsi, che restano sconosciuti?
J.K.: Certo… bisogna vedere in che misura si è affermati e chi lo dice. L’affermazione è una opinione e l’affermare la propria posizione è una finalità per un artista.
G.P.: Ci sono delle opere tue che non vorresti aver fatto?
J.K.: Non è per mancanza di coerenza che molte volte nasce male un lavoro, ma perché il reale è ambiguo ed è qua che si vive, dunque è possibile uno slittamento e allora nasce un lavoro che non è reale. Credo che bisogna ritrovare le motivazioni. Per parlare sempre dell’Italia, bisogna ritrovare il senso di slancio poetico dei momenti migliori del dopoguerra. È indispensabile, cioè aldilà della forma, aldilà del fare quella cosa o un’altra; però è naturale che bisogna trovare quello slancio poetico, perché parlare di poesia non è mica… non puoi dire che Mondrian non è un poeta, è semplicemente un grande poeta.

G.P.: Tu leggi spesso la poesia?
J.K.: Si, qualche volta.
G.P.: Qual è rimasto il tuo legame con la Grecia? Ci sei tornato recentemente?
J.K.: Sì, sono tornato. Resta un rapporto affettivo. Il resto non è che un fatto anagrafico, bellissimo perché io sono fiero di essere nato in Grecia, ma resta un fatto anagrafico. I fatti reali non si svolgono lì per quel che mi riguarda. È naturale che mi porto dietro la mia vita e i miei ricordi.
G.P.: Ti senti totalmente realizzato come artista?
J.K.: No.
G.P.: L’opera più bella sarà quella di domani?
J.K.: Penso quella di quando finalmente mi realizzerò – bisogna accettare questo debito con la storia – quando finiranno le mie paure.
G.P.: Pensi di restare nella storia dell’arte?
J.K.: Non so, quello che faccio è calibrato, è reale, il resto non mi riguarda.
G.P.: Sei ambizioso?
J.K.: Quando il mio calvario di contraddizioni che non vuole finire finirà, avrò una risposta più precisa da darti, ma bisogna prima che quella mia terribile condizione finisca.
G.P.: Quando lavori che tipo di emozioni hai? Un’emozione intellettuale o di altro tipo, anche fisica?
J.K.: L’opera è sempre il risultato di più stratificazioni. Riuscire volta per volta a dare almeno un’apparente sintesi a tutte quelle stratificazioni è un’emozione.
H.K.: Da dove parti?
J.K.: Parto dall’ultimo lavoro.
H.K.: Vuoi dire che è una cosa un po’ imprecisa o ti appare già nei dettagli?
J.K.: No, già nei dettagli, per quanto possibile perché nel lavoro c’è da dire fino all’ultimo momento, dunque se era così preciso nei dettagli lo poteva fare anche un altro. È come una calamita che sta fuori, che prende fino all’ultimo momento.
G.P.: Quando reputi una tua opera finita?
J.K.: Quando sento il bisogno di farne un’altra. Il compiersi è un attimo e dopo come tutti i sogni romantici o barocchi spariscono. È un momento che diventa reale e dopo questa realtà sparisce, perché aspetta sempre una carica nuova di reale. Perciò non è finito niente.
G.P.: Sei lento o veloce nel lavoro?
J.K.: No, lentissimo.
H.K.: Come si forma un lavoro? Parti da disegni, da progetti?
J.K.: Da vari disegni sparsi. Sono delle idee che metto giù e poi finisco per farne sempre la stessa cosa, ma è un cambiamento significativo volta per volta.
H.K.: Fai delle maquettes?
J.K.: No, perché se fai così sparisce uno degli elementi a mio avviso fondamentali che è l’emozione. Bisogna indovinare lo spazio, cioè captarlo, ed è in un punto che lo si capta, e allora il lavoro ha una sua vita e una sua estensione.
G.P.: Che differenza c’è tra un lavoro grande e un disegno?
J.K.: Nel disegno ho sempre calcolato delle cose che erano completamente sognate. Il lavoro è ben diverso.
G.P.: I tuoi inizi di artista sono avvenuti in Italia?
J.K.: Si.
G.P.: Tu pensi che l’arte in generale e il tuo lavoro in particolare subisca un processo evolutivo?
J.K.: L’artista cerca sempre la vitalità, le intenzioni e i contenuti del primo lavoro ma l’adesione al reale comporta dei sensibili cambiamenti formali.
G.P.: Esiste un clima naturale o sociale che influenza l’artista?
J.K.: Entrambi naturalmente. Le cose nascono in un certo momento e per delle ragioni imprecisate ma che tutti sanno in realtà precisare. Importante invece è il momento attuale, la visione, la dinamica delle problematiche, questo può essere anche un momento liberatorio. Non in senso di giudizio per qualcuno, “quello è sbagliato”, eccetera, il problema è che bisogna riportare l’arte in questo binario maestro della volontà dichiarata e morale. Non perché gli altri hanno torto.
G.P.: Non pensi invece che questo momento sia particolarmente dialettico, più che gli anni 70?
J.K.: Effettivamente gli anni 70 non sono mai esistiti. Questo momento può avere delle sorprese di rinnovamento formale, dunque di riavvicinamento alla tradizione e questo vuol dire rinnovamento formale. È l’unica maniera per riprendere la tradizione.
G.P.: Tu credi veramente che molta dell’arte che si produce oggi è un tipo d’arte consumistica e che non resterà?
J.K.: Che ti posso dire? lo penso che il quadro sia legato non a un certo tipo di consumismo ma di idea del mercato, e anche la vivacità e la visione del mercato non sono negative. Perciò non è il mercato il negativo, è il consumismo, è l’eccesso che è dannoso.
G.P.: Ma non esiste mai una divisione o un elemento netto per poter dire qual è l’eccesso. Si è sempre parlato di eccesso, anche per Picasso per esempio, per Pollock…
J.K.: Sì, ma si tratta di un eccesso di lingua, di creatività, un eccesso di approfondimento. Veramente parlare di eccesso di mercato mi pare la cosa meno reale, cioè di fronte a loro che sono eccessivi in virtù, parlare di un eccesso di mercato è… riduttivo insomma.
G.P.: Qualcuno mi diceva: dove c’è il mercato c’è arte. Tu cosa rispondi?
J.K.: Questo ha anche un suo peso di verità: è vero che il mercato offre degli stimoli; ma tu capisci che all’epoca del Cabaret Voltaire non avevano molti di quegli stimoli però hanno fatto una cosa fondamentale.
G.P.: L’artista è eversivo, è contro la società, contro…?
J.K.: Non c’è bisogno di una maniera così dichiarata ed esplicita, però la lingua è legata alla storia dell’eversione, la lingua è eversiva, il modificare, il modulare la lingua è per forza di cose eversivo.

G.P.: Allora la pittura è stato un momento di evasione nei confronti della società dell’arte che ci aveva forse troppo abituati a codici diversi?
J.K.: Tu pensi che una forma è pittura e l’altra non lo è, mentre io penso che la storia della pittura non si è mai interrotta e la tradizione del nuovo ha delle radici bagnate nell’Illuminismo che hanno dato fino a noi dei frutti considerevoli; adesso bisogna vedere se uno si identifica con quella tradizione oppure no.
G.P.: Non pensi che questo tuo giudizio così severo nei confronti della pittura sia determinato dal fatto che tu hai acquisito una sensibilità molto diversa?
J.K.: Come ti ho detto prima non ho mai considerato la storia della pittura interrotta ma non considero neanche l’oleografia come una pittura.
G.P.: Sii più esplicito.
J.K.: Io vorrei lasciare tutto il discorso su un possibile futuro della forma. A me interessa l’avvenire e la possibilità che molti dei miei amici pittori rientrino in una nuova esperienza formale.
G.P.: Ma non ti sembra che la pittura spetto alla pittura tradizionale? Cioè se paragoniamo un quadro di Chia e uno di Guttuso ci troviamo di fronte a due esperienze diverse.
J.K.: Si, uno ha un’esperienza, un’idea, un pathos anche, risorgimentale, che Chia non ha. Anche Boccioni ha un pathos risorgimentale… il suo era formalmente reale, quello di Guttuso è populista…
G.P.: Ma sono due esperienze, due culture, due personalità talmente diverse…
J.K.: Sì, però non si può scordare un’esperienza straordinaria ed efficace come quella di Fontana, per incidere nella coscienza dì un pittore, altrimenti c’è qualcosa che non va.
G.P.: Hai parlalo di Fontana e di Manzoni, ma non pensi che la loro esperienza si sia esaurita nel momento in cui si è compiuta?
J.K.: No, ma io non intendo una ripetizione formale di quella esperienza. Non credo che sia esaurita la tensione e la tenuta, la volontà di un discorso. La loro esperienza formale è finita con loro, ma quel tipo di altra esperienza non tiene conto di loro e non tenendone conto rischia il fallimento, perché quella di Fontana è un’operazione reale. Cioè non è un modernista, è una personalità che è legata in un certo modo alle problematiche internazionali, nasce da presupposti diversi. Loro nascono da presupposti regionali, ecco, è lì il falso.
G.P.: Ma tu non credi al regionalismo, al folklore?
J.K.: No, io penso che queste siano motivazioni terzomondista, io non ci credo assolutamente.
G.P.: Ma anche tu continui a portarti dietro…la cultura greca è preponderante in te.
J.K.: il rinascimento e gran parte della cultura tedesca sono stati lettori approfonditi della Grecia, io penso che la Grecia è una opinione, non è neanche un paese, cioè il classicismo è un dato dialettico, al di fuori di quella dialettica hai una cultura provinciale ed emarginata.
G.P.: Ma alcuni elementi della tragedia greca, per esempio, tutto sommato a me sembra, malgrado tu non lo voglia ammettere, siano rimasti nel tuo lavoro.
J.K.: Io penso che anche Von Kleist oppure Brecht hanno degli elementi della tragedia greca. Dunque io non posso rivendicare un’appartenenza per quanto nato in Grecia. Sarebbe un fatto riduttivo verso una cultura per la quale ho una grandissima considerazione. Ma non è a livello di appartenenza, l’appartenenza è un’opinione. La Grecia non so…è tutto l’Occidente. Altrimenti sarebbe un fatto folkloristico.
G.P.: No, non sto parlando di folklore; però lo stesso de Chirico o Savinio hanno portato con loro…
J.K.: Sì, ma ce l’ha anche Picasso, ce l’ha Ingres, probabilmente a livello dialettico ce l’ha anche Delacroix, ce l’hanno tutti. Non è un problema, la cultura greca non è un problema perché è un dato comune.
G.P.: Per esempio l’Espressionismo tedesco e austriaco…
J.K.: L’Espressionismo di Dresda o di Berlino sono estremamente diversi da un certo tipo di arte viennese, c’è anche stato un grandissimo movimento Dada a Berlino e ad Hannover viveva Schwitters.
G.P.: Roma è stata importante per te?
J.K.: Importantissima: è una cosa straordinaria che non c’è, un punto, non ha precisa attività, però è una cosa enorme, non si sa perché ma è una cosa enorme.
G.P.: Cosa pensi dell’arte americana contemporanea? Le esperienze più recenti ti interessano?
J.K.: Io penso che di recente in America c’è l’arte americana, penso naturalmente a Pollock, de Kooning, a Rauschenberg, e a Jasper Johns, a Oldenburg, a Carl Andre, a Sol LeWitt, a Ryman… fra gli altri, e basta.
G.P.: Non c’è piuttosto una sorta di vitalità più anglosassone, più radicale?
J.K.: È difficile concepire il radicalismo senza il protestantesimo ma è anche difficile pensare che Masaccio alla sua epoca non è stato radicale, voglio dire che i movimenti di pensiero europei sono innanzitutto conseguenza del Rinascimento che a sua volta si rifà alla Grecia classica.
G.P.: Come dovrebbe esser secondo te la critica? Ce n’è vero bisogno, innanzitutto?
J.K.: Il critico ha un senso se è come Apollinaire. È come il primo lettore, il più appassionato, il più sensibile; quella particolare figura che è il critico incancellabile. Diventa maligno quando è investito da un certo potere. In realtà è una figura indispensabile che fa parte della dialettica…
G.P.: Chi è l’Apollinaire italiano?
J.K.: Nessuno! Non ci sono Apollinaire italiani. Apollinaire è nato a Trastevere! ( Risate).
G.P.: Stai scherzando?
J.K.: No, è la verità. È nato a Trastevere da una madre polacca e da un padre che non si sapeva chi fosse.
G.P.: Quindi il critico dovrebbe essere un creativo che tiene un contatto con l’artista?
J.K.: Per forza di cose, in ogni maniera deve essere in contatto con l’artista; creativo o no, lo deve, se no che critico è? Lo storico è un’altra cosa. Il critico integra un’attività contemporanea.
G.P.: Che cosa pensi dei “Neoclassici”?
J.K.: Del Canova? (Risate). Che cosa ne penso? Non so, penso al movimento moderno che poi è un movimento antico, realmente antico, perché porta le problematiche al parossismo, come hanno fatto gli antichi. C’è una distinzione tra iconografia e iconologia: l’iconologia è un fatto illustrativo, l’iconografia è un’altra cosa. Io credo che a livello critico è inesatto… la gente guarda quel tipo di immagine e si riconosce senza tener conto dei contenuti di forma e di lingua, dunque può essere di tutto, una pittura di certo non lo è, perché serve la lingua per fare pittura.
H.K.: Tu consideri le tue opere una specie di arte totale, di Gesamtkunstwerk? Perché ci sono molte…
J.K.: Analogie?
H.K.: Si. anche analogie, ma anche molti tipi di arte sono presenti nelle tue opere.
J.K.: Pur di formalizzare un discorso, io sono capace di portare una nuvola dentro un pollaio!
G.P.: Spesso ci sono riferimenti letterari nel tuo lavoro.
J.K.: Sì, la letteratura io la trovo come un insieme, la letteratura fa parte, cioè è un fatto di carattere straordinario, guarda… l’Ulisse di Joyce, non so… sono cose straordinarie, e poi ti esaltano, danno forza, danno prospettive, danno del coraggio; mentre guarda la nostra letteratura come è andata a finire! Sembrano tutti degli impiegati!
G.P.: Purtroppo devo dire che anche la critica orinai in Italia tende ad essere...
J.K.: Il guaio della critica in Italia è che ha una visione accademica del lavoro. È essenzialmente di formazione crociana, è uno dei motivi per i quali la loro lettura sui movimenti moderni è avvenuta in ritardo, quando la loro lingua ne era codificata; l’altro motivo è l’eccesso di burocratismo.
G.P.: Quando stai male fisicamente riesci a lavorare?
J.K.: No, però devo dire che negli ultimi tempi sono stato male pochissimo! (Ride).
H.K.: Quanti lavori riesci a fare in un anno?
J.K.: Pochissimi! Dodici, e già sono troppi.
G.P.: Quando non lavori che cosa fai?
J.K.: Ho sempre lavorato. Ogni giorno, e anche quando mi alzo la mattina alle 5 lavoro dalle 5.
G.P.: Com’è la tua giornata? Quando ti alzi alle 5 cosa fai?
J.K.: Penso al lavoro da fare, subito.
G.P.: Questo ti coinvolge per tutto un mese?
J.K.: Finché faccio il lavoro.
G.P.: Quindi è una specie di ossessione? Un’ossessione mentale, intellettuale?
J.K.: Come tutti. Come si fa a fare un lavoro sennò?
G.P.: Quindi lavori sulle tue idee?
J.K.: No, lavoro sulle cose. È molto lento il processo del lavoro; il lavoro sembra semplice ma non lo è per niente, perché metto in atto tutte le contraddizioni e lo pulisco piano piano.

G.P.: Adesso vai a Monaco per una grossa mostra, porti con te già il lavoro, l’idea del lavoro?
J.K.: Si, faccio una mostra al museo Lenbachhaus, porto anche gli elementi del lavoro; su per giù so quello che devo fare.
G.P.: Tu sei noto come un artista difficile per le gallerie, nel senso che…
J.K.:Veramente ho fatto cento mostre, sai?
G.P.: Si però crei problemi di ordine pratico.
J.K.: Questo si, è vero.
G.P.: Questo vuol dire che l’idea della mostra, del lavoro si completa nel momento in cui lo esegui?
J.K.: Si, ma come fanno tutti i pittori, c’è chi lo fa in studio e chi lo fa in chiesa!
G.P.: A casa dici che lavori dalle cinque del mattino…
J.K.: Lavoro sì, e lavoro nel senso di definire un’idea; dopo il resto è un’occasione.
H.K.: Non hai bisogno di uno spazio esatto per stabilire l’opera?
J.K.: Il perché di un lavoro lo faccio per conto mio, l’altro è un’estensione, un ampliamento; i lavori nascono dalle manie, manie di persecuzione, dall’idea del bersaglio, volta per volta: è li che vuoi arrivare ed è li la nascita di un lavoro. Fare i lavori è sempre stato facile, non è una cosa difficile eseguire un lavoro: serve l’esperienza che uno può anche acquisire, non è difficile. Ma è estremamente doloroso farlo perché indica una posizione, sempre.
G.P.: Una nuova mostra ti dà nuovi stimoli o è solo la conseguenza…
J.K.: Mi dà stimoli e la faccio per questo, perché ti mette in contatto con il reale, sempre. C’è una distanza tra tutto questo e… perché non riesci a capire dove finisce il sogno, dove comincia la visione; e quella, la mostra, è un attimo di realtà. Non è più la mostra in senso ottocentesco, cioè il mostrare non è tutto perché tu prendi lo spazio come cavità teatrale e dunque come discorso… tutto quello che formalizza un lavoro viene ad essere messo in gioco. C’è la volontà di essere messo in gioco.
G.P.: Che differenza c’è tra una mostra in una galleria privata e una in un museo?
J.K.: Quando penso a una mostra in una galleria privata penso a come era quella casa editrice Shakespeare and Company, cioè non penso alla galleria privata come pura struttura finalizzata in senso commerciale, la trovo come una idealità gestita da privati; perché se pensassi che trae una finalità solamente commerciale, sarebbe completamente degradante, mentre così il privato ha la dignità di gestire una cosa pubblica, la differenza sta lì.
G.P.: Sei molto attento al denaro?
J.K.: Il denaro mi piace, però riesco a controllare molto bene questo tipo di piacere. Mi piace guadagnare anche dei soldi, ma non sono disposto a dare delle cose essenziali per quel motivo.
G.P.: A te interessa dove l’opera va? Tra un museo di grande prestigio e il salumiere, è la stessa cosa? È una questione di prezzo?
J.K.: La letteratura impressionista ha gratificato la figura del salumiere come collezionista e non bisogna scordarsi che la mostra degli Indipendenti era organizzata in un caffè.
G.P.: La tua vita privala è importante?
J.K.: È complicata! (Ride). Si, è importantissima, per quello che ho e per quello che sogno. È importante quando è coerente con la vita pubblica, non è importante di per se stessa.
G.P.: Hai momenti di relax nella tua vita privata in cui non pensi assolutamente al lavoro, ti lasci andare, giochi con tuo figlio o porti a spasso il cane?
J.K.: Sì, qualche volta lo faccio.
G.P.: Se tu non avessi avuto successo sarebbe stato lo stesso il lavoro?
J.K.: Assolutamente lo stesso.
G.P.: Non avresti smesso?
J.K.: No, no.
G.P.: La tua vita è stata dura? La tua vita d’artista, dico.
J.K.: All’inizio sì, perché è dura la città dove vivo… Era dura, e lo è tuttora, però non rimpiango niente.
G.P.: Comunque hai avuto successo abbastanza presto.
J.K.: Sì, dalla prima mostra ho cominciato ad avere degli interessi. Le difficoltà erano le difficoltà che hanno avuto tutti gli altri che erano con me, non è un fatto che ho avuto io solo.
G.P.: Dei tuoi compagni di strada degli inizi incontri ancora qualcuno?
J.K.: Non incontro nessuno perché esco raramente di casa, cioè esco di sera, vedo due o tre persone da quindici anni.
G.P.: Questi amici non sono artisti compagni di strada degli inizi?
J.K.: Si, ma li ho incontrati più tardi e con loro riesco a discutere sul lavoro. Allora diventa bello, perché bisogna avere un punto di paragone per poter calcolare, calcolare anche i cambiamenti, se tu hai un punto fisso vedi i cambiamenti.
H.K.: Hai un metodo di lavoro, alcuni punti di riferimento che devi rispettare?
J.K.: Sì, sono gli altri miei lavori. Questo è l’unico interrogativo; se no uno si sveglia la mattina ed è completamente diverso.
G.P.: Riesci a lavorare ovunque?
J.K.: Sì, dappertutto, anche in treno, anche in albergo.
G.P.: Scrivi, prendi appunti?
J.K.: Si, continuamente. È il mio metodo di lavoro, non c’è niente di eccezionale, io lavoro sempre così, anche in macchina.
G.P.: Fai degli schizzi?
J.K.: Si soltanto degli schizzi, perché il resto si calcola li per li.
G.P.: Quali sono gli artisti che oggi ti interessano maggiormente, rispetto al tuo lavoro o anche indipendentemente da esso?
J.K.: Il paragone è sempre con quelli che in qualche modo sono più antichi, diciamo. I conti li fai sempre con questi.
H.K.: Il lavoro che hai presentato a Documenta non si può leggere nel senso di una certa antitesi nei confronti della cultura tedesca o della cultura occidentale?
J.K.: Il muro d’oro è stato fatto nel 1973 a Napoli ed è stato riesposto in occasione della Documenta. Quel lavoro non crea antitesi, è fatto da un occidentale, può riferirsi a Vienna, anzi è probabile che si riferisca a Vienna, o può essere il fondale di un’opera di Brecht, nasce con questo tipo di presupposto. Naturalmente io come molti europei non posso considerare Dostoievsky parte della mia cultura.
H.K.: Il tuo uso della pittura figurativa negli ultimi 4 o 5 anni, anche quello ha un significato che è aldilà della situazione della nuova pittura? Non è che voglia commentare qualcosa che sta succedendo?
J.K.: Uno dei difetti del quadro è che non permette dubbi, mentre per me il dubbio è una difesa, è una finestra che permette di dialogare costantemente con l’esterno e di guadagnare in realtà senza cadere nella trappola del trasformismo.
G.P.: Il tuo lavoro è stato letto abbastanza correttamente?
J.K.: No, non credo.
G.P.: Pensi che l’artista italiano lavori ancora in uno stato di inferiorità?
J.K.: No, non penso di inferiorità, penso che non c’è l’equivalente di struttura, mentre gli altri hanno l’equivalenza di struttura e quello aiuta la lettura, mentre nel lavoro di un artista italiano la lettura è molto più lenta perché i passaggi sono lenti, la struttura non dà mai il quadro, perché non c’è addirittura una struttura qua.
G.P.: Il tuo lavoro in se stesso è comunque molto difficile da leggere.
J.K.: Non so, può anche darsi. Io lo vorrei facile però tutti dicono che è difficile… ( Ride).
G.P.: Pensi che il tuo lavoro abbia diversi gradi di lettura a seconda dei paesi in cui esponi?
J.K.: È naturale. C’è una frequenza linguistica e di problematiche che in un certo ambiente è comprensibile in molti paesi, è ovvio però che per ogni paese ci sono dei vincoli culturali locali che condizionano, definendola in un modo o in un altro, la lettura.
G.P.: Per fare un lavoro in un paese che non conosci hai bisogno di immedesimarli nel paese?
J.K.: No, io faccio il mio lavoro per conto mio… l’Italia mi offre gli elementi di analisi ed io li sviluppo dovunque.
G.P.: Hai mai fatto una mostra in Grecia?
J.K.: Si, una. L’ho fatta in una taverna di periferia dove c’era la gente che mangiava, ho esposto l’Apollo con me dietro la maschera e un flautista.