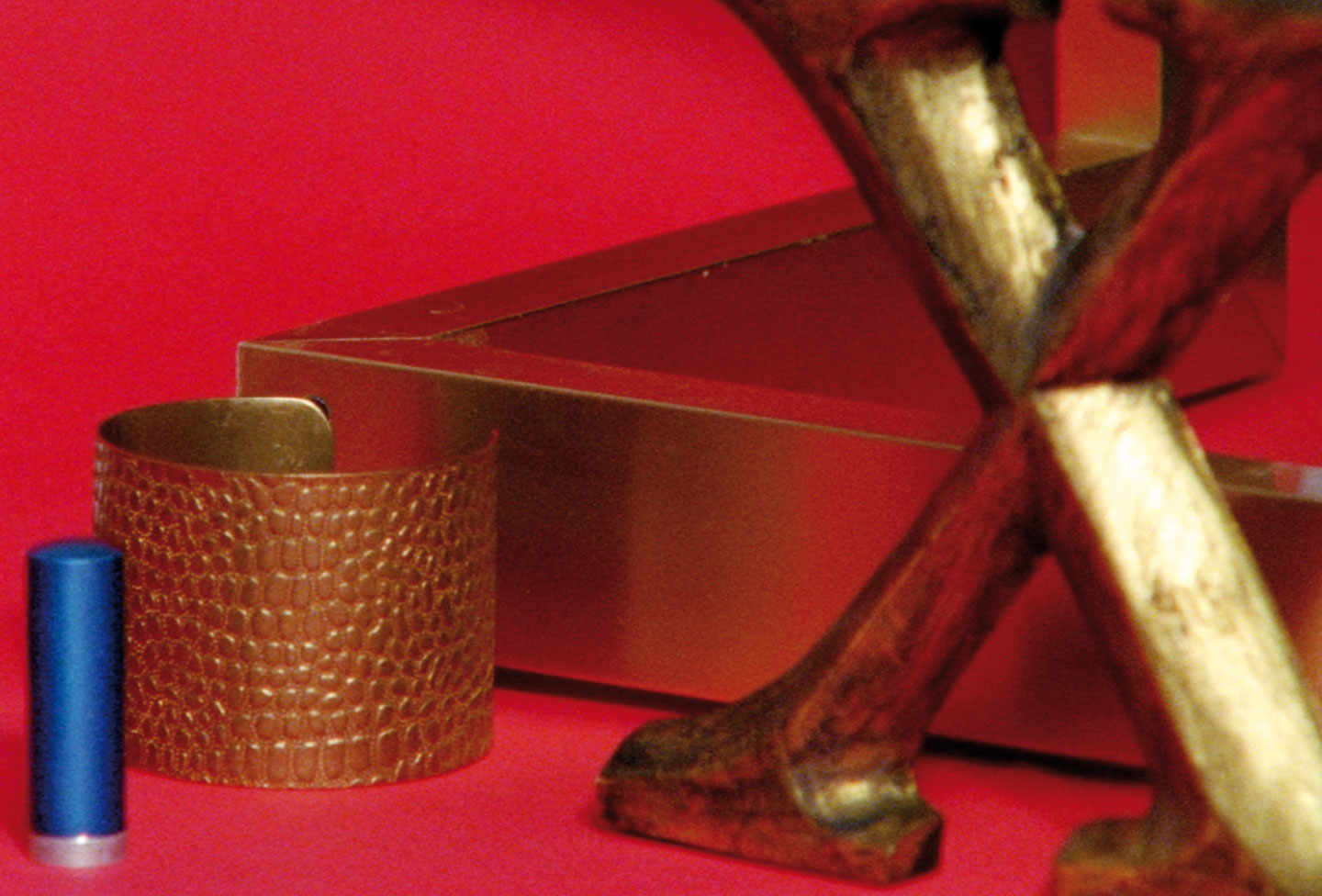Usare di nuovo, usare ancora, usare per altro, recuperare, riadattare, reimpiegare, far tornare in vita o allungare la vita alle cose. La mostra “RE.USE” è una carrellata lunga un secolo di arte intesa a mostrare come la creatività abbia fatto diventare lo scarto un elemento sublime, il rifiuto un linguaggio poetico.
Nelle tre sedi in cui si disloca il percorso (Museo Santa Caterina, Casa Robegan, Ca’ dei Ricchi) sembrano davvero riecheggiare le parole di Benjamin: “Mi approprierò dei rifiuti ma non per farne un inventario, bensì per rendere loro giustizia nell’unico modo possibile: utilizzandoli”. È così con le avanguardie del primo Novecento che non si esauriscono in un puro gesto iconoclasta, ma spostano gli oggetti fuori uso verso una radicale alterità. Ciò che è muto e banale si trasforma in qualcosa di ambiguo, ambivalente, estraneo. Succede con Duchamp e Man Ray, soprattutto con Schwitters, i cui oggetti trovati assumono la valenza di brandelli di vita privata, di intima ossessione maniacale. Ma è così anche con la bambola di Bellmer, vera esperienza di memorie clandestine, di corpi che esibiscono la paura della mutilazione, il dolore della perdita. Fino agli anni Sessanta, quando con i “Nouveaux Réalistes” (César, Arman, Spoerri) l’arte sembra identificarsi con l’appropriazione del reale più diretta e totale. Gli oggetti sono letteralmente “presi in trappola” e si caricano di una forte accezione di denuncia sociale, di un dichiarato avvertimento politico. Senza con questo abbandonare mai l’ironia, il sarcasmo, la levità. Basterebbe osservare i macchinari paradossali e cigolanti di Tinguely o l’altalena con la scritta “L’art s’en balance” di Ben Vautier, per capire come nella stessa opera si concentri infimo e sacro, strazio e tenerezza, innocenza e sapienza. È un lungo inventario, quello che propone Valerio Dehò (58 artisti e 87 opere), gremito di lacerti, contaminazioni, recuperi. Purtroppo i nomi sono quasi tutti noti: Manzoni, Christo, Rotella, Rauschenberg, Kounellis, ecc. Con il rischio che quanto messo in scena assuma solo l’aria di un diligente esercizio. Corretto, ma scontato. Non fosse per quella Regina fiabesca di Borghi, apparizione trasparente e impalpabile, fatta di migliaia di fondi di bottiglie di plastica o per quell’ “edificio” di Cragg che utilizza mattoni veri per costruzioni infantili; ma soprattutto se non fosse per quel continuo debordare verso l’antropologia (Costa), il poverismo (Pistoletto, Penone), la Body Art (Pane, Lüthi), dove è il corpo stesso a essere messo in gioco e a diventare elemento sacrificato e insieme trionfante. È come se il curatore attraversasse i vari movimenti per evidenziare quanto l’immaginario del Novecento si sia sempre confrontato con il banale per esplorarlo e coglierne la segreta meraviglia, l’intima dimensione psicologica, politica, ecologica.
Quando infine si passa agli ultimi anni, emergono altri cortocircuiti, in cui gli oggetti prendono i connotati di un esorcismo, di una sorta di cerimonia apotropaica, di una visione cupamente epicizzata del quotidiano. Lulaj presenta un video, in cui dei bambini giocano in una infernale discarica, divertendosi attorno alla magica apparizione di un monolite di ghiaccio. Morbin raccoglie la spazzatura dentro un aspirapolvere che si trasforma così in una paradossale urna funeraria. Vitone realizza un acquerello di carta e polvere, quasi a voler mostrare l’orma lugubre del nostro quotidiano che si disfa. È come ha scritto Calvino: “Ogni uomo si riconosce in un numero di cose, riconosce l’umano investito in cose, il se stesso che ha preso forma di cose”. E in esse si è perso.