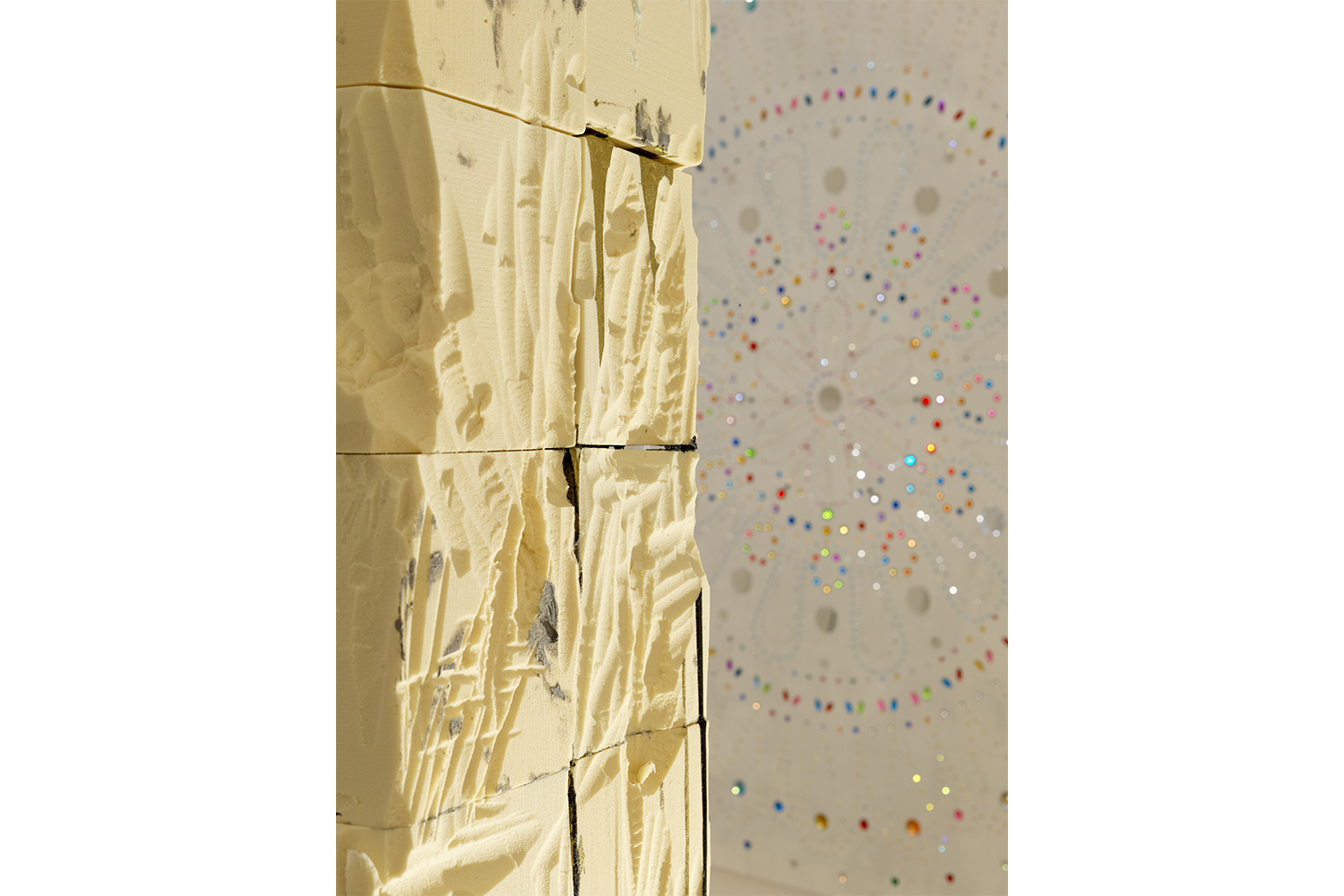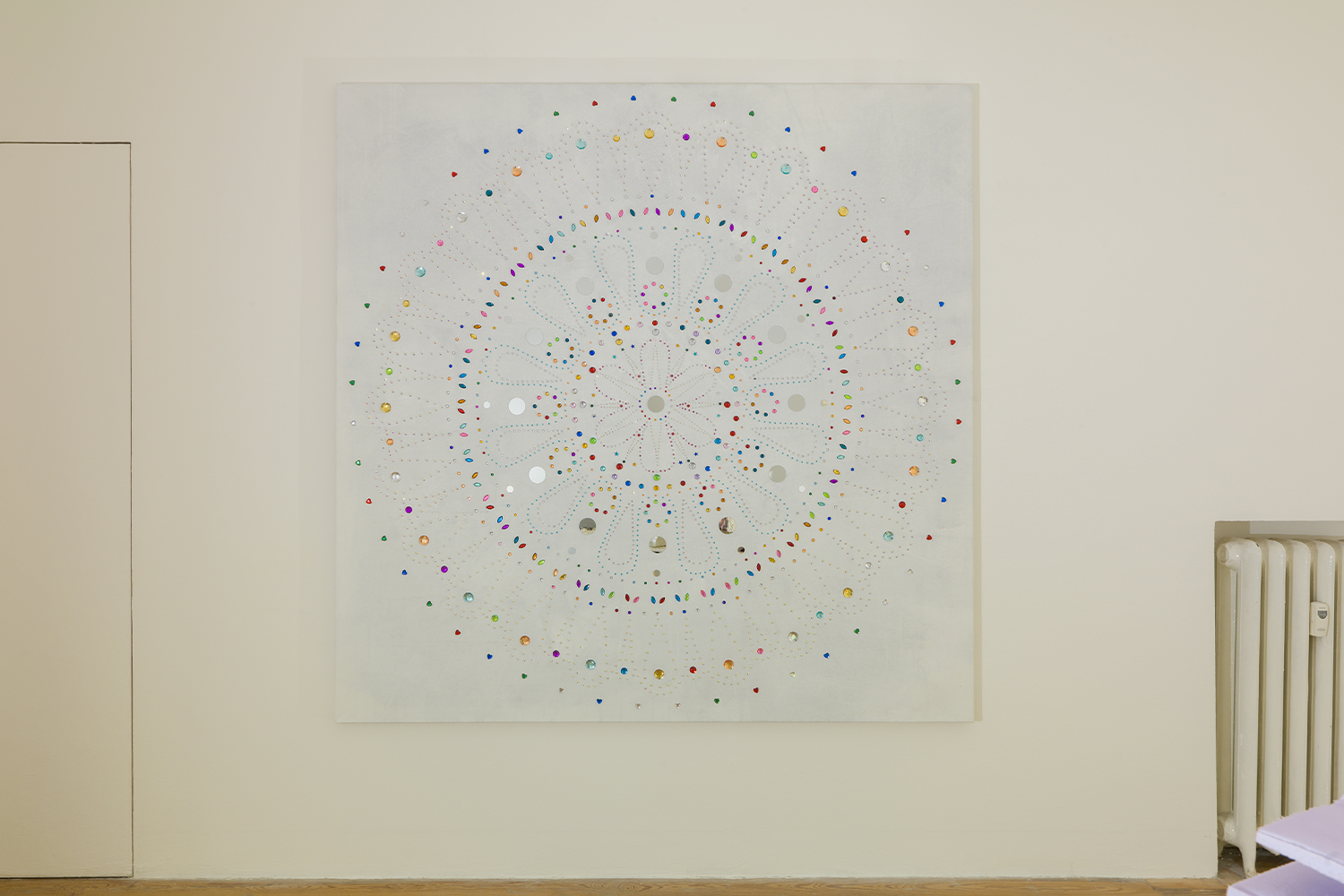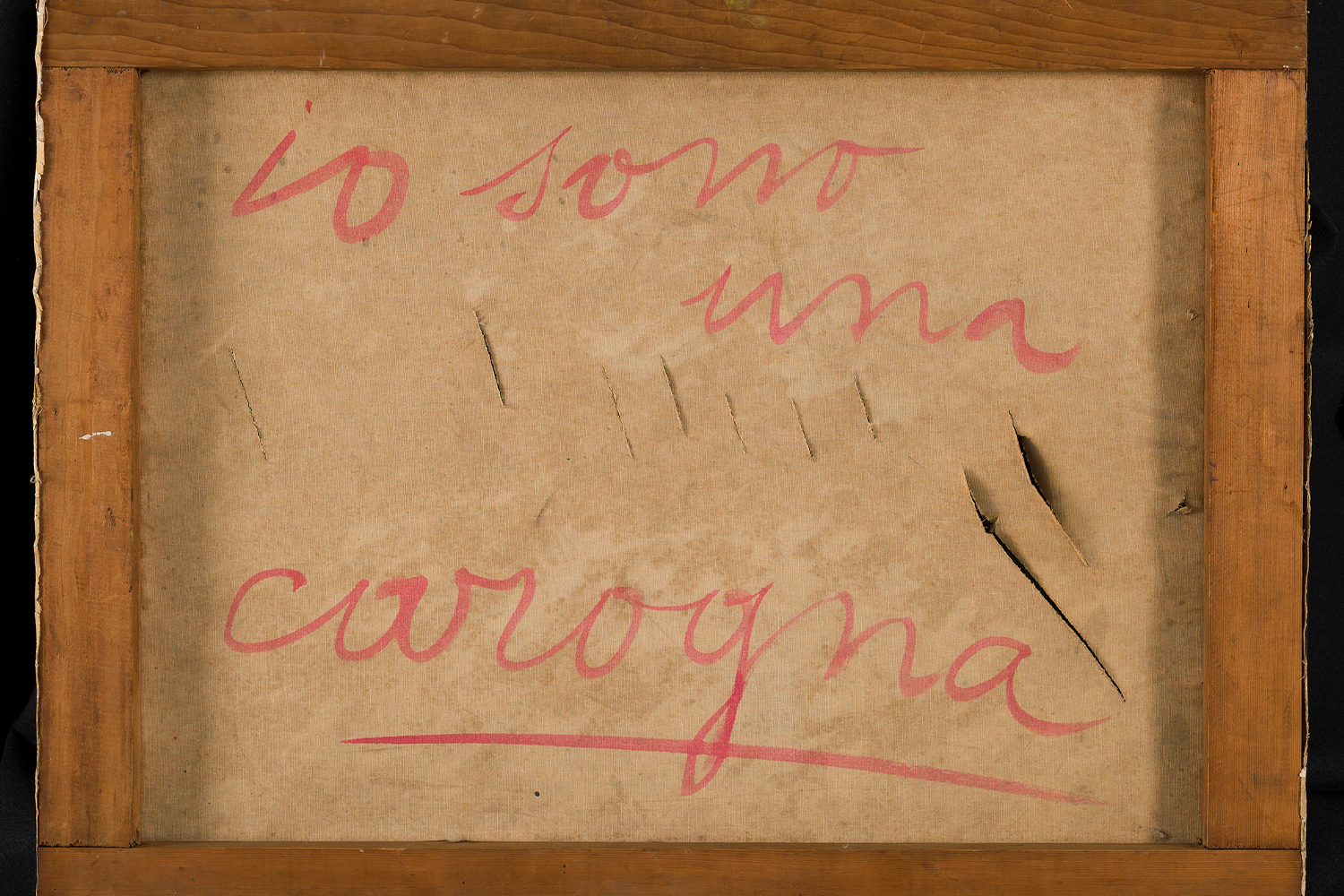Io sono un uomo ridicolo. Ora mi chiamano pazzo. Questo sarebbe un avanzamento di grado, se io, per loro, non rimanessi ridicolo come prima. Ma ormai non mi ci arrabbio più, adesso tutti mi sono cari, persino quando ridono di me; anzi, allora mi sono, non so come, particolarmente cari. Io stesso riderei con loro, non già di me, ma per amore di loro, se nel guardarli non mi sentissi così triste. Sono triste perché essi non conoscono la verità, io invece la conosco. Oh, come è duro essere il solo a conoscere la verità! Ma questo, loro, non lo capiranno. No, non lo capiranno.
Una volta invece mi affliggevo moltissimo, perché apparivo ridicolo. No non apparivo, ero ridicolo. Io sempre fui ridicolo e lo so, forse fin dalla mia nascita. Forse già a sette anni sapevo di essere ridicolo. Poi andai a scuola, poi all’università, ebbene? Quanto più studiavo tanto più imparavo che ero ridicolo. Sicché per me tutta la mia scienza universitaria pareva alla fine che esistesse unicamente per dimostrarmi e spiegarmi, man mano che mi ci approfondivo, ch’ero ridicolo. Come negli studi così fu nella vita. Ogni anno cresceva e si rafforzava in me la consapevolezza del mio aspetto ridicolo in ogni senso.
Di me ridevan tutti e sempre. Ma nessuno di loro sapeva, né indovinava che, se c’era un uomo sulla terra più di tutti consapevole ch’ero ridicolo, quello ero io stesso, ed ecco, questo appunto più di tutto mi riusciva offensivo, che loro non sapessero, ma la colpa ce l’avevo io stesso: fui sempre così orgoglioso che a nessun costo e mai volli confessar ciò ad alcuno. Quest’orgoglio cresceva in me con gli anni e, se per caso mi fossi permesso di fronte a chicchessia di riconoscere che ero ridicolo, mi pare che lì per lì, quella sera stessa, mi sarei fatto saltare le cervella con un colpo di rivoltella. Oh, come soffrivo nella mia adolescenza per il terrore di non poter reggere e di far io stesso d’un tratto qualche confessione ai compagni! Ma quando divenni un giovanotto, diventai, non so perché, un po’ più tranquillo. Proprio “non so perché”, per la ragione che tuttora non sono in grado di precisare un perché. Forse perché nell’anima mia si era andata accumulando una terribile angoscia per una circostanza che era ormai infinitamente superiore a tutto il mio essere: precisamente la convinzione formatasi in me che dappertutto nel mondo tutto è indifferente: indifferente. Da moltissimo tempo ne avevo il presentimento; ma piena convinzione mi venne nell’ultimo anno in un certo modo improvviso. D’un tratto sentii che mi sarebbe stato del tutto indifferente che esistesse il mondo o che non ci fosse nulla in nessun posto. Io presi a sentire ed avvertire con tutto il mio essere che in torno a me in mia presenza, non c’era nulla. Sul principio mi pareva, sempre che magari molto invece ci fosse stato prima, una volta, ma poi intuii che anche prima non c’era mai stato proprio nulla, e soltanto, non so perché, m’era sembrato. Allora smisi di colpo di arrabbiarmi con gli uomini, e quasi cessai di notarli. Davvero questo si manifestava perfino nelle più minute bazzecole; mi accadeva per esempio, andando per la via, di urtare qualcuno… la gente. E non già perché andassi fantasticando: e che avrei potuto pensare? Avevo allora smesso del tutto di pensare: tutto mi era allora indifferente. A cosa dovevo pensare? E meno male se avessi risolto dei problemi; non ne avevo risolto neppure uno, e quanti mai ce n’erano? Ma tutto m’era diventato indifferente, e tutti i problemi si erano allontanati.
Ed ecco che, già dopo ormai, conobbi la verità. La verità la conobbi lo scorso novembre, e precisamente il tre di novembre, e da quel tempo la ricordo a ogni istante. E me la ripeto, me la ripeto. Fu in una sera cupa, la più cupa che mai ci possa essere. Tornavo allora a casa dopo le dieci di sera e avevo precisamente pensato, rammento, che non ci poteva essere un’ora più cupa. Anche dal lato fisico. La pioggia era venuta giù tutto il giorno, ed era stata la più fredda e cupa delle piogge, una pioggia perfino in un certo modo minacciosa; questo lo ricordo, piena di palese ostilità verso gli uomini: e a quel punto d’un tratto, dopo le dieci, era cessata ed era cominciata una terribile umidità, più umida e più fredda, più cupa di quando pioveva, e da ogni cosa veniva una specie di vapore denso e cupo: da ogni pietra della strada e da ogni viuzza, se gettavo un’occhiata in avanti, in profondità, oltre la via che percorrevo. Mi figurai d’un tratto che, se i lampioni a gas fossero spenti dappertutto, ne avrei avuto maggior conforto, mentre col gas acceso il cuore si sentiva più triste, perché esso rischiarava tutto ciò, tutto ciò, tutto ciò… Quel giorno quasi non avevo pranzato, e fin dalle prime ore della sera ero stato a casa di un ingegnere, dal quale c’erano altri due amici. Io avevo sempre taciuto e li avevo annoiati mi pare. Essi parlavano di non so che argomento spinoso e a un tratto si accaloravano perfino. Ma la cosa era loro indifferente, lo vedevo, ed essi si scaldavano, si arrabbiavano, così solo pro forma. Di colpo glielo spiattellai. “Signori – dico – per voi questo è indifferente”. Non se ne offesero, al contrario, e tutti risero di me. Questo per la ragione che l’avevo detto senza rimprovero alcuno, e solo perché tutto mi era indifferente… mi era indifferente… indifferente. Essi videro che tutto mi era indifferente e ciò li mise in allegria e ridevano… ridevano.
Quando per la strada pensai al gas, gettai uno sguardo al cielo. Il cielo era oltremodo buio, ma vi si potevano chiaramente distinguere delle nuvole strappate e tra esse delle macchie nere senza fondo. All’improvviso scorsi in mezzo a una di quelle macchie nere una piccola stella e presi a guardarla, a fissarla. Questo perché quella stella mi aveva dato un’idea: mi sarei ucciso quella notte stessa. Era una cosa già da me fermamente stabilita fin da due mesi addietro e, per quanto fossi povero, avevo comprato una magnifica rivoltella e nello stesso giorno l’avevo caricata. Erano però già trascorsi due mesi ed essa stava tuttora nel cassetto; ma per me tutto era indifferente a tal segno che per uccidermi m’era infine venuta voglia di cogliere un momento in cui tutto mi fosse un po’ meno indifferente; a che scopo , non so. Ma pensavo… se uno si deve uccidere meglio farlo quando… piuttosto che… E in tal modo, durante quei due mesi, avevo pensato ogni notte, rincasando che mi sarei tirato un colpo in testa. Ma aspettavo sempre il momento. Ed ecco che ora quella piccola stella mi aveva dato l’idea, e io stabilii che sarebbe stato ormai senza fallo quella notte stessa. Ma perché la stella mi avesse dato l’idea, non so. Ed ecco, mentre guardavo il cielo, mi afferrò a un tratto pel gomito quella bambina. La via era ormai deserta e non si vedeva quasi nessuno. In lontananza dormiva sulla sua carrozzella un vetturino. La bambina era sugli otto anni; con un fazzolettino rosso in testa e solo un vestituccio indosso, tutta bagnata ma in modo speciale mi si impressero in mente le sue scarpe bagnate, lacere, anche adesso me le ricordo. Mi erano particolarmente balzate agli occhi. Ella s’era messa d’un tratto a tirarmi per il gomito e a chiamarmi. Non piangeva ma pareva che gridasse a strappi certe parole che non poteva pronunciar bene, perché tremava tutta, scossa dai brividi. Era atterrita per non so quale ragione e gridava disperatamente: ”La mammina! La mammina!”. Io volsi il viso dalla sua parte, ma non dissi nemmeno una parola e continuai a camminare; ella però correva e mi tirava, e nella sua voce echeggiò quel suono che nei bambini molto spaventati denota disperazione. Conosco questo suono. Sebbene non avesse finito di parlare, capii che sua madre in qualche posto stava morendo, o che in casa loro era accaduta qualche altra cosa, ed ella corsa fuori a chiamar qualcuno, a trovar qualcuno, per dare aiuto alla mamma. Ma io non la seguii, al contrario mi venne ad un tratto l’idea di scacciarla. Dapprima le dissi che insomma cercasse una guardia. Ma ella improvvisamente giunse le manine e, singhiozzando, ansando continuò a correre al mio fianco, senza staccarsi. Ecco fu allora che pestai il piede e alzai la voce. Ella gridò soltanto: “Signore, signore!” poi di colpo mi lasciò e a precipizio attraverso la via: era apparso là un qualche altro passante e lei, si vede, mi aveva lasciato per correre da lui.
Salii al mio quinto piano. Io abito da una specie di affittacamere. La mia stanza è povera e piccola, con una specie di finestra da soffitta a mezzaluna. Da me ci sono un divano di tela cerata, un tavolino con sopra dei libri, due sedie e una comoda poltrona, vecchia, vecchissima, ma, in compenso, à la Voltaire. Sedetti, accesi una candela e mi misi a pensare. Perché io di notte non dormo mai fin proprio all’alba, e ormai già da un anno. Passo tutta la notte vicino al tavolino in poltrona, senza far nulla. I libri non li leggo che di giorno. Sto seduto e non penso nemmeno, ma un po’ di pensieri mi vagano in testa, così, e io li lascio vagare liberamente. Nella notte la candela si consuma per intero, si consuma per intero… Quella volta sedetti molto lentamente davanti al tavolino, aprii il cassetto e tirai fuori la rivoltella e la posi davanti a me. Mentre la posavo, rammento, mi domandai : “sì?” e in modo perfettamente affermativo mi risposi: “sì”. Cioè mi sarei sparato. Sapevo che in quella notte mi sarei sparato ormai di sicuro, ma quanto ancora sarei rimasto, prima di quel momento, vicino al tavolino, questo l’ignoravo. E certamente mi sarei sparato, se non fosse stata quella bambina.
Da Il sogno di un uomo ridicolo di Fëdor Dostoevskij