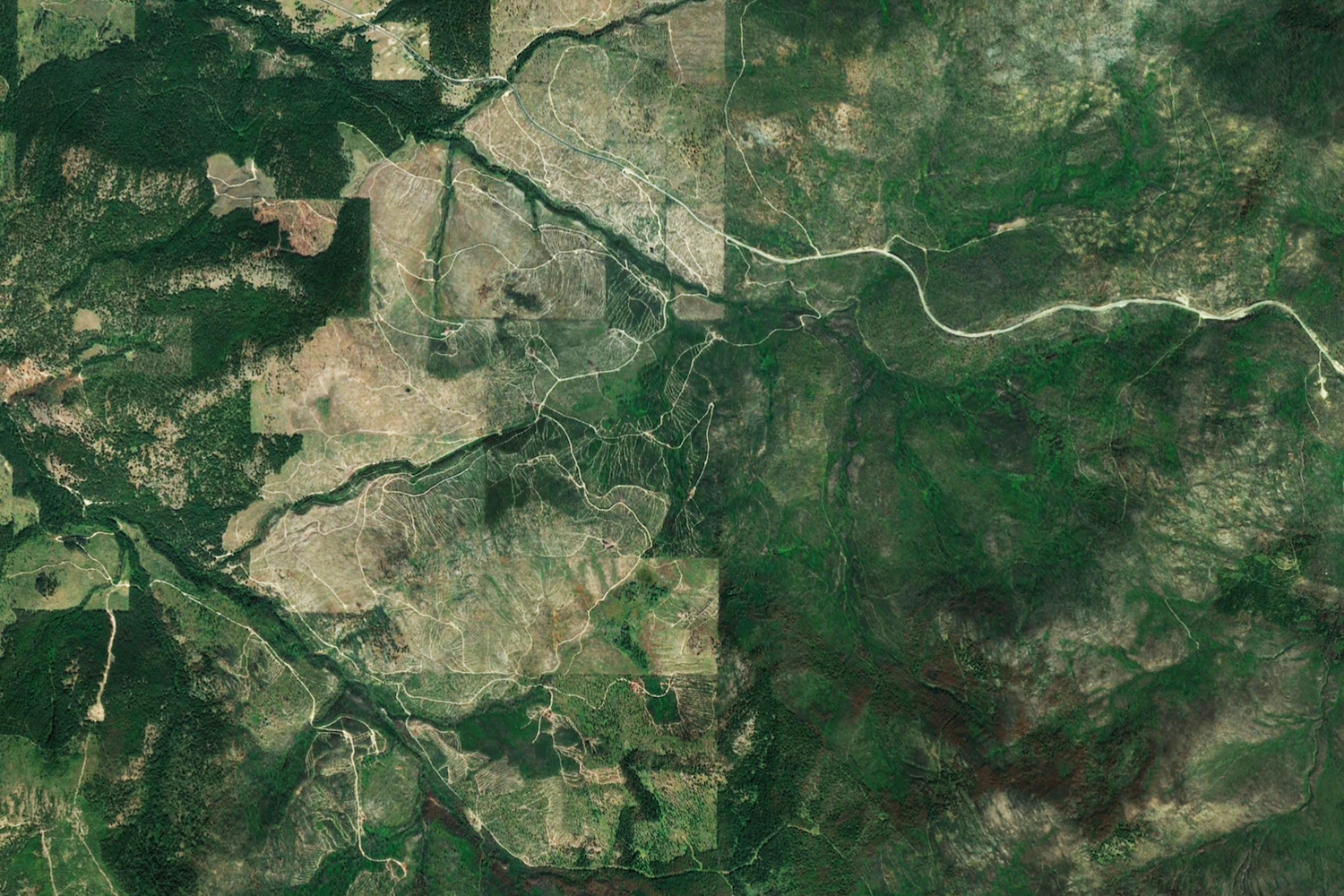Per una come me, nata alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, la sirena è una ragazza-pesce carina e un po’ naif che rifiuta il proprio mondo acquatico e in cambio della propria voce ottiene un paio di gambe per andare sulla superficie terrestre alla ricerca del suo principe, una versione mora di Ken. Ma lasciando da parte l’eccezione creata dalla Disney e ispirata alla fiaba di Andersen (che, spoiler, non ha il lieto fine disneyano), le sirene della letteratura sono in genere le carnefici, mai le vittime.
Da dove nasce l’idea della sirena, così popolare nella storia dell’umanità? Che cosa ha spinto l’uomo (e uso questo termine non a caso) a immaginarsi una creatura metà donna metà animale (a volte uccello, a volte pesce), che prima seduce e ammalia l’uomo che la incontra, per poi rivelarsi nella sua vera natura di mostro spietato e letale? Quale paura viene esorcizzata da questa figura mitologica, presente in molte epoche e molte culture? Per trovare una risposta è utile osservare che, nella maggior parte dei casi, la narrazione vuole che le sirene usino le proprie abilità seduttive con un secondo fine, quello di ingannare e uccidere il malcapitato che cede alle loro lusinghe. Solo per citare due esempi: nell’Odissea di Omero le sirene tentano con il loro canto di attirare la nave di Odisseo contro gli scogli; nel racconto di Tomasi di Lampedusa che dà il titolo a questa mostra, Lighea, pubblicato postumo nel 1958, il protagonista muore in mare, attirato un’ultima volta dalla sirena di cui era stato amante in gioventù.
Questo avviene perché per gran parte della storia l’umanità è stata definita dal genere maschile, bianco e eterosessuale. Per tutto questo periodo, ciò che non è rientrato in questo canone è stato considerato non umano, in primis le donne. È dall’esclusione della categoria di umano che nascono creature come le sirene. Le sirene sono mostruose perché non si sottomettono al desiderio dell’uomo che le avvicina, anzi: lo ingannano per soddisfare il proprio piacere, e poi lo uccidono senza scrupoli. Proseguendo nella metafora, le donne sono esseri mostruosi, sovversivi, specialmente quando non si sottomettono al desiderio dell’uomo e, per estensione, alle richieste del patriarcato.
Sono sovversive le ragazze che popolano una Ghibellina Nuova abbandonata dagli uomini nel video di Elisa Giardina Papa (1979, Messina) U Scantu”: A Disorderly Tale. Un racconto per immagini che si ispira ad alcune figure della tradizione orale siciliana, le donne di fora e le inciarmatrici. Ambiguamente in bilico tra i generi e le specie, queste donne hanno corpi non conformi e per questo vengono perseguitate dall’Inquisizione tra il XVI e XVII secolo. Nel video un gruppo di ragazze adolescenti percorre le strade della utopica città ricostruita dopo il terremoto del 1968, a cavallo di biciclette personalizzate con impianti stereo. In mostra Giardina Papa rende omaggio a queste figure della tradizione siciliana con due sculture in ceramica smaltata – una lunga treccia bianca che spunta dalla parete, l’altra troneggia su un piedistallo – che ci ricordano una delle tante metamorfosi di cui queste donne vengono ritenute capaci, la trasformazione dei propri capelli in spire di velenosi serpenti.
Sono corpi non conformi quelli dipinti da Carla Grunauer (1982, Tucumán): l’artista argentina tratteggia figure ibride in cui umano, animale, vegetale e robotico si fondono in unico ammasso fluido. Colature di inchiostro definiscono i contorni di quelli che sembrano ectoplasmi diafani e dalla forma incerta, che galleggiano sulla superficie della tela in uno spazio privo di profondità. Come per le donne di fora, individuare e nominare con certezza quale sia la natura delle abitanti di questo mondo pallido è impossibile, e per questo motivo sembrano mostruose. Alcune hanno la testa di uccello e il corpo di un essere umano, altre sembrano crescere all’interno dei ventri oblunghi di funghi dai colori pastello, altre ancora si contorcono sotto il peso di arti sproporzionatamente gonfi. Tutte sembrano appartenere allo stesso momento a un passato remoto e a un futuro inconoscibile, di certo non al tempo presente. Allo stesso modo delle sirene queste creature deformi e metamorfiche risultano sensuali e mostruose, seducenti e respingenti, ai margini di un sistema patriarcale in cui il canone estetico è definito dall’uomo, bianco, abile e eterosessuale.
È proprio il canone estetico così definito quello da cui parte Andreia Santana (1991, Lisbona) per concepire e realizzare le sue opere. Santana guarda al mondo dell’archeologia e ricerca i reperti tralasciati dal racconto storiografico, perché non funzionali nella trasmissione della Storia, uniformemente eurocentrica e colonialista. Il risultato di questa indagine sono opere che ricordano fossili di animali impressi sul fondo del mare solidificato dai millenni, ma la loro iridescenza suggerisce una provenienza diversa, quasi aliena. Il vetro stesso ha una natura ambigua: pur sembrando solido è in realtà un fluido, e il suo stato è instabile. Altrettanto mutevole è l’identità di queste creature opaline, che sfuggono alle categorizzazioni binarie con cui siamo abituati a nominare il mondo.
La sirena rappresenta tutto ciò che sta in bilico tra gli opposti: bello e brutto, maschile e femminile, seducente e mostruoso e con questa indefinitezza mette in discussione, come le opere in mostra, il nostro modo di esplorare e conoscere il mondo.