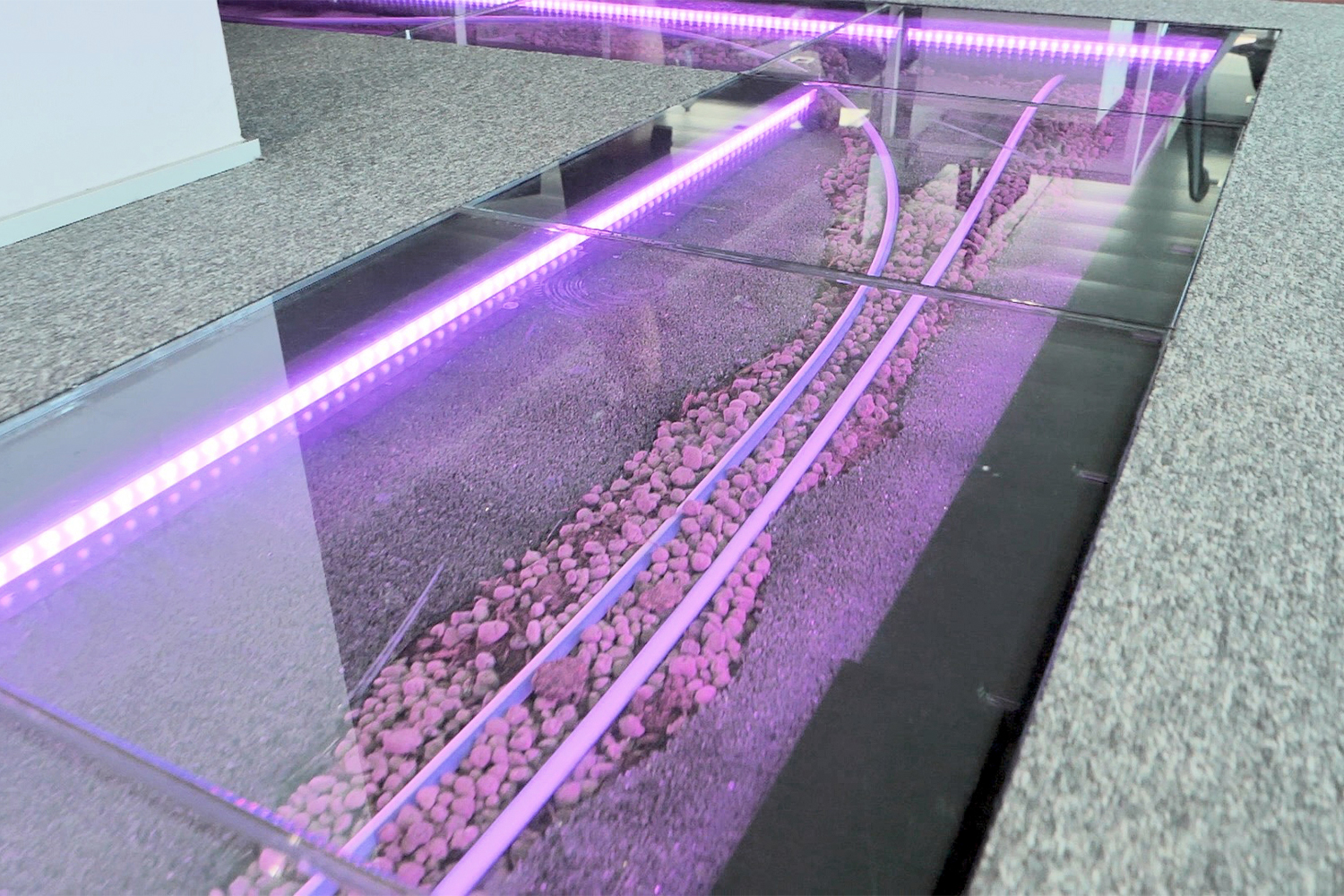Bologna, martedì 16 dicembre. Per la chiusura di stagione Xing presenta negli spazi di P420 la performance High Gear di Kidows Kim, artista sud-coreano, alla prima apparizione in Italia. L’atmosfera è algida, sospesa. Del fumo bianco galleggia nel white cube svelando al passaggio del pubblico un’installazione. Un volto sfocato, a metà tra la rappresentazione di uno spirito e un ritratto hyper-pop, è stampato su un grande tessuto tecnico disteso a terra, da cui si estendono nello spazio delle catene, organi di trasmissione come lunghe budella. Una coda più lunga si conclude in una scultura, un fagotto grottesco o i resti di un costume rituale, con lembi di tessuto che intrecciano la catena a maschere e capelli di plastica. In scena c’è una figura, che accoglie il pubblico all’ingresso, chinata sulle mani, porge il culo e si muove a ritroso, scrutandoci come un demone Shirime.
High Gear è il terzo capitolo di una serie di performance in corso – inaugurata da Funkenstein nel 2021 e proseguita nel 2023 con Cutting Mushrooms – con cui Kidows Kim esplora e incorpora figure della mostruosità, tra processi di metamorfosi, rimediazione e reincarnazione, immaginari animisti e scenari stranianti, eerie. Ogni performance compone una nuova figura, un’immagine ambientata, attraverso cui l’artista rielabora memorie personali e collettive, ibridandole a fonti tratte in particolare dal mondo dei manga e del cinema giapponese di genere distopico, cyberpunk, horror. Un universo visivo in cui l’artista è cresciuto e che ha segnato la cultura sud-coreana a cavallo del millennio, quando il paese si è aperto ai prodotti giapponesi, proprio mentre viveva la violenta trasformazione sociale che dal miracolo economico ha portato alla crisi finanziaria e a una nuova accelerazione dell’industria hi-tech. Traducibile proprio in marcia alta, a pieno regime, a tutto ritmo, High Gear si struttura drammaturgicamente su uno schema a quattro scene ripreso dal yonkoma manga, sviluppando altrettante immagini che tematizzano un ciclo produttivista: nascere, mangiare, lavorare, morire.
Ancora chinata, la figura inizia a intonare frammenti di un canto monotono, a metà tra nenia e ninna nanna, distorto dalla pressione della posa sulla laringe. Cerca i margini della scena, si muove tra il pubblico, per poi alzarsi, aprendo la voce al canto una volta trovato l’angolo della stanza. La prima di quattro immagini, segnate da un magnetismo della presenza scenica che ammutolisce la sala, si conclude con un’interruzione netta: la figura siede tra gli astanti, distaccatamente, a osservare il centro della scena abitato dalla sola installazione. High Gear è un lavoro che oscilla tra quattro immagini, in movimento ma delineate come dai contorni di vignette animate, durante le quali questa entità produce intensamente e voracemente. Alle scene si infiltrano però momenti di sospensione, che sembrano trascinare in una pausa lo svolgersi, per osservare e riflettere sullo stato raggiunto, quindi rivisitarlo. Dopo il nascere, viene il mangiare, anche se tutta la performance ricorda fortemente un processo digestivo, viscerale, tra il moto di fluidi, momenti di passaggio come tra membrane, e vuoti come cavità. La figura rientra e inizia a consumare abiettamente un liquido lattiginoso, tra gorgoglii, risucchi e spruzzi, che ricordano le vomitate da allattamento, ma anche un rito apotropaico. È un’immagine che viene prolungata, che insiste sull’attenzione e sfida la misofonia, concludendosi nuovamente con un’uscita tra il pubblico, che rispecchia la postura ora riflessiva. La figura dà quindi vita una nuova animazione: lavorare.
L’avvio della terza immagine coincide con l’ingresso del suono: stratificazioni di tracce che evocano un locale notturno, infiltrazioni di sonorità organiche e amplificazioni elettroniche si fondono e alternano, risultando però sempre vagamente distanti, come provenissero da un altro piano. Il ritorno in scena è incentrato sulla manipolazione dell’installazione: la figura entra e raccoglie la scultura caudale, per appenderla al soffitto, dirigendosi quindi al volto impresso sul telo, che inizia faticosamente a caricare sul proprio corpo, insieme al resto delle lunghe catene, avvolgendo il tutto e sé in un pesante ammasso che si trascina mostruosamente, fino a modellare e appendere l’intera installazione ambientale in un’unica congerie. C’è un aspetto riflessivo negli elementi che compongono le protrusioni di questo ibrido corporeo – dagli oggetti alle vesti, fino al suono – in cui il groviglio si fa metafora non solo delle immagini messe in scena, ma anche dello stesso processo produttivo. Penso alla creatura Odradek di Kafka, per rimanere a riferimenti a me più vicini: un oggetto impossibile da visualizzare, una sorta di matassa ingarbugliata, che rispecchia i temi della sua letteratura, ma è anche metafora dell’approccio alla narrazione e autoritratto mostruoso. Questo rispecchiamento in High Gear si ritrova nell’attraversamento di un amalgama fatto di corpo, immagine, oggetto, suono e ambiente, che viene paradossalmente rafforzato dalla simmetria dello schema, perché abitato da una presenza magnetica che avvolge i lembi di ogni immagine senza soluzione di continuità.
La terza immagine si conclude proprio in un groviglio vocale, l’entità anima la scultura, insufflandola con un nuovo canto. Un ammasso di gorgoglii, espressioni viscerali, ma anche lamenti, pianti e urla che vengono rilanciati dall’impianto, facendoli collassare tra loro in una parete sonora che ha dei rimandi al noise e all’underground giapponese. Anche questa immagine si interrompe in una sospensione, a cui partecipa anche il pubblico nel silenzio corale, mentre il riverbero si va spegnendo, aprendo alla quarta e ultima immagine: la morte. Un volto disperato, trasfigurato dalla paura in un urlo muto, che potrebbe essere anche un pianto, sostenuto a lungo. Carico di espressività esasperata, ricorda forse più di tutto i disegni di un manga horror, ma anche le espressioni schematiche tipiche della tradizione Butoh. È l’immagine di una bocca forzata, ai limiti dell’estraneità, che si fa cavità e fagocita l’intero ambiente. Anche quest’ultima scena si conclude in un’uscita, che lascia nuovamente spazio all’installazione, rivelando i resti rimasticati da un ciclo produttivo che è stato chiaramente manomesso.
Nella Monstrarcheology di Kidows Kim, termine coniato dall’artista per descrivere questa sua pratica di scavo nel mostruoso, si incontra una corporeità che si distanzia inorganicamente dal vitalismo che permea molta performance incentrata sul corpo e la sua liberazione. L’installazione porta le tracce di distorsione, sovversione ed evocazione, un corpo ibrido che si nutre di limite, che non nasconde fragilità, sofferenza, disperazione, ma che mostra anche una via di fuga, ai margini, nella produzione di una singolarità mostruosa, per fagocitare meccanismi di programmazione del corpo, individuale e sociale. Un’immagine capace di congiurare, come un rito, inconscio collettivo e mondo interiore.