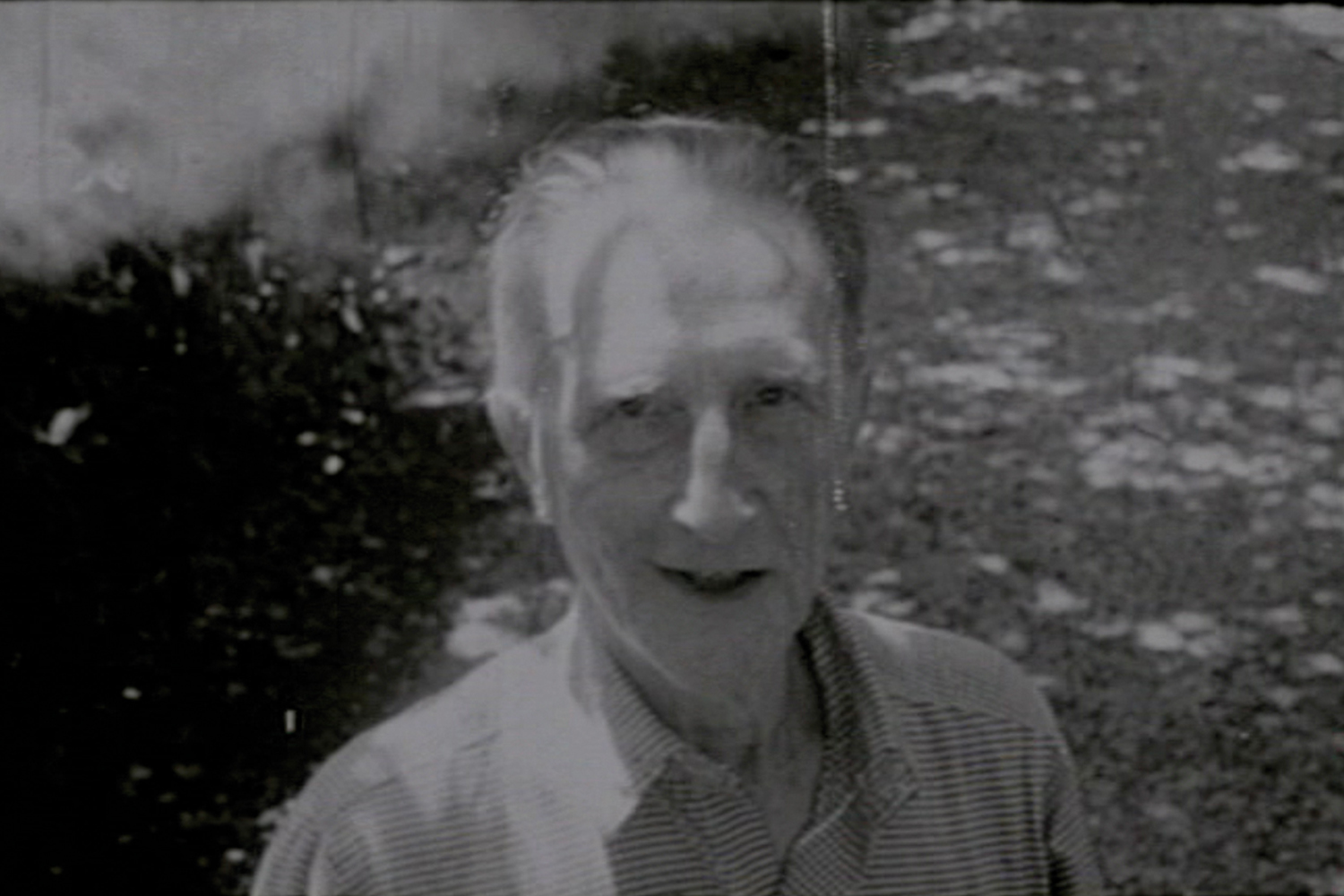Non è una mostra tra le tante la 7ma Biennale di Berlino. Non intende solo proporre la visione del curatore rispetto a un tema, come la maggior parte delle biennali dei nostri tempi, ma vuole segnare una svolta nel modo di fare arte. O addirittura nel concetto stesso di arte.
Con questi presupposti rivoluzionari si è messo all’opera il curatore, l’artista polacco Artur Żmijewski, celebre per opere che indagano la vita sociale e toccano tematiche scottanti. Berek, un suo vecchio video del 1999, che mostra un gruppo di persone nude rincorrersi e darsi delle pacche all’interno di una camera a gas, era stato rimosso tra le polemiche da una mostra al Martin Gropius Bau di Berlino proprio pochi mesi fa. E tanto per chiarire che non ha nessuna intenzione di cedere su alcun punto di principio, lo stesso video, da curatore, lo riespone ora nella sua Biennale. Con lui, a co-curare la mostra, Joanna Warsza, giovane ricercatrice polacca, e il gruppo Voina, gli attivisti russi autori di azioni che scuotono la cappa di conformismo politico post-sovietico attraendo i riflettori dei media. È famosa l’orgia scatenata nel 2008 nel museo di Biologia di Mosca alla vigilia delle elezioni di Medvedev, così come il grande fallo di 63 metri dipinto sul ponte levatoio che si è poi alzato di fronte all’edificio del Kgb a San Pietroburgo. Imprigionati, poi rilasciati ma con decine di cause pendenti, non sono stati avvistati all’opening della Biennale, ed è probabile che la loro presenza curatoriale sia più simbolica che altro, quasi un modo per sostenere la causa attraverso un incarico istituzionale.

Con questi presupposti poco rassicuranti, anticipata dalle polemiche per la raccolta di libri di seconda mano del politico tedesco Thilo Sarrazin a opera dell’artista ceco Martin Zet per farne, forse, un pubblico rogo, la Biennale si è aperta lo scorso 27 aprile con una conferenza stampa gestita da gruppi di Indignados e di Occupy. E quasi facendo un’autoanalisi, riconoscendo i limiti burocratici e la paura istituzionale con cui ogni cambiamento deve fare i conti, è stata intitolata “Forget Fear”. Un auspicio ad andare avanti senza paura della novità. Visitando la mostra, a dire il vero, sul piano del linguaggio non sembrerebbe esserci nulla di nuovo. Quando si salgono le scale del KunstWerke, di piano in piano si osservano installazioni dall’aspetto simile a quelle di tante altre mostre o biennali. Le tende e i banner dei vari Indignados e Occupy che sono stati invitati a utilizzare liberamente lo spazio al pianterreno non sono molto diverse da quelli di “Utopia Station”, la sezione aperta allestita da Judith Nesbitt, Hans Ulrich Obrist e Rirkrit Tiravanija nella Biennale di Venezia del 2003. Al primo piano, il timbro per passaporto e il francobollo dello stato palestinese inesistente di Khaled Jarrar sembrano solo l’ultimo di una lunga serie di falsi documenti che hanno invaso da sempre il mondo dell’arte. A fianco è allestito un workshop per la riproduzione della grande testa del Cristo di Świebodzin. Il Cristo originale, dello scultore Mirosław Patecki, svetta nella cittadina polacca al confine con la Germania per 65 metri di altezza. Ma la scultura in corso di lavorazione l’avevamo già vista a opera di Monica Bonvicini alla Biennale di Venezia del 2005, per non parlare delle decine, centinaia di work in progress di vario tipo a cui le mostre degli ultimi anni ci hanno abituato. Poi ci sono alcune foto di una torretta di legno nella foresta congolese a opera dell’Institute for Human Activities, e ancora bandiere di movimenti illegali nei vari paesi, e il tema della guerra del narcotraffico con le copertine di un tabloid di Ciudad Juárez raccolte da Teresa Margolles: una lunga reiterazione di immagini di omicidi e donnine seminude. Continuando a salire, si arriva nella sala di “Breaking the News” con immagini video di proteste e azioni di guerriglia urbana, dalle rivolte egiziane alle nudità delle Femen ucraine. Sala densa di energia, che però assomiglia a un ampliamento di un lavoro dello stesso Żmijewski, Democracies, in cui l’artista documentava proprio una serie di proteste in giro per il mondo. Anche i cartoons che accompagnano la salita lungo le scale, opere dell’artista bielorussa Marina Naprushkina, non sono all’apparenza molto diversi da quelle di altri artisti che utilizzano il medium dei comics, da Raymond Pettibon a Dan Perjovschi. E quando si esce, la grande chiave del ritorno realizzata da profughi palestinesi, come emblema di speranza di rientro nelle proprie case e ora collocata nel cortile del KW, potrebbe sembrare un Oldenburg da bricolage fai da te.

In realtà, ciò che caratterizza tutti questi elementi — chiamiamoli pure opere — è che la loro presenza al KunstWerke è solo l’ombra di un’esistenza altrove, nel mondo reale. L’assunto di Artur Żmijewski è che l’arte debba interagire con la realtà, che le sue potenzialità non siano pienamente esaurite quando viene esibita nelle mostre e nelle fiere, che debba attivare, produrre dei cambiamenti. Insomma che l’arte debba essere politica. Per questo l’artista polacco ha scelto lavori che vivono nel mondo prima ancora che in uno spazio espositivo, anche a rischio di perdere talvolta l’aura. Per questo ha coinvolto attivisti e situazionisti, prima che artisti con curriculum da gallerie e da musei. Gli Occupy e gli Indignados, il cui tentativo di reinventare una democrazia dal basso mostra tutti i limiti della naiveté politica (per non parlare di quella artistica), manifestano comunque un’opposizione al sistema giocata sulla propria pelle. Il timbro sul passaporto palestinese non è solo un gioco, un’invezione artistica, ma mette a rischio le persone (e sono già oltre duecento) che uscendo dai territori occupati lo usano come forma silenziosa di protesta — o di normalizzazione, visto che in effetti sarebbe normale avere un visto quando si esce da una nazione, se non fosse che i confini sono controllati solo da Israele. Il grande Cristo di Świebodzin non è frutto solo della megalomania di un artista, ma il prodotto di una volontà corale: quale consenso popolare, quale larga partecipazione di cittadini per riuscire a costruire una scultura di questa dimensione? La torretta e le foto africane sono immagini di un progetto che si sta svolgendo a ottocento chilometri da Kinshasa, dove si attua veramente un seminario sulle modalità di produzione e di commercializzazione artistica e si avvia un processo reale di gentrificazione nel mezzo della foresta. Le bandiere che penzolano dal soffitto stanno a rappresentare un convegno che si svolge realmente tra associazioni clandestine, tra cui Eta e Al Qaeda, per discutere i processi di messa al bando di organizzazioni definite terroristiche. Il collegamento diretto con la realtà vale per gran parte degli altri lavori presentati anche fuori dal KW, come il muro che divide la parte elegante e quella povera di Friedrichstrasse realizzato da Nada Prlja, il Draftsmen’s Congress nella chiesa di St. Elisabeth, progetto partecipativo in cui Pawel Althamer invita tutti a ricoprire le pareti con disegni, o i reenactment della Battaglia di Berlino prodotti da gruppi amatoriali polacchi usi a rappresentare scene di guerra in costume militare. Quello dei gruppi appare una costante di questa Biennale. È come se, quando si cercano le radici sociali e politiche dell’arte, questa tornasse a essere il prodotto di gruppi o di intere comunità. Come è stato nelle società primitive, o nel Medio Evo, quando l’artista era solo un anonimo mezzo di espressione di un valore generale. Anzi, in un certo senso la parte più tradizionalmente artistica, ovvero quei casi in cui appare più forte la definizione dell’opera come frutto di un’espressione individuale, è forse la parte più debole della mostra. Un carattere appare comunque evidente: la distanza dal mercato e dai tradizionali mezzi di assegnazione del valore. Non ci sono oggetti da vendere o comprare. Forse manca una direzione sicura verso una nuova definizione del valore artistico. Ma intanto la sovrapproduzione che fino a oggi ha invaso fiere e biennali appare già vecchia e sfocata, e la necessità di una ridefinizione della posizione dell’arte nella società si fa sempre più impellente. Questa 7ma Biennale di Berlino, che convinca o lasci con l’amaro in bocca, pone una questione imprescindibile. Da domani l’arte non potrà più essere la stessa.