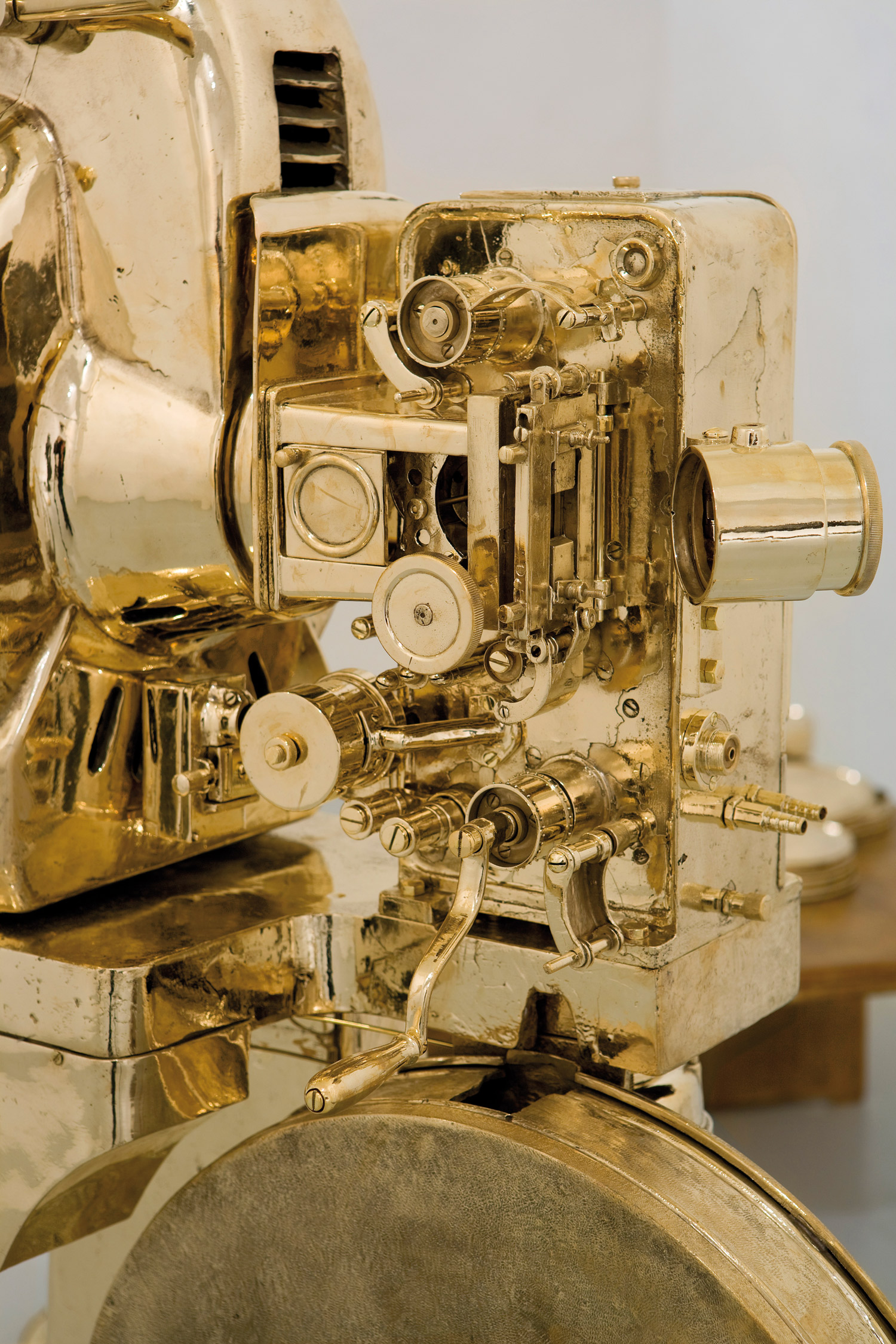In un famoso passo dei suoi Lineamenti di filosofia del diritto Hegel dice che quando la filosofia dipinge il suo grigio su grigio, allora una figura della vita è invecchiata — e non può più ringiovanire, ma soltanto essere conosciuta. Anche se queste parole possono suonare vagamente rassegnate, come se la conoscenza fosse qualcosa che non possiede la linfa vitale delle cose, ma solo un cromatismo spento che viene dipinto sopra di esse, come una mano di smalto, in realtà esse colgono con precisione non solo il ruolo del pensiero, ma anche quello dell’arte nell’epoca contemporanea. Se dipingere, oggi, non può più significare solo “esprimersi” o “creare”, ma piuttosto “conoscere” e “riflettere”, allora il colore adeguato a queste operazioni è proprio il grigio. Quest’ultimo, da non-colore, da cromatismo neutro e azzerante, in quanto media matematica di tutti i colori e loro negazione, diventa il fulcro dello spettro visibile, di cui i colori propriamente detti non sono che variazioni. E per quanto possa sembrare poco verosimile una tale convinzione, basterebbe una ricognizione veloce della pittura contemporanea, dai primi quadri cubisti di Picasso e Braque, con i loro monocromatismi grigi e seppiati, passando per le gradazioni grigie di Guernica, ai toni bassi di Ad Reinhardt, fino alle diluizioni pluriennali di Roman Opalka, e alle sfocature di Gerhard Richter, per capire che la natura “filosofica” del grigio ha conosciuto e conosce in pittura una sopravvivenza ben più che casuale.
Eppure, si potrebbe obiettare, il grigio — questa media imperfetta tra il bianco e il nero — è pur sempre lo spettro da cui una civiltà delle immagini come la nostra vuole ostinatamente sfuggire. La storia stessa dei mezzi di riproduzione, dalla fotografia, al cinema e alla televisione, agli schermi dei computer, insegna che, non appena è stato tecnicamente possibile, ci si è emancipati dalla visione in bianco e nero, per passare al colore — passaggio che retrospettivamente porta a identificare l’assenza del colore con una sorta di “povertà” del mezzo, una sua inadeguatezza di fondo. Il paradosso però, oggi, è che, nonostante abitiamo stabilmente in un regime visivo cromaticamente completo, siamo al tempo stesso insoddisfatti e oppressi, affamati di immagini nuove, ancora più brillanti, ancora più vivide, e nauseati dalla loro ossessiva, quasi asfissiante presenza. Proprio come i bulimici che, pur avendo in odio il cibo, ne vengono magneticamente attratti (e del resto il cibo moderno che consumiamo non è proprio additivato con coloranti che servono al solo scopo di catturare il nostro appetito?), anche nei confronti delle immagini soffriamo di un doloroso disordine alimentare che ci porta a consumarle con una specie di disperata e leggermente autolesionistica compulsione. Al punto tale che talvolta ci sorprendiamo a guardare con nostalgia una vecchia foto in bianco e nero come un temporaneo sollievo da questa “bulimia semiotica”.

Proprio in questo contesto si inserisce il lavoro di Adriana Jebeleanu. È stato acutamente notato che il grigiore stressato di certi sfondi, non ravvivato, ma semmai confermato dall’emergere di pochi toni cromatici (certi rossi, certi gialli apertamente “fasulli”), sia comune ad altri esponenti che provengono come lei dalla cosiddetta “scuola di Cluj” (la città rumena sede di una prestigiosa Accademia d’Arte) — “come se una certa imagerie socialista fosse rimasta incollata all’immaginazione” (cfr. A. Mugnaini, in Il cammino dell’ombra, testo in catalogo). D’altra parte, comincia anche ad apparire più chiaro che proprio certe aree dell’Europa dove il “capitalismo semiotico” non ha ancora completamente attecchito (o è un fatto ancora troppo recente) sono quelle in cui una riflessione artistica sulle immagini è ancora possibile. Come accade per una sempre crescente parte della nuova generazione artistica, non è più importante focalizzarsi su un determinato medium, quanto dedicarsi a una rilettura di ciò che le immagini mostrano di volere — tornare al filosofico “grigio su grigio”, per costruire una pausa di riflessione, e di “indisponibilità”, che sia anche una indicazione dietetica “iposemiotica”.

Per riprendere il titolo di un famoso saggio di William J. Thomas Mitchell, What Do Pictures Want?, si potrebbe dire che Jebeleanu prova a rispondere con il suo lavoro a questa pressante domanda: che cosa vogliono veramente da noi le immagini che quotidianamente assediano la nostra vita e il nostro sguardo? I suoi cicli pittorici, “Who Is Who” e “Good Times. Bad Times”, tentano di articolare una complessa risposta a questo angosciante interrogativo. L’impiego di una tecnica immediata e insieme sofisticata, la parziale cancellazione dei volti, il (falsamente) distratto sgocciolamento della materia cromatica, l’impiego apparentemente casuale di formati diversi, l’attenzione all’opacità dei segni, conducono lo sguardo di chi osserva a domandarsi in una luce inedita il significato di emblemi, loghi, sigle, archetipi, oggetti che già ci sembra di avere visto e rivisto. Nei suoi dipinti queste figure simboliche riaffiorano come doppi slavati e disciolti, e acquistano una incertezza fatale che li rende di nuovo interessanti, di nuovo degni di essere “osservati”. Il video Totally Love, in cui si vede una innocente tazzina finire straripante di sangue, mentre la voce fuoricampo ripete “My Blood / Your Food”, sembra indicare la risposta: le immagini vogliono proprio noi, vogliono il nostro sangue, la nostra vita.
Ecco perché il lavoro di Jebeleanu, teso a una “diluizione del significante”, acquista, oggi, un senso supplementare, non solo di carattere estetico, ma anche di resistenza critica all’esistente.