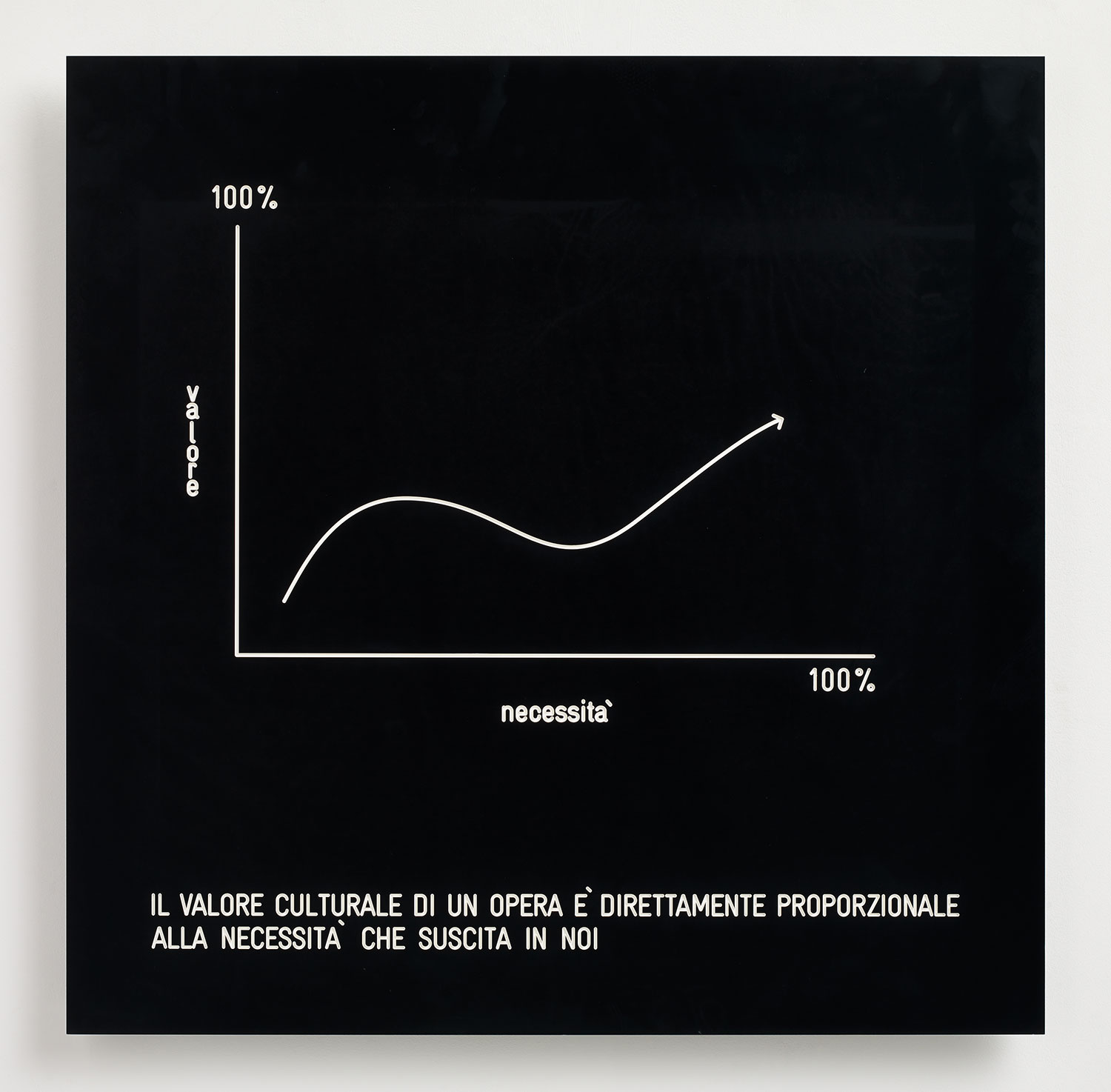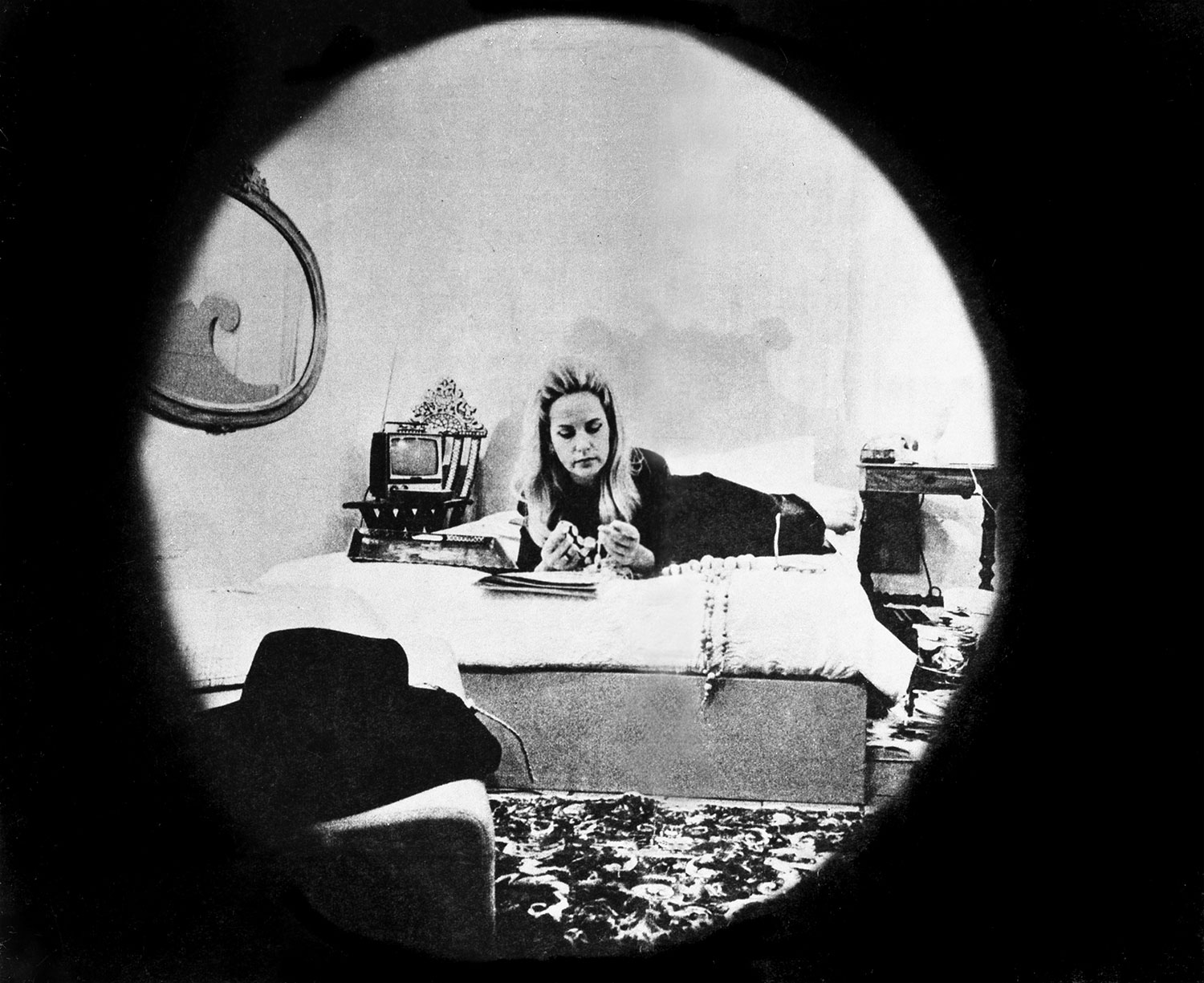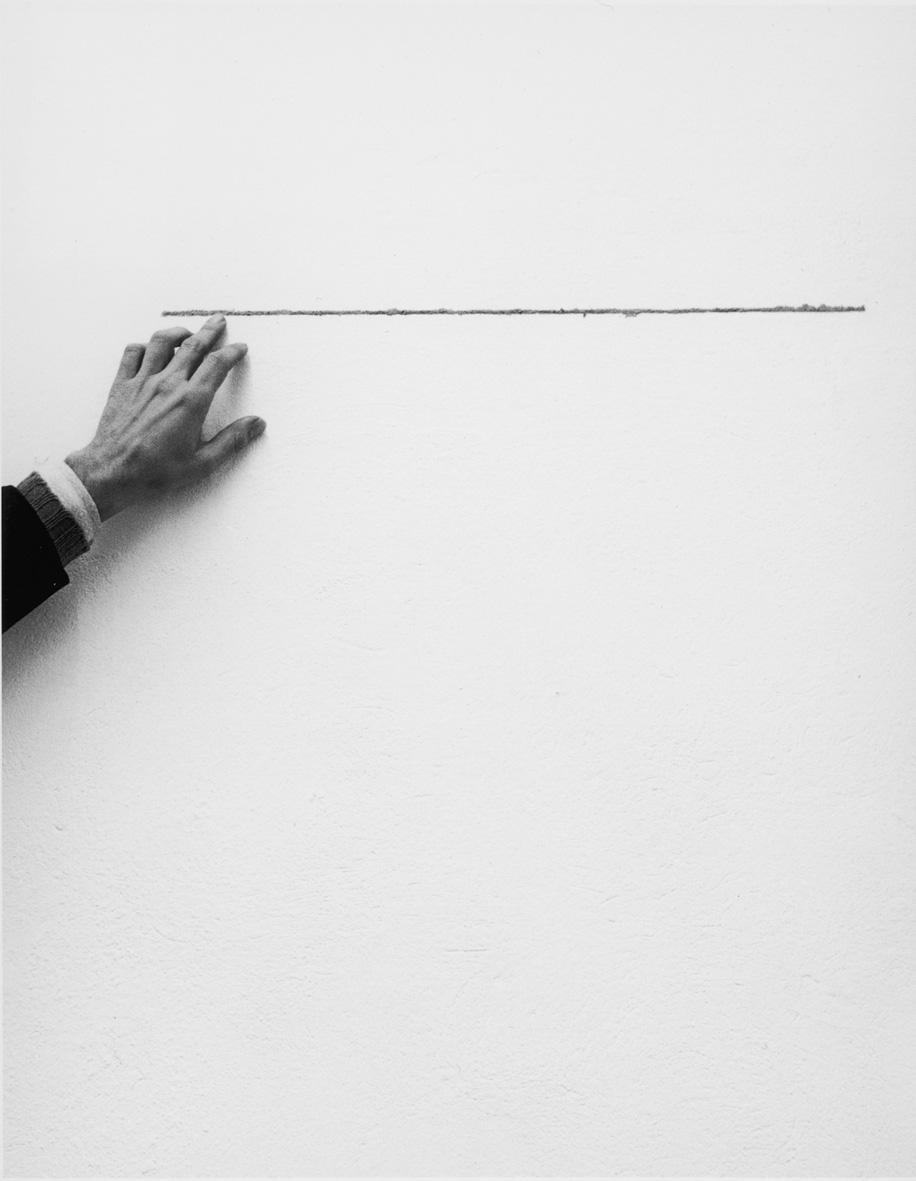Qual è il posto degli artisti africani contemporanei sulla scena mondiale e italiana? Per cercare di rispondere a questa domanda occorre guardare alle traiettorie individuali dei singoli artisti, ma anche al mercato e alla geopolitica del sistema dell’arte, alla posizione dei paesi africani nel sistema delle relazioni internazionali, alla loro diversità sociale e culturale e all’“Africa” come prodotto dell’immaginario globalizzato.
L’arte contemporanea africana ha attraversato il panafricanismo post-indipendenza, il neo-primitivismo degli anni Novanta, il postcolonialismo e concettualismo promosso da curatori di origine africana come Okwui Enwezor, per divenire oggi parte integrante dell’arte globale. L’enfasi si è spostata dall’autenticità all’ibridazione, mostrando il carattere diasporico e plurale di artisti che sempre più vedono nell’“africanità” non un destino, ma un’eredità culturale composita che sta tutta dentro la modernità e che, selettivamente, si può assumere o lasciar cadere o mixare, in quanto cittadini del mondo e in quanto artisti alla ricerca di una propria strada.
Non è però solo questione di poetiche ed estetiche individuali, ma di politiche culturali, della domanda del mercato globale e della committenza internazionale, di neocolonialismo e della fragilità del mondo dell’arte contemporanea in Africa. È dentro questo campo di forze che gli artisti africani negoziano i propri spazi di libertà e la propria autonomia espressiva.
Ivan Bargna: Organizzata al Centre Pompidou di Parigi nel 1989, “Magiciens de la Terre” fu un’esposizione che, fra le prime in Europa, portò (non senza qualche ambiguità e molte critiche) numerosi artisti africani sulla scena internazionale. È possibile oggi, a distanza di quasi trent’anni, tracciare un bilancio critico della strada percorsa? Gli artisti africani hanno portato un contributo riconoscibile e significativo all’arte contemporanea globale?
Elvira Dyangani Ose: Probabilmente si dovrebbe cominciare con il riconoscere il carattere dell’arte africana e lo status degli artisti africani presentati in questa mostra. Gli organizzatori di “Magiciens de la Terre” hanno visto l’Africa attraverso la lente di una nostalgia mistificata, sotto un persistente esame antropologico e una continua scoperta. Gli artisti soddisfacevano il concept curatoriale solo se autodidatti, rurali e, in certo senso, “oggettivati”. L’uso di quelle che erano definibili come tecniche ed estetiche occidentali era motivo di esclusione. Al tempo, quei curatori non presero in considerazione l’importante lavoro di artisti moderni come Ernest Mancoba, Gerard Sekoto, Malangatana Ngwenya o Ibrahim El-Salahi, solo per citarne alcuni tra quelli invece ben noti alle scene artistiche di Parigi e Londra. Detto ciò, le critiche sollevate da quest’esposizione hanno prodotto straordinarie mostre di reazione: “The Other Story” (Hayward Gallery, Londra, 1989), “Seven Stories of Modern Art” (Whitechapel Gallery, Londra, 1995) e “Otro país. Escalas africanas” (Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 1995). In tali progetti sono emerse preoccupazioni più profonde — questioni riguardanti la razza, le politiche di rappresentazione e l’identità culturale – che hanno contribuito a dibattiti già in corso sull’autenticità, l’africanità e la blackness. Per la prima volta, il cosiddetto “altro” fu sia narratore che protagonista. A organizzare la gran parte di questi progetti furono infatti artisti, curatori, pensatori, e altri tipi di operatori culturali non occidentali. Tale contributo a una estetica globale post-coloniale è ancora molto presente e vivo, anche a più di vent’anni di distanza.
Marco Scotini: A “Magiciens de la Terre” sono già stati dedicati troppi convegni internazionali e pubblicazioni importanti mentre si dovrebbe procedere a un suo ridimensionamento. Prima di tutto quella mostra non è pensabile senza “Primitivism” del 1984-85 al MoMA di New York, curata da William Rubin e Kirk Varnedoe. Tantomeno è scorporabile dalle tendenze occidentali anni Ottanta che celebravano la pittura dei Nuovi Selvaggi, rileggevano Beuys in termini esclusivamente sciamanici e declinavano in senso vitalistico ed energetico il portato dell’Arte Povera. Diciamo che tutto ciò era la risposta neoarcaica alle innovazioni sociali che stavano premendo con la globalizzazione. Eppure Edward W. Said aveva già scritto Orientalism (1978), e i “subaltern studies” e le teorie di Stuart Hall sono degli stessi anni Ottanta. Dunque perché mettere quella mostra in prima fila? Di fatto se un merito la kermesse francese l’ha avuto è stato quello di generare tutte le spinte avverse che gli hanno fatto seguito, come correttamente fa notare Elvira. Perché poi sono stati gli artisti e i curatori africani a volersi autorappresentare e di strada ne è stata percorsa tanta, fuori e dentro il continente. Ricordo che agli inizi del 2000 ho incontrato un artista come Meschac Gaba che mi raccontava quanto gli era costato negare la propria partecipazione all’invito di André Magnin e Jean-Hubert Martin; ma, d’altra parte, non si sentiva, tantomeno avrebbe desiderato essere, “un mago”.
Iolanda Pensa: La carriera dell’artista Frédéric Bruly Bouabré (1923 – 2014) è l’esempio più straordinario di quanto ricco e articolato, riconoscibile e contraddittorio, sia il percorso degli artisti africani. Oltre alla Documenta e alla Biennale di Venezia, Bruly Bouabré ha partecipato a “Magiciens de la Terre”, un’esposizione che come gli artisti africani si rinfresca ogni volta che se ne parla, visto che ognuno la racconta un po’ come gli pare e se la ricorda senza averla vista. Bruly Bouabré è un protagonista della storia dell’arte con opere fatte di disegni e segni, di un nuovo alfabeto e profezie, di densità e fragilità; è un artista che con la complessità e l’intensità della sua opera è stato apprezzato da tantissimi e – ognuno con il suo sguardo – ha trovato in lui quello che cercava. Lo studioso Cédric Vincent ha analizzato l’arte contemporanea africana attraverso la personalità e l’opera di Frédéric Bruly Bouabré, che ha senza dubbio dato un contributo riconoscibile e significativo all’arte contemporanea globale, ma attraverso un percorso che magari sarebbe stato meno lungo e tortuoso se non fosse stato africano.

IB: Oggi le mutate congiunture economiche e geopolitiche hanno posto in primo piano i cosiddetti paesi emergenti (BRICS e “tigri asiatiche”) e il mondo arabo. Come si riposizionano gli artisti africani in questo contesto? In che misura l’accrescersi o restringersi della loro visibilità internazionale dipende dalle agende politiche e dagli interessi economico-finanziari sull’Africa?
IP: Nell’archivio della Fondazione Ford ho trovato un documento del 27 luglio 1975 in cui dopo aver ricevuto una proposta di ricerca da parte del poeta nigeriano Wole Soyinka, Haskell Ward dice con un memo interno a Robert Edwards e Melvin Fox che avrebbero dovuto approfondire cosa stava succedendo nel campo della cultura in Africa per decidere se finanziarlo (Inter-Office Memorandum, 27/07/1975, 76-334, Ford Foundation Archives). Il sostegno da parte di istituzioni e nazioni estere alla cultura africana è legato a interessi politici e diplomatici, ma è essenziale capire che è molto limitato e a volte – come è emerso dalle mie ricerche in questo campo – influenza più di quanto non finanzi. In altre parole capita piuttosto spesso che artisti e curatori usino determinati termini e messaggi (e una formulazione delle loro opere “a progetto”) senza rendersene conto, rispondendo a interessi di cui non necessariamente beneficiano. Un discorso diverso invece va fatto per l’acquisto di opere e l’emergere di nuovi mercati, importante per capire altre dinamiche internazionali e di posizionamento degli artisti africani.
MS: Sicuramente la scena artistica africana può contare ben poco sul mercato locale, se si escludono alcuni grandi collezionisti come Sindika Dokolo o Lionel e Marie-Cecile Zinsou. Per questo è noto che tutta l’arte prodotta in Africa (nel passato e nel presente) non rimane nel continente: mancano gli strumenti per captare e ricondurre questa produzione all’interno di una struttura valorizzativa. Il primo decennio del nuovo millennio ha visto comunque una proliferazione di artisti, istituzioni e mercati – dal Sudafrica, al Congo, al Senegal – per ragioni diverse, ma anche in conseguenza di congiunture economiche a livello internazionale. Nel caso del Sudafrica esiste un mercato interno; nel caso della Repubblica Democratica del Congo l’apertura di grosse miniere, il boom dell’informatica e la crescita smodata della presenza cinese in Africa sviluppano interessi che si ripercuotono anche sul sistema dell’arte contemporanea. Invece la situazione del Senegal e di Dakar può essere spiegata per la presenza di un terreno già preparato dal punto di vista governativo grazie a una figura come l’ex-presidente-poeta Senghor.
EDO: Di fronte a questo scenario è necessario menzionare anche il costante interesse – la necessità, quasi – per lo “spettacolo africano”, che sembra ancora emulare quelle mostre dei primi anni Novanta. Le grandi esposizioni, a mio avviso, nel tentativo di delineare un’idea di Africa e di identità africana – con tutto ciò che questo implica – incorrono in un fallimento e evitano così una comprensione più profonda di ciò che gli artisti vorrebbero comunicare. L’ironia è che senza queste mostre alcuni artisti, e in particolare quelli emergenti, sarebbero stati scoperti molto più tardi.
IB: Una delle difficoltà che gli artisti contemporanei africani hanno dovuto affrontare è stata quella dell’immaginario primitivista occidentale, etnocentrico e stereotipato, che tendeva a risospingerli nel limbo dell’arte tribale, popolare o naïf, limitando le loro possibilità di sperimentazione individuale: la richiesta di conformarsi a un’“africanità” esotizzante e immaginata, aveva la meglio sulla possibilità di affermarsi come “contemporanei”. Come gli artisti africani hanno saputo disattendere le aspettative e giocare con gli stereotipi culturali dentro cui rischiavano di essere chiusi? E in tutto questo, qual è stato il ruolo che hanno svolto i curatori?
MS: Da Yinka Shonibare è arrivata una delle risposte più immediate alla primitivizzazione dell’arte africana con l’africanizzazione dell’Occidente. Le sue comparse vittoriane vestite di ciré ribaltano completamente lo sguardo occidentale su se stesso. Ma lo stesso Meschac Gaba con il fantomatico Museum of Contemporary African Art ha giocato con lo stereotipo del museo etnografico e ha realizzato sale dedicate al cibo, al matrimonio, alla religione, alla musica e al gioco, sempre all’interno di importanti istituzioni museali occidentali. Lui stesso, sulla falsariga di Broodthaers, si è trasformato in direttore museale, mettendo in scena un classico processo di identificazione a matrice coloniale. L’estetica dell’accumulo di Pascale Marthine Tayou invece schernisce l’idea occidentale del feticcio e dell’arte tradizionale, trasformando le chincaglierie e i residui dell’urbano in oggetti del consumo turistico. Gli esempi potrebbero continuare ma è più importante capire come questa prima generazione emersa sulla scena internazionale abbia sfidato l’autenticità attraverso la fiction, e l’originalità attraverso l’ibridazione. La scena emersa dopo – John Akomfrah, Kader Attia, Sammy Baloji, Nidhal Chamekh – muove verso una ricostruzione archeologica e riscrive la propria storia come storia contaminata e colonizzata. Anche i curatori si sono moltiplicati – dai più noti Okwui Enwezor e Simon Njami fino a Bonaventure Soh Bejeng Ndikung – per promuovere zone di contatto e complesse articolazioni tra Nord e Sud. Forse hanno avuto meno forza da dedicare agli stereotipi.
IP: Nel 2005 ho provato a fare una mappa del sistema dell’arte contemporanea africana. Uno dei veri limiti è che solo negli ultimi anni i curatori hanno cominciato a consolidare una loro playlist di artisti. Tra il 1966 e il 2005 sono pochissime le ricorrenze e, in pratica, in ogni mostra si “scoprivano” nuovi artisti. Questo è un ostacolo sistemico all’emergere di una produzione; affinché un artista riesca ad avere una galleria e così posizionarsi nel mercato internazionale deve avere una produzione sufficientemente consolidata; guardando invece il portfolio di molti artisti africani quello che si nota è quanto sia varia la loro produzione. È un po’ come se provassero cose nuove e linguaggi nuovi a seconda delle occasioni. I curatori svolgono un ruolo chiave nel creare opportunità per consolidare la produzione degli artisti che scelgono e sostengono. Ma gli artisti vanno scelti e sostenuti. Il cacciatore di teste André Magnin che ha selezionato gli artisti africani per “Magiciens de la Terre” e poi per la collezione Jean Pigozzi è stato molto criticato per il suo sguardo considerato un po’ primitivista (per farla breve), ma in realtà ha scelto artisti apprezzati anche in altri contesti e ne ha veramente lanciato e consolidato la carriera, permettendo loro di affermarsi. (Un caso su tutti, Chéri Samba che in un’intervista ringrazia Magnin proprio a questo proposito).
EDO: Un’origine geografica non può essere assunta come categoria estetica. Gli artisti che producono opere in Africa e nell’ambito della diaspora non sentono necessariamente il bisogno di rappresentare la loro africanità e la loro blackness. Ciò non implica che non siano interessati a problematiche locali, alle storie e alle spiritualità. Curatori e altri operatori culturali sono fondamentali nello sviluppo di una scena contemporanea più variegata che impedisca agli artisti di cadere intrappolati dentro nicchie culturali. Anche se gli artisti hanno l’ultima parola, è difficile per molti di loro rifiutare una mostra per il rischio di essere incasellati in eterno all’interno di una singola categoria. Credo che gli artisti abbiano bisogno di credere che il loro lavoro sia più “grande” di tutto ciò. Come curatori, d’altra parte, dobbiamo sostenere gli artisti, ma anche essere ambiziosi, andare oltre la singola narrazione e offrire un più ampio, complesso e – perché no – complicato esercizio che rifletta sui vari universi contemporanei in cui tutti abitiamo.
IB: Colonialismo, tratta degli schiavi e migrazioni hanno portato l’Africa fuori dall’Africa, disseminandola nella diaspora, creando una molteplicità di identità che sono al contempo locali e transnazionali (Black Atlantic, African American, African Caribbean, Black British ecc.) che si sovrappongono solo parzialmente. Questo spazio, incerto e plurale, è anche quello in cui lavorano molti artisti africani contemporanei: uno spazio che non presume una pienezza ma una mancanza, non la purezza delle origini ma la mescolanza di un presente che è il risultato di una storia segnata dalla violenza. L’arte – come hanno evidenziato Stuart Hall, Paul Gilroy e tanti altri pensatori postcoloniali – è uno dei luoghi in cui oggi si negoziano e per-formano le identità culturali, lavorando nell’in-between delle immagini con cui si è stati rappresentati da altri (quelle razzializzanti dell’eredità coloniale) e di quelle con cui ci si vorrebbe rappresentare in futuro.
Presi fra un passato ereditato e un futuro da costruire, come si muovono a vostro parere gli artisti contemporanei che, a vario titolo, si richiamano all’Africa nella loro opera e nella loro biografia? Le loro prese di posizione politiche (quando ci sono) si giocano esclusivamente all’interno del sistema globale dell’arte (e per il pubblico dell’arte) o si connettono a movimenti sociali e politici dentro e fuori dall’Africa?
EDO: Penso che ci vorrà un’ulteriore tavola rotonda per affrontare le problematiche che sollevi! Gli artisti contemporanei non hanno necessariamente bisogno di rispondere a un’identità culturale e di accedere all’universo ontologico che la descrive; eppure, in qualche modo, essi potrebbero sentirsi – come afferma il filosofo senegalese Souleymane Bachir Diagne – “saldati insieme da una metafisica dell’inconscio collettivo”. Questa metafisica collettiva porta alcuni di questi artisti a connettersi a tutto ciò che eccede il tempo e lo spazio dell’opera o dell’esperienza artistica. I casi più fruttuosi presentano metodologie e attitudini che mirano a un’esperienza sociale trasformativa. L’impegno sociale, il lavoro collaborativo, la consapevolezza che l’arte è manifestazione di una collettività, al di là dell’individualismo dell’artista borghese, sono fondamentali a questo proposito.
IP: Attraverso segni e anche molta leggerezza, un’opera può creare collegamenti, sintetizzare. Tutte le storie umane sono complesse e per chi viaggia e vive tra più mondi, la distanza non fa che accrescere la complessità che siamo; allo stesso tempo le distanze permettono di vedere. Fernando Alvim e Rasheed Araeen, con vite ricche e complesse, sono certamente due esempi molto significativi di come il collegamento a movimenti sociali e politici per gli artisti non sia retorica ma una vera adesione – nel caso di Alvim ai movimenti panafricanisti e indipendentisti degli anni Cinquanta e Sessanta e della loro forza e carica espressiva; per Rasheed Araeen è invece essenziale conoscere la sua adesione alle Pantere Nere per capire il suo posizionamento rispetto alla geografia del mondo e a come nasce la rivista Third Text (poi a sua volta estremamente pionieristica e influente).
MS: Se si tiene fede al filosofo camerunense Achille Mbembe l’Africa esiste ancora solo come un’assenza. Dunque non è un caso che tutti gli attori della sua scena artistica siano figli della diaspora e che, come tali, abbiano voluto rappresentarsi. Pensiamo a un grande artista e film maker come John Akomfrah che ha fatto del trait d’union un fattore d’identità. Un collocamento percettivo che gli ha permesso di essere “cittadino” e “straniero” allo stesso tempo. Ma forse questa realtà attuale e post-coloniale è il segno di un più antico sdoppiamento che il soggetto africano ha dovuto esperire. Credo che sia proprio questo carattere anti-identitario a essere divenuto un modello per tutte le soggettività contemporanee globali, pur muovendo principalmente dall’Africa. Dopo di che non ha senso dove si è collocati. Di fatto lo sforzo di una nuova generazione di artisti e curatori è stato quello di aprire o gestire istituzioni nel loro paese d’origine. Penso a Abdoulaye Konaté che nel 2002 ha creato a Bamako il Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias, a Yto Barrada con la Cinémathèque de Tanger, a Bisi Silva con il Center for Contemporary Art a Lagos, a Koyo Kouoh con il centro per l’arte Raw Material Company a Dakar, a Fernando Alvim con la Triennale di Luanda, ecc.

IB: Veniamo all’Italia, paese che ha avuto in Africa una storia coloniale limitata e tardiva, ma non per questo meno violenta di altre. Oggi l’Italia, situata alla frontiera meridionale della Comunità Europea, appare sempre più esposta sull’Africa, ma ancora priva di quelle politiche culturali che le consentano di andare oltre la gestione dell’emergenza. L’arte e più in generale l’iniziativa culturale potrebbero svolgere un’importante funzione in tal senso: quali sono i luoghi, pubblici e privati, commerciali e no profit, attraverso cui sono prodotte e circolano? Vi sono a vostro avviso artisti africano-italiani significativi, che stanno svolgendo una funzione di “mediazione culturale” in tal senso? La Biennale di Venezia, che in più occasioni ha dato spazio ad artisti, curatori e collezionisti di origine africana (il “Padiglione africano” del 2007, le mostre “Authentic/Ex-Centric: Africa in and out of Africa” del 2001 e “Fault Lines: Contemporary African Arts and Shifting Landscapes” del 2003) ha svolto e può svolgere un ruolo rilevante?
IP: Credo che la creazione di occasioni per produrre sia essenziale e l’Italia purtroppo non è molto brava in questo. La Biennale di Venezia è un album di figurine ed esserci sicuramente fa bene agli artisti; personalmente credo che più della Biennale, la Galleria Continua di San Gimignano abbia avuto un impatto rilevante nel sostenere gli artisti africani in Italia, perché con competenza e un livello di professionalità molto alto ha scelto opere e protagonisti sui quali ha investito.
MS: La Biennale di Venezia purtroppo non ha una ricaduta (culturale, economica e sociale) su scala locale. Dunque l’Italia si trova sprovvista di istituzioni o iniziative che possano creare un tessuto e uno scambio interessante con quella che sta diventando una realtà imprescindibile per il prossimo futuro. Se si fa eccezione per un’istituzione non profit e molto attiva qual è la Fondazione Lettera 27, tesa a promuovere la formazione e la conoscenza con un focus sul continente africano, rimangono le gallerie commerciali che hanno fatto un grande lavoro negli ultimi anni: dalla già menzionata Continua a Primo Marella. Sul versante artistico vedo alcuni giovani afro-italiani immigrati o di seconda generazione come Délio Jasse, Maurice Pefura e Adama Sanneh. Dunque non c’è che da cominciare a tessere nuove trame.
EDO: È curioso quanto poco impatto abbiano avuto queste mostre veneziane sulla scena artistica italiana. Si potrebbe supporre che una conseguenza sia stata l’inclusione di più artisti africani nella mostra internazionale, nonché il recente interesse di iniziative private africane a essere presenti a Venezia durante la Biennale. “Authentic/Ex-Centric” e “Fault Lines” hanno evidenziato l’importanza della diaspora nel produrre una narrazione completa dell’arte africana moderna e contemporanea, sottolineando le posizioni degli artisti nei dibattiti sull’autenticità o esplorando le estetiche e le pratiche di rappresentazione associate al concettualismo. Tuttavia, al giorno d’oggi, le esposizioni individuali o tematiche o relative a media specifici sono rare. C’è molto da migliorare. Ricordo l’anno che trascorsi a Firenze, tra il 1995 e il 1996. La Spagna, in particolare le coste dell’Andalusia e delle isole Canarie, stava sperimentando la più grande ondata migratoria del decennio. E in Italia, dove l’immigrazione dai paesi africani stava aumentando, c’era una pesante atmosfera di diffidenza. In entrambi i paesi, comunità nere provenienti dai territori colonizzati vi abitavano già da generazioni. Questi individui sono a pieno diritto italiani e spagnoli. Tuttavia, la presenza dei nuovi arrivati ha compromesso un già debole equilibrio sociale. In ogni caso, questa questione avrebbe bisogno di più tempo e di ulteriori riflessioni, perché parte di quella tensione è ancora persistente… Si guardi alla vicenda del ministro Cécile Kyenge Kashetu.
IB: Marco, “Il cacciatore bianco. Memorie e rappresentazioni africane”, la mostra che hai organizzato per FM Centro per l’arte contemporanea di Milano, propone un percorso che mette al centro le opere degli artisti africani, ma che guarda anche alle immagini che dell’Africa hanno prodotto gli italiani in epoca coloniale: sguardi diversi che fanno intravedere storie e memorie discrepanti ma interconnesse. Questo filo conduttore però nella mostra sembra interrompersi dopo le prime due sale, quella dedicata al colonialismo italiano e quella sull’arte africana tradizionale, che rievoca la Biennale di Venezia del 1922. Questo filo potrebbe forse essere ripreso a partire dal fatto che gran parte delle opere esposte nelle sale successive, provengono da collezioni italiane: queste stesse collezioni – con i loro gusti e sguardi, selettivi e orientati – non possono essere viste come “memorie e rappresentazioni africane” degli italiani contemporanei? Detto altrimenti: come e perché si collezionano artisti africani in Italia oggi?
MS: Nonostante l’ambizione della mostra sia quella di decostruire lo sguardo occidentale sull’Africa, è stato importante partire da una posizione situata e, dunque, locale. Altrimenti sarebbe risultata un’ennesima operazione coloniale. La sala sulle conquiste italiane d’oltremare e la ricostruzione della saletta in Biennale sono solo un’introduzione all’esposizione per cui ci si sarebbe potuto chiedere “e dopo cos’è successo in Italia? In fondo settant’anni di colonizzazione non sono pochi: che cos’è rimasto di tutta quell’esperienza africana?”. È incredibile come l’Italia abbia rimosso tutto ciò, nonostante in molte città italiane si possono trovare ancora nomi come Piazza Adua, via Tripoli o Asmara, Piazzale Gondar. Eppure trenta milioni di italiani erano accorsi ad ascoltare il 5 maggio 1936 il discorso di Mussolini sulla vittoria su Addis Abeba e la proclamazione dell’Impero. Se si escludono le biennali veneziane dagli anni Novanta in poi, che comunque sono un’enclave internazionale, mostre sull’arte africana contemporanea in Italia non ce ne sono state, ad eccezione di “Why Africa?” alla Pinacoteca Agnelli nel 2007 che mostrava “i maghi” della collezione Pigozzi. E per il resto? Il fallimento del Museo delle Culture (MUDEC) di Milano, una pubblicazione inaspettata di Damiani curata da Enwezor, l’associazione Lettera 27 e poco altro. Ecco allora che ad aver fatto qualcosa sono soprattutto le gallerie e i collezionisti che “Il cacciatore bianco” mette in mostra.

IB: Elvira, ci siamo conosciuti nel 2013 a Douala, in Camerun, dove curavi un progetto di arte pubblica e partecipativa degli artisti Trinity Session, Nelisiwe Xaba e Faustin Linyekula in un quartiere popolare della città. Nel 2016 hai curato alla Fondazione Prada di MiIano la mostra dell’artista angolano Nastio Mosquito, “Template Temples of Tenacity”. Entrambi i progetti, per quanto molto diversi, prevedevano parti performative che sollecitavano un intervento del pubblico, chiamato ad attivare il dispositivo artistico. Che cosa cambia quando l’azione artistica e la curatela si spostano da un paese africano a uno europeo, coinvolgendo città e pubblici fra loro molto diversi?
EDO: In generale, nelle mostre e nei progetti che curo, cerco sempre di evitare di cadere in limitazioni conseguenti a qualsiasi retorica dell’“ noi e loro”. Questo perché il mio obiettivo è formulare progetti che vadano oltre ciò che Salah Hassan definisce la “‘Darkest Africa Syndrome” [sindrome dell’ “Africa più nera”], ovvero la distinzione tra i paesi del Nord Africa e quelli del Sud. Ho enfatizzato il ruolo della diaspora in una narrativa completa dell’identità Africana. Ho insistito sulla riformulazione di tutte queste categorie, che etichettano le identità e delimitano le terminologie, per rimarcare invece una nuova prospettiva dell’essere assieme, della consapevolezza del bisogno di una radicale solidarietà – in un periodo di lotte anti-coloniali e di discussioni sul postcolonialismo – e sull’establishment, ciò che Fred Moten chiamerebbe “coalizione”.
Gli artisti con cui lavoro di solito sono impegnati in questo genere d’approccio, quindi la distinzione non è tanto tra la produzione di progetti ambientati in Africa o Europa, quanto piuttosto tra le specifiche necessità della performance in questione e il contesto in cui prendono luogo. La Trinity Session è intervenuta in un quartiere in cui l’artista Goddy Leye nel 2002 guidò un gruppo di artisti e la comunità locale in un’esperienza di trasformazione urbana intitolata Bessengue City Project. Performando a Bessengue, Trinity Session ha attivato un senso di “rituale come istituzione” già presente all’interno di quella comunità. La vita di tutti i giorni si era intromessa. Nel caso di Nástio Mosquito alla Fondazione Prada ciò che si era intromesso era il campo dell’arte.