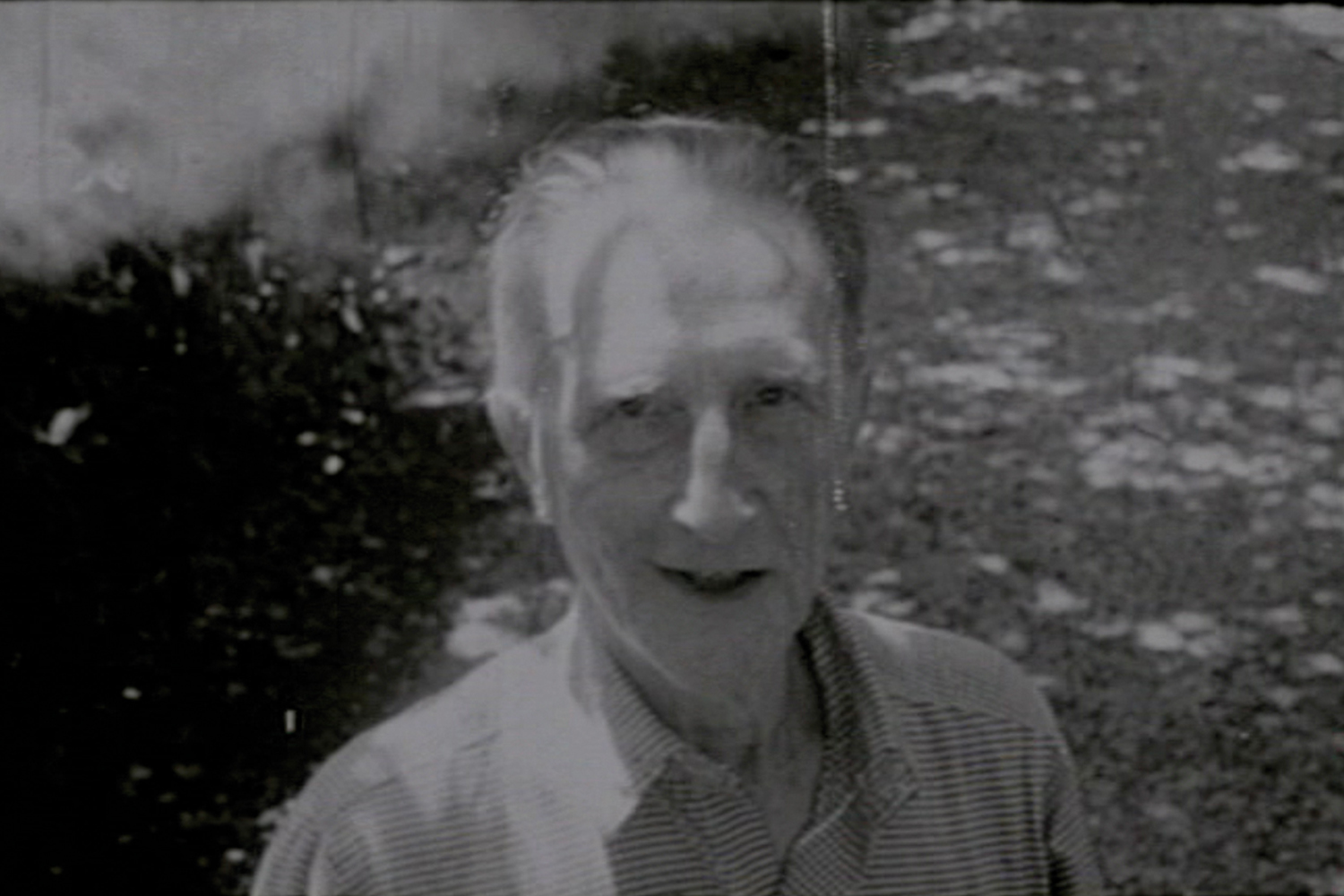La propensione di Alexander Heim (Amburgo, 1977) a fare affidamento su diverse soluzioni formali ha trovato un punto di convergenza in The Great Plastic Vortex (2011), un’operazione articolata, ma non inaccessibile, che è stata presentata per la prima volta a Statement in occasione di Art Basel lo scorso giugno. Ispirato a un fenomeno semi-naturale noto come “Pacific Ocean Garbage Patch”, un’area al centro dell’Oceano Pacifico dove grandi quantità di spazzatura si stanno accumulando seguendo un percorso a spirale dettato dalle correnti, fino a formare una vera e propria isola artificiale. Il lavoro di Heim indagava questo singolare incidente da lontano, utilizzando come punto di partenza elementi presi dalla realtà più ordinaria e trattandoli come singoli frammenti destinati a formare un inquietante mosaico. Una video proiezione raffigurante dei rifiuti di plastica che galleggiano nel Tamigi faceva da fondale al suono di un’autoradio a tutto volume, che avvolgeva l’intero spazio in maniera circolare. Al centro, una serie di componenti d’auto “geneticamente modificati” dall’artista con generosi strati di creta e acrilico vibravano al ritmo della musica, evocando delle inedite specie di fauna oceanica e invertendo in modo neanche troppo sottile gli effetti collaterali che scaturiscono dall’impatto dell’inquinamento sull’ambiente ittico.L’idea di un lavoro in uno spazio circoscritto impegnato in una relazione dialettica con un’alterazione intenzionale del paesaggio presenta delle analogie interessanti con le teorie di Robert Smithson, ma mentre nel caso dell’artista americano il problema era principalmente di natura geologica, il lavoro di Heim è soprattutto orientato verso l’esplorazione, e in certi casi l’offuscamento, della sottile linea di demarcazione che separa il naturale dall’artificiale. È una nozione che trova ulteriori conferme dall’impiego di tecniche vicine al ready made, e che suggerisce un intrigante parallelismo tra l’accettazione e la conseguente integrazione di oggetti pre-esistenti nel circuito dell’arte così come nell’ambiente. L’idea di individuare nell’automobile il simbolo per eccellenza per descrivere il processo di introduzione e assimilazione che caratterizza la relazione tra abitanti e habitat può a prima vista apparire come una scelta scontata, ma Heim ha alle spalle una lunga storia di associazioni tra il mondo della meccanica e quello della biologia. Indizi in questo senso si erano già visti in precedenza con Les Chevaux Vapeur (2010), un breve filmato girato sulla costa gallese dove il suono delle onde è sostituito da un ritmicamente simile e sorprendentemente calzante rumore di motore, e soprattutto con The Rotherhithe Tunnel (2006), un progetto sviluppato nel corso di dodici mesi in cui l’artista ha meticolosamente raccolto e catalogato gli specchietti retrovisori lasciati al suolo in una stretta curva a esse situata al centro dell’omonimo tunnel.

Courtesy Karin Guenther, Amburgo.
Il messaggio ecologico di Heim, in tutta la sua eloquenza e persuasività, non è però esclusivamente critico. Un’ironia astratta, abbinata a un interesse di fondo per gli effetti legati alla mutazione e alla forma di sopravvivenza darwiniana che ne deriva, rivela una visione fondamentalmente filosofica se non addirittura fatalista, implicando che i cambiamenti nell’ecosistema di cui siamo testimoni, per quanto irreversibili, sono in effetti il risultato di una costante capacità di trasformazione e adattamento.