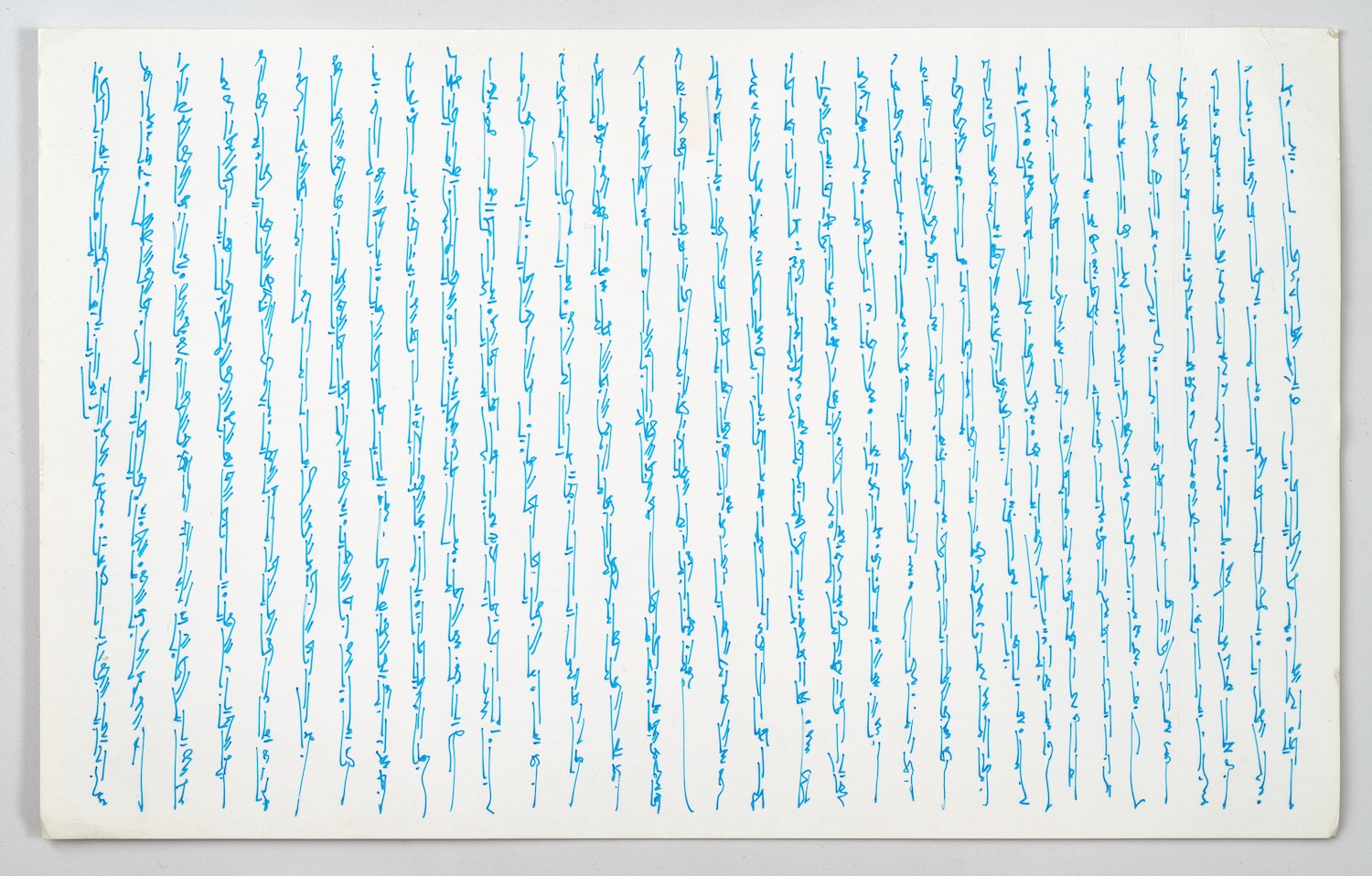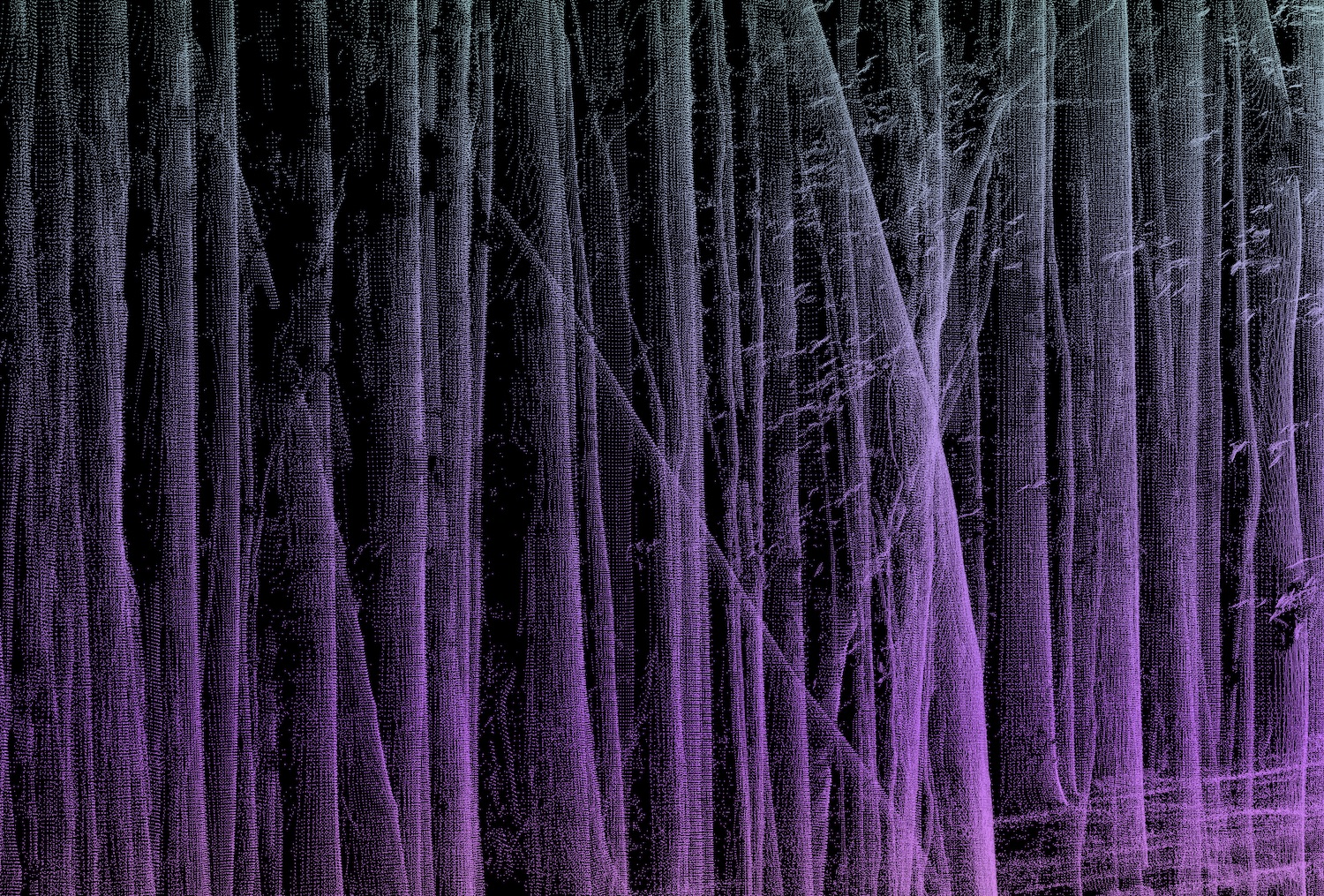“Ero stato autentico. Lo ero stato senza prima capire come si faceva”, dice l’uomo uscito dalla penna di Tom McCarthy prima di dedicarsi a una delirante ricostruzione dell’architettura cui è legata la piacevole sensazione. In piedi, in bagno, davanti a una crepa, sta ricordando l’armonia con cui aveva sempre vissuto prima di un grave incidente.
Come in Remainder1 (2005), allegorico romanzo dell’artista e scrittore inglese, anche l’installazione d’arte si presenta come l’arrangiamento formale della più ambiziosa delle ossessioni: è un dispositivo della teatralità sospeso tra realtà e finzione che, nelle sue molteplici manifestazioni, gestisce gli sviluppi di una narrazione, media il rapporto tra artista e spettatore e infine definisce spazi di movimento mutevoli ma sicuramente autentici. L’uomo di McCarthy, ad esempio, intende riprodurre uno studiatissimo teatro dell’assurdo fatto di oggetti, persone e azioni che sembrano espandersi perfettamente da quella spaccatura nel muro.
L’artista lituano Augustas Serapinas sembra affetto dalla medesima psicosi, crepe comprese. The Occupier (2018), l’opera site-specific concepita per la Biennale di Riga, si presentava come una “messinscena scultorea” in due atti – o meglio due stanze – nella residenza Kristaps Morbergs. Il primo ambiente, completamente vuoto, era la derelitta rappresentazione di se stesso: pavimentazione e soffitto originali, un camino piastrellato e tante screpolature d’intonaco che rivelavano la struttura lignea sottostante. Il secondo, con una certa continuità estetica, conteneva invece un intervento scultoreo che, in calcestruzzo pieno e su un piedistallo, si presentava come un calco in scala della stanza precedente: il suo “positivo”. Come nella chiara visione di Remainder, o nella scenografia di qualsiasi pièce teatrale, Serapinas valorizza l’architettura preesistente riproducendone le sembianze. Addirittura, grazie alla collaborazione di un gruppo di restauratori, prevede che i materiali della scultura reagiscano chimicamente per ricreare le crepe della stanza che la contiene.
Trascurando per un attimo l’attenzione al genius loci – che peraltro è la marca distintiva di Serapinas –, l’artista tratta il suo “oggetto” come materia modellata dal vuoto e fa dell’osservatore l’attore di uno script tanto esperienziale quanto inconsapevole. Il suo sguardo non attraversa gli ambienti come spazi servili, ma come interstizi di un’unica scenografia sbozzata per raggiungere nuova conoscenza: le due stanze, ormai legittimate dallo sguardo di chi le osserva, diventano gradualmente parte dell’installazione. Più in generale, insistendo su dinamiche spazio-temporali e distillandole dal luogo nel segno dell’“installazione totale”2 (Housewarming, 2016; Phillip, Lukas & Isidora, 2015), Serapinas riconosce allo spazio coreografato una tridimensionalità di senso, oltreché di dimensione, in cui la coordinata z è lo sguardo.
Senza voler ripercorrere una cronologia tipologica né strutturarne un’antologia, l’installazione d’arte si costruisce all’incrocio di tempo e spazio ma, almeno da quando esiste il campo allargato,3 si espande al punto da produrre architetture “teatrali”, “immersive” ed “esperienziali”4 per il soggetto che le abiterà. Nonostante la relazione artista-spettatore sia di per sé connaturata a qualsiasi produzione artistica, l’installazione prevede la costruzione di lavori che smettono di essere self-contained objects5 e diventano situazioni in cui far muovere individui che, svestiti i panni di puri voyeur, si ritrovano guidati dai segni e delle immagini del display che li circonda.
La loro presenza fisica è ormai la componente indispensabile per definire lo statuto dell’installazione e, in base a come è strutturata l’esperienza, diventa il paradigma per riscontrare differenze interne alla categoria. La loro “autenticità”, per dirla con McCarthy, si attiva con lo spazio e nello spazio e, contrariamente a quanto richiedono i media tradizionali, l’osservatore è attore nel fare la composizione, riempiendola fisicamente o intervenendo emotivamente.
L’artista contemporaneo ne è consapevole e gestisce la sintassi delle sue “scenografie” facendovi apparire elementi e disposizioni sempre utili all’innesco o alla gestione dello sguardo: alla ricerca di una percorribilità, di un’“inguaribile teatralità”,6 o di più complesse relazioni in cui gli oggetti appaiono simultaneamente.
In tutti i casi, l’interattività generata coincide con la pratica dell’osservazione estetica e procede per progressivi allontanamenti dalla tradizionale frontalità del teatro: entrare nello spazio o esserne circondati non è la stessa cosa, e il movimento genera una soggettività decentrata in grado di affrontare una visione sempre parziale, una prospettiva per volta. Anzi, anche quando quest’ultima insiste sulla centralità, l’installazione sovverte la sua disciplinata tradizione teatrale e nega l’esistenza di uno spazio privilegiato da cui osservarne la complessità.
Fino a poco tempo fa, nella project room della Fondazione Pomodoro, una serie di sculture in vetroresina addomesticava gli spazi asettici di un tendone industriale, una serra plausibilmente. Se osservati dall’ingresso, gli elementi della struttura correvano verso un unico punto di fuga facendo di Underfoot (2019) una perfetta macchina teatrale a prospettiva centrale.
La giustapposizione delle sculture e la simultaneità con cui apparivano al suo interno però, tradiva la razionalità della costruzione ottica invitando lo spettatore ad approfondire – muovendovisi all’interno – la visione per soluzioni multiple e sempre parziali. Ogni scultura di Rebecca Ackroyd infatti, era al contempo sola e appaiata, e la sintassi dell’installazione richiedeva un numero di viste (quantomeno) pari al numero dei singoli lavori. Anche considerando un approccio scenografico, proprio lo slittamento prospettico generava l’abbattimento della fissa separazione tra palcoscenico e pubblico raccontando la teatralità come un sistema di relazioni aperte tra soggetto-oggetto, o come una forma antigerarchica di esperienze estetiche.
A voler credere che dietro l’utilizzo dell’una o l’altra prospettiva si nasconda ancora una forma simbolica,7 i tanti punti di vista costruiti da Underfoot darebbero conto di una visione del mondo frammentata e decentrata, in cui l’individuo è solo, e la psicologia dello spazio è il riflesso dei corpi che la abitano. Non a caso Rebecca Akroyd tratta la serra come un salotto bizzarro e lavora sull’estetica del singolo complemento d’arredo abbinandogli, senza soluzione di continuità, i fantocci che lo abitano: sono delle strane sagome umane e si rendono testimoni (o vittime) di un’esperienza onirica di cui lo spettatore è partecipe solitario.
Ancora una volta lo spazio è progettato per essere “totale”, o una completa immersione in cui l’esperienza estetica dello sguardo coincide con quella fisica del dispositivo. Il senso dell’installazione, in fin dei conti, è la proliferazione di momenti contemplativi che, calibrati su prospettive coesistenti, conducono l’occhio a inseguire la densa architettura di immagini e segni costruita intorno a lui.
Infatti, se indirizzare l’esperienza dell’osservatore secondo prospettive simultanee significa riconoscere l’installazione come un dispositivo8 in grado di gestire molteplici percezioni su altrettanti oggetti, allora l’artista – che per dirla con un linguaggio semiotico è “referente” di questa mediazione tra segno e interpretazione – non solo gestirebbe l’apparire delle “cose” ma, coreografandone il “senso”, renderebbe tutti gli oggetti indizi della sua narrazione.
Le teste di Tomaso De Luca – Cokehead (2017) –, che abitano un white cube e stanno appese a tavoli e sedie come resti di un trauma, sembrano i sopravvissuti di un panorama post-apocalittico non troppo diverso da quello di Akroyd, pure nei materiali. Di quella introspezione domestica però, interpretano solo la dimensione privata di un dramma collettivo: sono tutti protagonisti di un romanzo distopico, Sofakissenstadtebau, ambientato in una New York gentrificata che converte tutti i suoi locali in dive bar. Attraversando lo spazio che le ospita, le sculture di De Luca – insieme al mobilio e ai disegni su resina – sono come ephemera posizionati per stimolare una narrazione che coincide con l’installazione, come oggetti di scena che intrappolano un messaggio prima di trasferirlo allo spettatore. Della metafora teatrale rimane la sua apparente negazione. Lo script resiste, ma avviene un paradossale ribaltamento tra quinte e palcoscenico, tra forma e contenuto: l’artista mostra l’inscenabile, accompagna il suo pubblico dove non gli è consentito e stimola la simultanea apparizione della sua soggettività. Nel forzare l’esperienza visiva in ogni direzione infatti, De Luca rende “opaca”9 anche la condizione estetica: lo spazio dell’installazione è ora un luogo dialettico dove coltivare ambiguità, e l’osservatore si muove tra le immagini ricostruendo la propria narrazione senza alcuna esaustività.
Qualche anno prima, ad esempio, attraversare gli spazi di Salopp Gesagt Schlapp (2014) significava affrontare la medesima opacità identitaria, quanto essere sottoposti a una poetica dell’esercizio. Le strutture di legno e mattonelle alla Kunstlerhaus di Brema simulavano l’estetica imbrattata di un qualsiasi bagno pubblico pur ospitando una costellazione di immagini studiata nella composizione e nei riferimenti. Come un foro romano postmoderno, l’installazione era uno spazio in cui abituare lo sguardo a nuove prospettive; era un’architettura teatrale in cui scoprire contemporaneamente il fronte e il retro delle opere; ma soprattutto era l’ingresso dello spettatore/attore nel riconoscimento di sé in una narrazione stratificata, rizomatica e inesausta. Qui risiede l’esercizio: errare tra i segni di De Luca significa mettersi la maschera dell’attore e guardare ogni immagine come un palinsesto pronto a richiamarne un’altra, in una concatenazione di senso che risiede sempre nello sguardo del singolo spettatore. Significa appellarsi al “diritto all’opacità”, che difende tanto la fallacità dei segni quanto nega la coincidenza tra percezione e realtà.
Nel lavoro di De Luca, citazionismo, ripetizione, variazione e replica, compromettono il procedere consapevole nel senso, ottenendo l’assoluta negazione dell’orientamento e il paradossale riconoscimento del soggetto nell’oggetto contemplato.
D’altronde anche all’uomo di McCarthy (nell’aggiungere elementi alla mise en scène), sfugge progressivamente la gestione, e forse il senso stesso, della macchina di cui diventa spettatore. Anzi, con risoluta follia, espande il progetto al punto da non distinguere la realtà dalla finzione.
Se è vero che l’installazione rappresenta il dispositivo per la gestione di simultanee soggettività, l’artista concepisce la sua sintassi consapevole delle ambiguità e alterazioni che susciterà su ogni sguardo. Che si tratti di spazi percorribili, prospettive simultanee, o dell’assoluto ribaltamento della percezione, lo scopo è quello di strutturare la più autentica delle esperienze nella più libera delle articolazioni.
Il problema non è orientarsi sulla modalità spaziale, che sicuramente risponderà a una scelta contenutistica; il punto è renderla coerente con lo sviluppo della sua percezione. Il teatro è ancora un riferimento privilegiato, ma resiste come espediente estetico da smontare, rimontare o decostruire completamente: non è più il protagonista, ma l’antagonista.