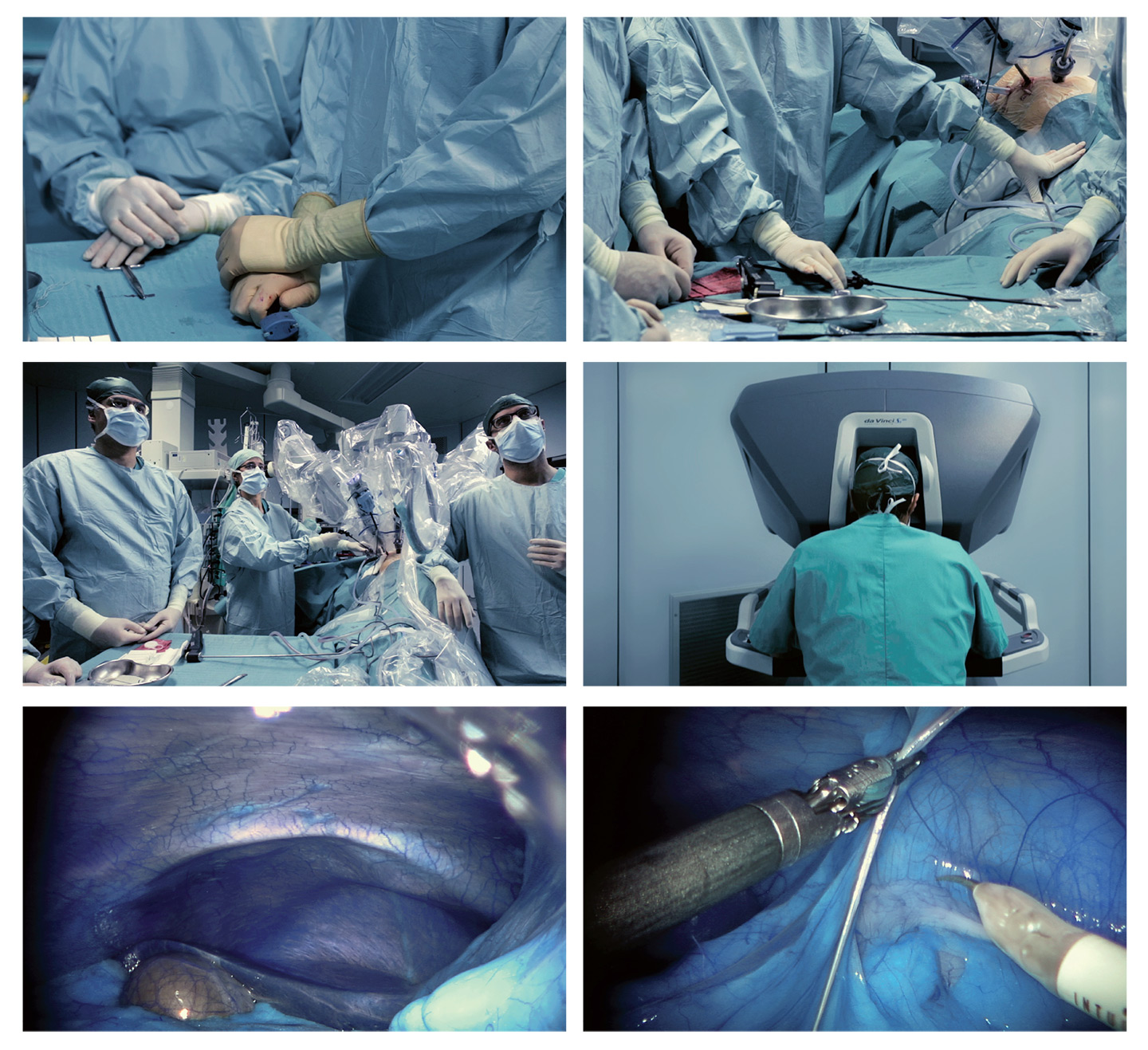Prima, scatole e gabbie, poi stoffe e coperte; e ancora forme antropomorfiche che iniziano ad apparire da sotto le coperte; strati di carne, che si aprono davanti ai miei occhi, frammenti di corpo…una cosa, allungata, un braccio, una gamba, un parto… tutto ha luogo davanti ai nostri occhi.
Le opere di Berlinde De Bruyckere vengono alla luce davanti ai nostri occhi, si moltiplicano e si sgretolano. La sequenza è irrilevante, tutto accade simultaneamente. Quando tutti i suoi lavori, dalle “Closet Forms” che lei ha realizzato negli anni Ottanta ai suoi più recenti “Bodies” sono posti l’uno accanto all’altro, non è necessaria una prospettiva storica per percepire l’idea di nascita presente in ogni suo lavoro. La fessura che permette al parto di apparire come un atto “creatore” in ogni suo lavoro.
Forme spaccate, che si moltiplicano, mostrando la fessura che emerge dal loro corpo, da cui si è nati e che dà la vita. Il lavoro di Berlinde De Bruyckere rappresenta la nascita, la moltiplicazione e gli incessanti inizi che si trascinano con un inutile sforzo davanti alla morte.

“Quelle bellissime persone salirono sui loro bellissimi cavalli e se ne andarono”.
Yaşar Kemal
Pezzi di cera che è impossibile distinguere rispetto alla vera carne e dalle ossa, fluttuano, si fondono e divergono; diventano corpi il cui inizio o fine è difficile da distinguere. Possono questi corpi essere definiti umani? Stanno provando piacere o dolore? O per lasciar perdere queste domande, è possibile per loro sentire qualcosa? Sanno di essere guardati? Sono consapevoli? Lasciateci supporre che lo siano, quindi nascondono le loro facce perché si vergognano? Perché scelgono di non nascondersi completamente e apparire, senza volto, svelando i loro petti? Sono torturati? O questa è solo la natura umana? Una volta svelato il velo dell’illusione che appartiene allo spettacolo, sarà rivelata la verità nascosta? È questa la nostra vera faccia sulla quale la tortura che ci viene inferta dal mostro è riflessa come cultura; è questa l’esistenza umana, nel mezzo delle tristezze? Sono questi gli eroi che sorgeranno dalle profondità e fermeranno il flusso della vita di tutti i giorni fermamente tessuto, che sconfiggerà tutte le ideologie, accettati universalmente i giudizi e le norme morali del loro stesso gioco, e salveranno noi, la nostra natura e la nostra umanità? Non credo. Invece di presumere di parlare dell’orgoglio umano, della gloria o della dignità che dovremmo proteggere o per la quale dovremmo combattere, il lavoro della De Bruyckere li attraversa in un solo colpo. Questo forse perché ci ricordano, di solito con un senso di disgusto prodotto dall’eccesso di immagini di vittime di guerra o di torture, di rifugiati politici o di campi di concentramento. Il lavoro di Berlinde De Bruyckere rivela ciò che resta quando siamo spogliati di tutto ciò che ci persuade a essere umani — quello che resta in momenti di crudeltà. Ma si potrebbe anche non restare impressionati; mentre i tiranni sì, con l’aiuto di mille e una tecnologie — omicidio, tortura, esilio, imprigionamento — usano uno di questi residui, questi eccessi senza forma come un pretesto per ricavare potenza dalla vita, Berlinde De Bruyckere li segna come il momento in cui si rivela la potenza della vita. Il momento in cui l’esistenza umana è solo un’esistenza umana; il momento in cui l’esistenza umana è ferita, e non nel senso di vittima, ma accettata. Il coraggio non è andare in luoghi in cui nessuno è mai stato prima, o fare cose che non sono mai state fatte, o aprire il tuo cuore a tutti. Dopotutto, le crepe aperte sulle loro superfici rivelano che non c’è nient’altro a parte il vuoto dei loro corpi. Il coraggio risiede nel portarle sul palco in assenza dell’uomo o della donna che guida, e nell’apparire in vetrina, giacendo spogliati di tutte le carenze, e in un’accettazione, sebbene possa apparire difficile, del fatto che non c’è niente da nascondere o da cui scappare da questo, in sostanza illusorio e transitorio, mondo in cui viviamo. Il coraggio non risiede nell’attendere un salvatore, o nel correre intorno urlando “La Verità! La Verità!”, ma uscire fuori e giocare il gioco, sapendo bene che è solo un’illusione. Dopotutto, i nostri salvatori sono andati via, e più probabilmente non sono mai venuti in questo posto. Una volta nati, non abbiamo nessuno a cui insegnare come vivere e come morire. Le nostre madri e i nostri padri sono ignoranti quasi quanto noi. La questione non è sul come accendere un fuoco, o come costruire una casa come rifugio, o imparare a subaffittare o a pescare. Quello di cui abbiamo bisogno è una determinata specie di conoscenza; sentiremo l’alito dell’assenza di questo sapere sul nostro collo per tutta la nostra vita; questa è la conoscenza di cosa, come e quanto ameremo, quanto possiamo moltiplicare il nostro amore, e mantenerlo in un flusso, impedendogli di dissolversi e di rimanere paralizzato di fronte alla paura della morte. Dopotutto, è il dubbio il luogo in cui una tale conoscenza può essere trasmessa attraverso l’insegnamento. Se c’è una verità di cui abbiamo bisogno per poter restare vivi, allora dobbiamo acquisirla vivendo, ma vivere non è qualcosa che si può fare da soli. Richiede lo stare insieme, nella pluralità, e in un senso più semplice, stare sotto lo sguardo degli altri. “L’altro” è necessario, così uno sa verso cosa tende il suo braccio, o la sua gamba, e cosa toccherà e da cosa sarà respinto. Il lavoro di Berlinde De Bruyckere trova la sua collocazione in una vetrina con un desiderio tale — un desiderio di toccare colui che è proprio accanto a noi, conoscerlo ed essere conosciuti, aprire se stessi al corpo dell’altro e così, vivere. Una semplice riflessione: il nostro mondo è composto di cose che facciamo e le cose che facciamo ci danno forma. I lavori di Berlinde De Bruyckere non contengono un ritorno alla natura; piuttosto, essi emergono nel mezzo di questo mondo artificiale come parte di esso. La costante comparsa delle sculture in compagnia di oggetti artificiali come le vetrine, i tavoli e le coperte possono anche essere visti come segnali di questo. Nei suoi ultimi lavori, i corpi non sono separati dagli involucri, nastri o coperte che Berlinde De Bruyckere usava nei suoi primi lavori. Queste cose, che trattiamo come meri strumenti espositivi o contenitori, che vediamo come interferenze tra i lavori e la nostra esperienza di realtà, e che l’arte moderna sta sempre cercando di disfarsene, sono abbracciati dalle sculture della De Bruyckere come il loro unico possibile mondo. E la carne, le ossa, i corni, i cavalli e gli alberi, tutto ciò che ci ricorda di una natura vergine, selvaggia, prende il suo posto su un palco artificiale con la piena consapevolezza del fatto che questo è il loro unico mondo. E i cavalli, avendo portato gli umani sui loro forti corpi nel corso della storia nello sforzo dell’umanità di controllare la natura, domare la morte e fare dello sconosciuto conosciuto, sono evoluti nelle opere della De Bruyckere. Essi, inoltre, non sono i cavalli che conosciamo dalle leggende, dalle saghe, o dalle storie di guerra. Essi non si alzano sulle zampe come quei cavalli che conosciamo né attraversano il mondo al galoppo. Non sono cavalli che vediamo come conquistatori o vincitori correre come parti delle statue. Al contrario, essi sono cavalli che finiscono con l’essere uccisi, sono cavalli che finiscono in salsicce. Non una forza mirata alla conquista, alla vittoria o al dominio, ma verso l’emergenza e la rivelazione della vita, non una forza per cambiare il mondo ma per emergere accanto al mondo. I cavalli restano qui e si moltiplicano come se fossero lacerati, si alzano sulle zampe in quasi ogni direzione.

Per entrambe: Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Pechino / Le Moulin (F).
“E così, più toccavo, più la tua carne, le tue parole si moltiplicavano”
Cemal Süreya
Se cerchiamo di respingere la convinzione che l’umanità sia stata in qualche modo più felice in tempi passati, e che le esistenze umane erano più umane e il mondo era più bello prima, potrebbe aiutarci nell’affrontare la nostra incompetenza a immaginare che quello che abbiamo fatto non è caduto dal cielo come una palla di luce, ma è cresciuto nel cuore come una patata. Incappare nella cattiva sorte e arrendersi alla malinconia è sempre un’opzione. Proteggere le nostre ferite che aspettano tenerezza e attenzione dal mondo intero e mostrarle solo a coloro che le capiscano, trascorrere tempo a sentirsi in colpa per ognuna di esse o diventare occhi che conoscono la sofferenza, reclamare la santità e invitare i lebbrosi nel nostro letto… chi mostrerà l’arroganza di accollarsi la sofferenza del mondo? Nessuno tra noi è un guaritore. Falliamo anche quando aiutiamo noi stessi. Il lavoro di Berlinde De Bruyckere non è un elogio alle nostre ferite. Queste opere sono esse stesse ferite, ognuna di esse è una crepa. Sono lavori che invece di correre a cercare una cura, cercano di rendere più profonda la ferita, di andarci più a fondo. Perché la cosa che noi chiamiamo ferita è la vita stessa e più la esploriamo e la allarghiamo, più essa appare bella. Le opere di Berlinde De Bruyckere sono alla ricerca del Bene, del Bello o, in altre parole, della felicità. Se seguiamo Kant e permettiamo a noi stessi di essere catturati dall’idea di non percepire nessuno come uno strumento, possiamo ritrovarci sospesi a mezz’aria, senza neppure comprendere noi stessi in questa zona dove non c’è morale. Potremmo dover offrire noi stessi all’esistenza di altri come strumenti e viceversa, usare la loro carne come un letto in cui abbandonare la nostra carne, e usare le loro ossa come bastoni per pungolare le nostre ferite. L’unica fonte della nostra felicità è essere riconosciuti dall’“altro”. Sebbene possa sembrare che i nostri brutti corpi siano il più grande ostacolo nel cammino che ci conduce alla felicità eterna, dovremmo piuttosto pensare che siamo informi non a causa dell’intensità dell’impatto nel colpire il pavimento, ma perché ci pieghiamo, come radici sotterranee, con tutta la nostra esistenza verso la fonte della vita. Nello stesso modo in cui una pianta ha bisogno di radici più profonde per trovare più nutrimento, noi abbiamo bisogno di più superfici per essere amati/toccati. Questa visione può redimere i corpi di Berlinde De Bruyckere dalla tirannia di un giudizio estetico funzionale e consentirci di contemplarli con bellezza. Se la cosa che noi chiamiamo vita umana comincia quando noi andiamo oltre i nostri bisogni elementari, allora l’acqua e la terra che danno vita a una pianta sono sostituite dal riconoscimento mostrato dagli altri o per usare l’espressione più familiare, dall’“essere amati”. Quello che ci rende umani è l’entrare in contatto con gli altri ed essere toccati da loro. L’acqua è bellissima non perché placa la nostra sete, ma perché è acqua e ci fa sentire vivi quando attraversa la nostra gola.