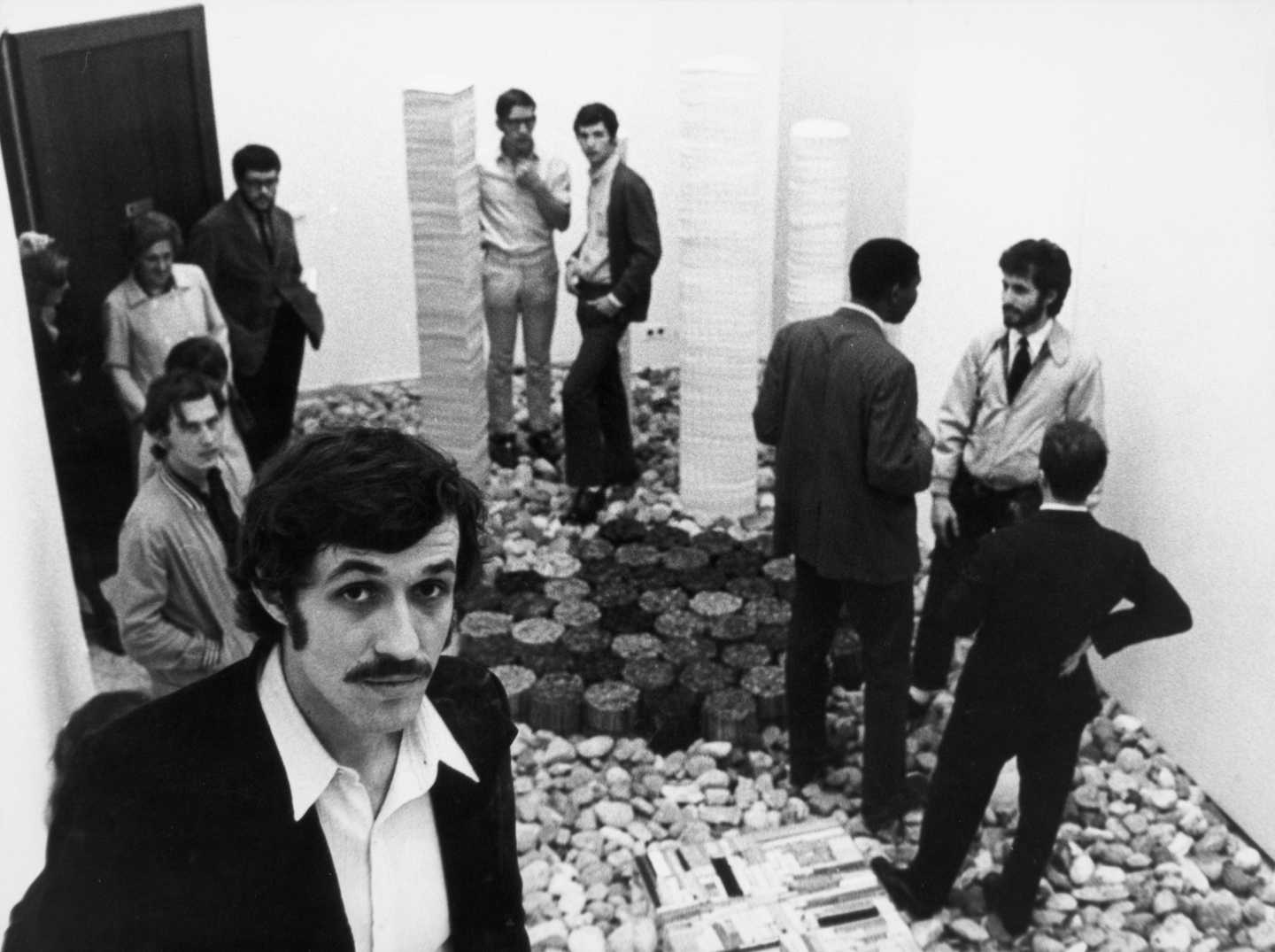“Come una lampadina vista tra le lacrime”.
Silvio D’Arzo
Le case sono grandi strumenti ottici. L’insonnia protrattasi fino all’alba predispone il pensiero verso questa analogia. Fermo nel letto ammiro la forza permeante del sole, ancor prima del suo apparire all’orizzonte, in quella fase in cui il barlume avanza dentro le scatole dell’uomo come un alito che senza fretta deterge le cose dalla ganga dell’ombra. Io stesso sono nella soluzione di sviluppo ed emergo dal buio che fino a poco fa possedeva tutta la mia forma. Poi un primo fascio di luce diretta colpisce un punto bianco del soffitto, varcando la soglia di una finestra che svolge un ruolo di filtro. Attraverso il cristallino si distribuisce allora un chiarore più acuto e vibrato nella camera oscura e anche le stanze senza finestre vengono raggiunte dal riverbero insinuante di quella potenza silenziosa e intangibile. I raggi sono tentacoli che dal soffitto discendono a terra, frugando la preda nella tana. Monete bianche sul muro, che aumentano di numero e valore facendosi strada tra le foglie della bignonia.
Sembra di comprendere meglio anche il bianco di Johannes Vermeer stamane, quel colore che non resta fermo nel suo perimetro, nella tarsia assegnatagli. Una componente prismatica che irradia e risucchia come un abisso di assoluto.
Dipinti che ragionano sul lume e sull’eco rifrattivo di stanze e pareti, di oggetti e presenze. Dipinti che fanno del bianco un diapason intorno al quale si intonano alti gli scalini delle altre tinte, i terrazzamenti che alludono alle forme. La superficie abbacinata di un foglio di carta, lo specchio convesso di una brocca, lo smeriglio di una finestra, la pupilla di un occhio sono i cardini cromatici estremi dai quali sgorga una supremazia del colore sul dettaglio. La leggera ma percepibile espansione luminosa che ogni tinta svolge entro il campo che le pertiene, sancisce una vittoria della luce, che è riuscita a eliminare ogni particolare successivo, chiosando perentoriamente la visione.
Senza esperienza lenticolare non sarebbe stata possibile una tale pittura.
Si percepisce un diaframma vitreo e scintillante che si frappone tra l’autore e il modello in posa. Le case, le cose e le figure sono in ferma perfetta, solo la luce risulta non completamente arrestata. Se quel bianco non fosse estremo e non avesse fagocitato i perimetri grafici della forma tutto sarebbe immobile, illustrato e, forse, morto.
La pittura di Vermeer diviene invece una calibrata macchina del tempo luminoso. Tacche di luce ne scandiscono il corso entro l’orologio lento dello spazio domestico. Allora la donna che versa il latte, l’astronomo che tende la mano al globo, la giovane gravida che legge una lettera, diventano meridiane viventi.
Agendo nella scena geometrica i corpi cedono dettagli di verità per divenire volumi solidi, ammorbiditi tuttavia da una luminescenza che sembra venire dal loro interno.

Olio su tavola, 23 x 18 cm. Collezione National Gallery, Washington.
Una sorta di diacromia, di retroilluminazione del colore, viene immaginata tre secoli prima della sua nascita elettrica o una scatola prismatica permetteva già di far convergere, sul lato vitreo di un cubo ligneo, un riverbero di visione?*
La scienza di Galileo, sviluppata dai maestri vetrai olandesi e veneziani, ha spinto a interpretare anche il nostro corpo come macchina ottica. L’occhio è dunque una finestra, un’apertura che immette luce dentro lo spazio dei nostri pensieri. La metafisica luminosa in Vermeer avvolge le forme con un’aria amniotica che rende onirica ogni visione.
Anche i più semplici ritratti, grazie a questa sfocatura che richiede sintesi, acquistano un traslato spaziale e temporale, una separazione dal “qui e ora” che li spinge in una quarta dimensione, quella del ricordo o del soprappensiero. L’estraniarsi con la mente dal presente non è forse manifestato da un leggerissimo strabismo? Da una temporanea perdita della messa a fuoco? Per questa ragione la Ragazza con l’orecchino di perla dell’Aia, la Donna col cappello rosso di Washington o la Giovane con manto grigio, del Metropolitan Museum di New York, visibilmente segnata dalla sindrome di Down, divengono persistenze luminescenti, fosfeni che finiscono per impressionare la nostra più recondita retina.