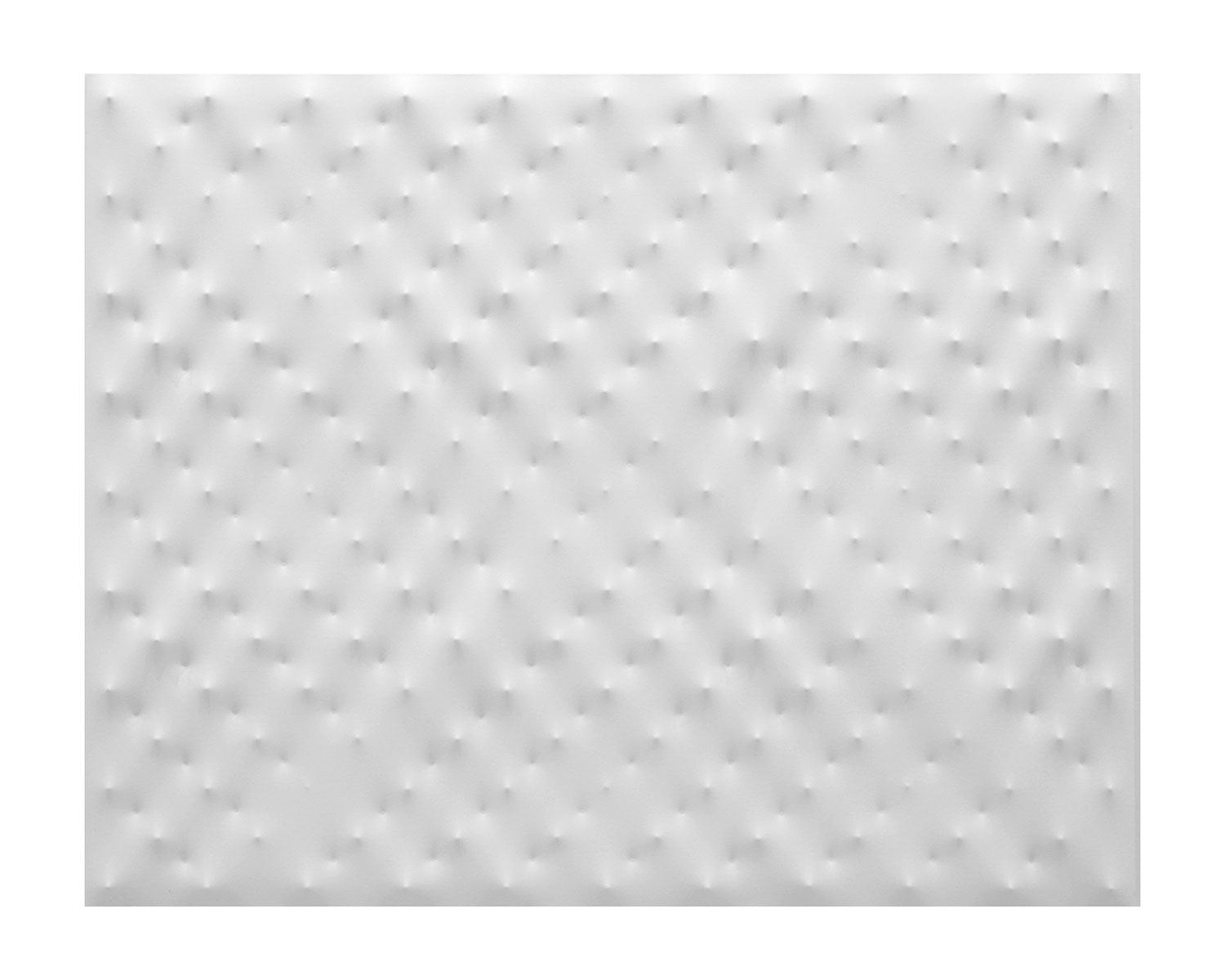Damiano Gullì: Sei la sesta vincitrice del Max Mara Art Prize for Women. Il premio, organizzato e finanziato da Max Mara, vede attivamente coinvolte due istituzioni la Collezione Maramotti di Reggio Emilia e la Whitechapel Gallery di Londra. Assegnato ad anni alterni a partire dal 2005, il Max Mara Art Prize for Women sostiene artiste residenti nel Regno Unito che non hanno mai avuto una mostra personale. Che cosa significa per te questo importante riconoscimento? Cosa ne pensi della situazione delle artiste donne oggi?
Emma Hart: Non dovremmo avere bisogno di un premio per artiste donne, ma, mentre ci sono donne molto forti che lavorano come curatori e direttori di musei (come Iwona Blazwick — direttore della Whitechapel e presidente di giuria del premio — e Jenni Lomax), è un mistero per me perché le artiste donne siano ancora sotto rappresentate nelle gallerie e nelle principali mostre pubbliche. Dopotutto, la maggior parte degli studenti d’arte sono donne e ci sono molte grandi donne galleriste. Premi come il Max Mara Art Prize for Women danno alle artiste una spinta importante in un momento fondamentale della loro carriera. Anche se questo premio non può risolvere la disuguaglianza, è soprattutto riuscito a farcene parlare.
DG: Il premio consiste in una residenza di sei mesi in Italia (in Lombardia, Umbria ed Emilia-Romagna), nella produzione di una nuova opera e nell’acquisizione della stessa da parte della Collezione Maramotti. L’opera realizzata sarà presentata in due importanti mostre personali, prima alla Whitechapel, poi alla Collezione Maramotti, della cui collezione permanente entrerà a far parte. Mentre Whitechapel segue l’aspetto scientifico-curatoriale del progetto, soprattutto nella fase della selezione, la Collezione Maramotti si occupa di selezionare le proposte di residenza e di effettuare una tutorship durante il periodo di residenza, garantendo così uno stretto legame con il territorio e con la cultura italiana. La Collezione collabora inoltre con la Whitechapel per gli aspetti organizzativi legati alla produzione della nuova opera, del catalogo e della presentazione al pubblico del progetto. Ci puoi descrivere il lavoro grazie al quale ha vinto il Max Mara Art Prize? Cosa ti aspetti dalla residenza in Italia?
EH: Sono felice di aver vinto. Come artista si è sempre attanagliati da dubbi, nervosismo, domande, e così vincere un premio di tale prestigio è una vera e propria iniezione di fiducia. Il mio punto di partenza per la residenza è stato quello di pensare a come ci avviciniamo alle opere d’arte e a come ci relazioniamo con esse. Può essere fatta un’arte che coinvolga il pubblico piuttosto che farlo sentire solo un osservatore esterno? Il pubblico può essere coinvolto in qualche tipo di situazione reale, di sistema o di relazione con un’opera d’arte? Pensare alle relazioni mi ha portato a voler esplorare il potere della famiglia, qualcosa di importante nella storia italiana (e, ovviamente, importante anche nella mia vita!). Ma più che guardare a esempi storici voglio anche scoprire come le relazioni e i sistemi familiari funzionino, quindi sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di scoprire di più sulla figura di Mara Selvini Palazzoli, una pioniera nel campo della psicologia, che ha sviluppato la Scuola di terapia familiare a Milano. Ma voglio anche e soprattutto guardare alla maiolica, un tipo di ceramica italiana dalle immagini vivide smaltate sulla superficie. Dal momento che lo smalto non sbiadisce e i colori e le immagini che vediamo su queste ceramiche sono esattamente quelli che l’artigiano avrebbe visto appena uscite le opere dal forno, guardare una maiolica è come viaggiare nel tempo. La maiolica è stata spesso data in dono per celebrare eventi familiari, così potrebbe anche rivelarmi qualcosa sulle relazioni familiari oltre ad imparare delle abilità pratiche fondamentali. Venire in Italia avrà un enorme impatto sul mio modo di pensare, sulla mia famiglia e sul mio futuro. Penso davvero che la residenza mi renderà una artista migliore. Ultimamente tendo a fare un sacco di arte in fretta e questo premio mi dà il tempo e lo spazio per lavorare in maniera più ponderata. Venire in Italia sarà l’avventura di una vita, dal momento che sono sempre bloccata nella vita di Londra con tutte le sue sfide travolgenti.

Triennial. Foto: Thierry Bal.
DG: Puoi descrivere la tua pratica artistica? Ricorri trasversalmente a diversi media e tecniche: la ceramica, il video, la fotografia e il suono… tradizione e innovazione…
EH: Credo che il travolgente mondo reale in cui ci troviamo a essere sia separato dal modo in cui il mondo digitale si riferisce alla realtà. Nel mondo digitale tutto viene appiattito. La vita sembra bella nelle immagini, o se non è bella, sembra abbastanza lontana da noi da gestire e controllare. L’immagine, la cui funzione è rivelare il mondo, sta in realtà trasformando tutto in superfici delle dimensioni di byte che nascondono l’esperienza reale. La scultura, più recentemente la ceramica, mi offre un modo per corrompere e “sporcare” fisicamente le immagini ed estrarre con forza più vita da esse. L’argilla fornisce un modo per lavorare al di là delle immagini e rivelare il puro, grezzo, reale stato delle cose che le immagini schermano. Voglio dirvi come esso sia davvero e cosa si prova. L’argilla forzatamente accostata con il video o la fotografia è il mio metodo per far prevalere gli aspetti interiori su quelli esteriori. Questa frustrazione nei confronti della macchina fotografica è diventata anche una richiesta all’arte, che anch’essa offra esperienze dal vivo, o che offra all’osservatore situazioni in cui egli possa entrare piuttosto che starne al di fuori e contemplare. Il mio lavoro è alla ricerca del “reale”. Vita reale, sentimenti reali, dettagli autobiografici reali. Piuttosto che dare un senso al mondo, voglio che l’arte generi la confusione, lo stress e la nausea del quotidiano. Voglio riconoscere nell’arte la mia sudicia vita di tutti i giorni, non cancellarla per guardare educatamente agli oggetti. Attraverso video o audio uso la mia voce per creare un clima ansioso che si libra sopra le sculture in ceramica. Attraverso questo desidero affrontare questioni di classe e offrire l’arte in prima persona, rischiando l’imbarazzo. Esponendo dati e sentimenti personali, metto in gioco qualcosa di me nel fare le opere. Il mio lavoro è rozzo, diretto ed è subordinato al fatto che l’osservatore entri nelle situazioni che ho creato. Presento da vicino una esperienza intima. Giving It All That, per la Folkestone Triennale del 2014, installata in un appartamento fatiscente, tratteggiava l’ansia latente che risiede nel divario tra il nostro io pubblico e quello privato. Nello spazio domestico possiamo provare chi siamo. Ho fornito delle “postazioni d’aiuto” o “Mates”: strutture composte da corrimano in metallo, in cui lo spettatore “entrava” per vedere una presentazione ripetitiva di sé. Nel frattempo delle sculture in ceramica davano delle posizioni allo spettatore. Braccia in ceramica si tendevano dal pavimento per offrire precarie bevande vuote e occhi-specchio in argilla scrutavano tavolette in ceramica. Essere serviti o essere monitorati produce diversi stati emotivi. Dirty Looks al Camden Arts Centre, del 2013, richiedeva che lo spettatore scrutasse in squallidi armadietti e si confrontasse con brutali lingue staccate dal corpo. La lingua è un organo interno che usiamo per controllare le nostre impressioni esteriori. Basata sulla mia esperienza di lavoro in un call center, la mostra ha provocato un disagio surreale. Il mio approccio è spesso quello di cercare di sopraffare lo spettatore. Fornendo allo spettatore molti dettagli a cui guardare è costretto a modificare la propria esperienza attraverso la mostra, e io rinuncio al controllo.
DG: L’esperienza reale, il dato autobiografico, la realtà quotidiana, le emozioni sono molto importanti per te. Come riesci a tradurli in un lavoro?
EH: Ho deciso di fare ceramiche in una scala più grande, per offrire non oggetti ma situazioni che creino un coinvolgimento, anche se solo emotivamente, dell’osservatore con un’opera d’arte. Intendo le opere d’arte come modalità per generare esperienza, che assorbano l’osservatore, o che almeno lo rendano consapevole di se stesso. Se non sto lavorando su installazioni che creano situazioni in modo più chiaro, allora allo stesso modo dei lavori a parete più piccoli si dirigono o vanno verso lo spettatore. Ad esempio, Pony, una serie di code di cavallo, che potrebbe anche apparire come un’esplosione di stronzi, fa riferimento alla posizione dello spettatore. Vengono verso di te. Erano in una recente mostra “Big Mouth” alla Grand Union di Birmingham, dove mi sono soffermata su sudore, fuoriuscite e fluidi corporei incontrollati, lapsus, tosse ed emozioni prorompenti. Sono sempre attratta da sudore e fuoriuscite, momenti di eccesso fisico scoppiano attraverso il nostro aspetto esteriore. L’argilla può essere schiacciata, costretta e versata per rappresentare i propri eccessi. L’argilla mi permette di mettere i sentimenti sulla sua superficie. Si può prenderla a pugni, a calci, graffiarla, morderla e accarezzarla. Si connette con la me stessa più pura.
DG: La ricerca che hai svolto per sviluppare il progetto risultato vincitore ti ha fatto scoprire nuove figure della storia o della cultura italiana su cui hai deciso di focalizzarti?
EH: Come accennavo prima, durante la mia ricerca ho scoperto il lavoro di Mara Selvini Palazzoli, che ha sviluppato il cosiddetto “Milan Approach”: una scuola di terapia familiare in cui, invece di curare il singolo individuo, sono esaminati e curati anche il sistema o la famiglia di cui esso fa parte. Questo è qualcosa su cui mi piacerebbe molto riflettere, soprattutto nel modo in cui ci si avvicina all’arte. Lo spettatore è coinvolto in un insieme di relazioni, piuttosto che essere l’osservatore esterno di una situazione.