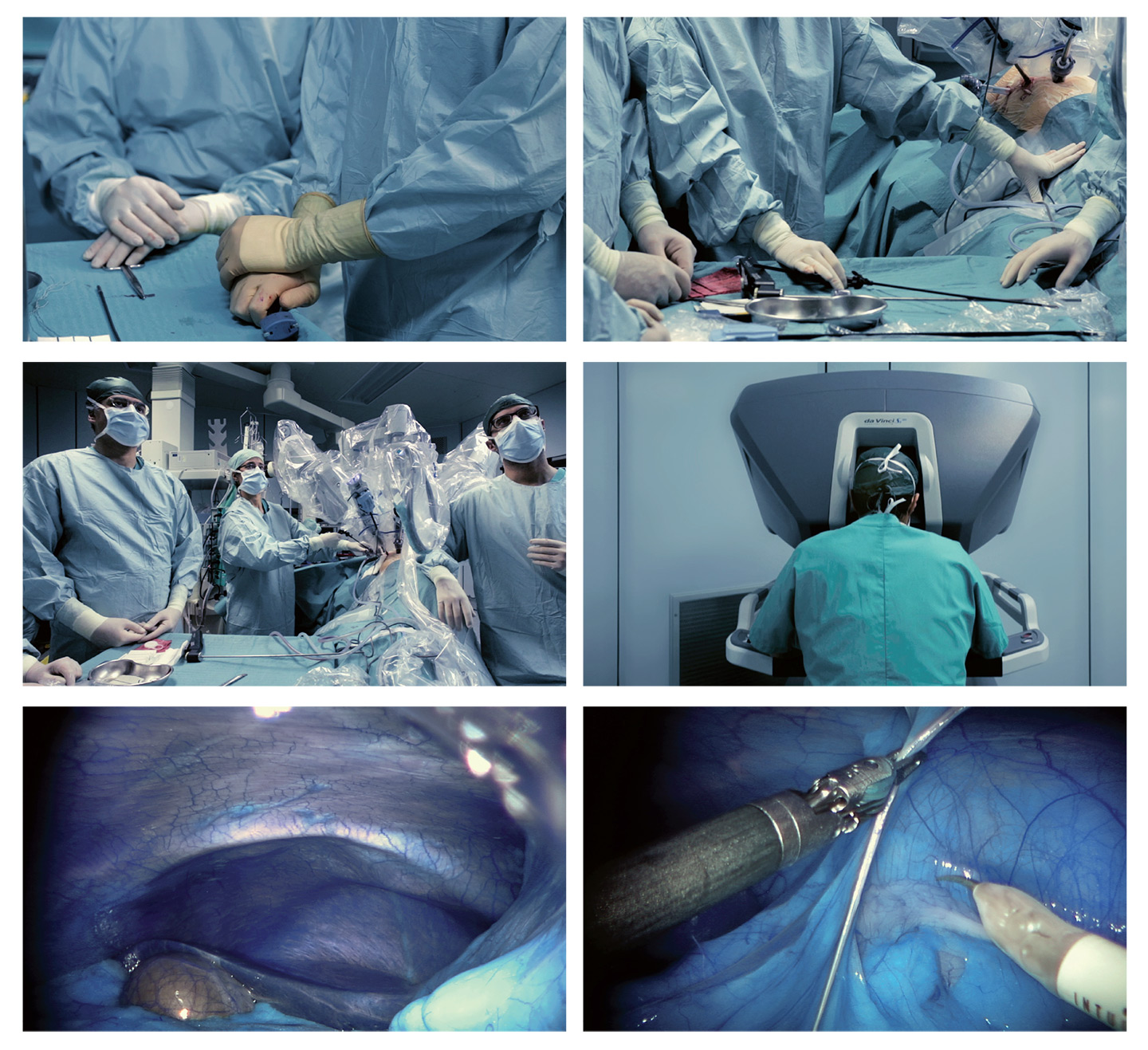Originariamente pubblicato in Flash Art no. 160, Febbraio-Marzo 1991.

Jean Baudrillard: Lo chiami kitsch quel che fai?
Enrico Baj: Il kitsch lo si ritrova in tutti i campi della vita, ma forse è più evidente nell’arte, visto che si pretenderebbe maggiormente una coerenza dello stile.
JB: Ma tu, hai avuto l’impressione di entrare a far parte, a un certo momento, dell’avanguardia?
EB: Ne ho fatto parte senz’altro. È stato prima del 1951: il Movimento Nucleare o, a dire il vero, antinucleare. Nel 1953 c’è stato il mio incontro e l’inizio della mia collaborazione con Jorn. La nostra avanguardia si erigeva contro la razionalizzazione dell’arte e l’invasione del geometrismo, della linea e dell’angolo retto. Sempre nel 1953 con Jorn, nell’ambito di questo impegno antigeometrico, ho fondato il movimento per un Bauhaus Immaginista. È il movimento che ha preceduto l’Internazionale Situazionista, visto che dall’incontro tra Jorn e il Bauhaus Imaginiste, da una parte, e l’Internationale Lettriste, dall’altra, è sorta l’Internazionale Situazionista fondata in Italia nel 1956. Ho avuto i primi contatti con i Lettristes nel 1952. Poi, nel 1954, ho ricevuto una corrispondenza dell’Internationale Lettriste e anche il loro bollettino Potlach. Ho mostrato tutto quanto a Jorn e ci siamo proposti di incontrarli al primo passaggio a Parigi. In seguito, leggendo Potlach ho avuto una reazione negativa. Non mi piaceva questa specie di linguaggio politicizzato che praticavano: una sorta di stile stalinista farcito di accuse e di autocritiche che ammetteva ogni vigliaccheria…
JB: Sì, tutte queste esclusioni… È un po’ il lato poliziesco dell’avanguardia, come di tutte le società segrete.
EB: Si pretende che l’avanguardia sia continuata fino alla Pop Art. Ma la Pop Art perse molto presto ogni spirito sperimentale e ogni carica innovatrice.
JB: Non credo che ci sia stata una sovversione critica nella Pop Art. Né si può propriamente parlare d’ironia. La messa in gioco è diversa: è maggiormente paradossale.
EB: Hai usato il termine “sovversione”, che trovo molto interessante, se giustapposto all’aspetto formale delle cose e dei prodotti che ci sono offerti da vedere. Ma c’è forse qualcos’altro che potrebbe succedere e che potrebbe essere avanguardia, non nel senso dell’opposizione formale, ma nel senso del confronto e dell’opposizione a ciò che è ufficializzato. In fondo gli impressionisti non proponevano tanto manifesti né antagonismi aggressivi ma, per il loro comportamento e le loro opere, si opponevano all’ufficialità, a ciò che erano il gusto e l’estetica correnti. Si opponevano al gusto pompier di un’arte che emanava dal potere e dall’autorità, e che ne era la rappresentazione e la celebrazione. A mio parere, ciò che si vede oggi in certi grandi musei è di nuovo un’arte pompier presentata sotto un’angolazione diversa. Spesso si tratta di “installazioni”, vale a dire di monumenti al gusto corrente. Cioè un conformismo dell’ufficialità basato ampiamente su di un gusto per i materiali, sfruttato sino alla ripetizione, come avviene in certe opere dell’Arte Povera, o nella rappresentazione di immagini della Campbell’s Soup o della Coca Cola.
JB: È un conformismo dell’ufficialità che, invece delle grandi rappresentazioni semi-religiose, storiche o allegoriche, pontificali o ceremoniali del XIX secolo, viene dal basso, viene dal ceremoniale della banalità e della quotidianità. Non cambia nulla. C’è sempre quantitativamente la stessa massa di arte pompier. Ma quella del XIX secolo si riusciva facilmente a individuarla, mentre oggi avanza mascherata dalla banalità dell’arte, tramite il cadavere eccellente della banalità. Era stato escluso e ora fa il suo rientro trionfante, risuscitato dalla mania attuale di riabilitare tutto.
EB: È sempre stato difficile giudicare. Se qualcuno mi dicesse “Che cos’è pompier?”, potrei avanzare un’ipotesi di probabilità: è pompier ciò che è attratto dalla luce, che non prude e non dà fastidio. Tutte queste grandi cose americane concettuali e minimaliste sono ben lisciate e ben laccate. Sembra che siano state verniciate, come facevano giustamente i pittori pompier prima dell’apertura della mostra, che quindi prese il nome di “vernissage”: si usava verniciare le opere affinché brillassero al massimo. Vedi la scelta di materiali lisci e tecnologici. Anche i materiali grezzi o naturali utilizzati vengono esaltati in installazioni con un sapiente effetto di luce e di spazio che li rende puliti, igienici e brillanti.

JB: Sì, sì, c’è nello stile pompier un effetto “pulito”, un effetto detergente. Ma altre opere si presentano oggi sotto l’effetto contrario della Bad Painting, e sono veramente di stampo pompier per l’impiego dell’antipittura, per l’impiego dello sporco, del “bad”.
EB: In ogni caso i musei e l’ufficialità non si interessano alla Bad Painting, benché ciò non sia definitivo e cambi sempre.
JB: Tu credi che non ci siano Schnabel o altri nei musei? E tutto un imballaggio arbitrario delle possibilità della pittura che si pretende sacralizzare come arte. C’è una tale richiesta dei musei, ma anche della collettività, per la sacralizzazione di qualsiasi cosa, ed è questa richiesta culturale a essere kitsch. Esisteva un altro kitsch, quello dell’arte popolare tradizionale, che non rientra veramente nel campo dell’estetica, ma piuttosto nella produzione artigianale. È kitsch nei confronti dell’arte, ma possiede una propria originalità. Oggi il kitsch è prodotto dall’istituzione estetica stessa. Un po’ come la medicina produce talvolta la malattia (gli aspetti patogeni della medicina). Così si può dire che l’arte, l’organizzazione stessa dell’arte, produca il kitsch, questa escrescenza patologica della dimensione estetica. Tu hai sempre mantenuto la padronanza estetica di ciò che facevi. Anche se le cose evolvono, c’è in te una forma d’esplorazione e d’invenzione che è fedele a se stessa. Non sei trascinato in questa specie di circuito, al limite del patologico, quasi canceroso. Non so in che modo gli artisti stessi vi si ritrovino.
EB: Ogni atteggiamento corrisponde a un individuo. L’insieme degli individui costituisce una massa che può essere la massa degli spettatori di un museo o di una partita di calcio. Finalmente alla massa si vendono i biglietti d’entrata, poi si contano le entrate e se ne trae una filosofia che si riassume nell’espressione della quantità degli spettatori o dei visitatori. Sono dei risultati, delle cifre statistiche che non hanno niente a che fare con l’arte o lo sport; come i best-sellers, bisogna ben ammetterlo, non hanno nulla a che vedere con la letteratura. Recentemente in Italia è uscito un libro tirato a 400.000 copie e per il quale è stata montata una pubblicità mostruosa: manifesti e anche striscioni attraversavano le vie principali delle grosse città, con il titolo e il nome dello scrittore.
JB: La macchina funziona da sé, e come per anticipazione. Ma io voglio porti una domanda: in che cosa, giustamente, la pittura ti offre una possibilità di opporti a ciò, di arrestare questa macchina? Prima c’era ancora un’eventualità di segreto, di lavorare nel segreto della tradizione, al di fuori del mercato, dicendosi: un giorno la gente lo scoprirà. Un ritardo nel tempo che manteneva una differenza di sguardo. Oggi mi sembra molto difficile, ti senti assorbito in anticipo a livello del prodotto, o può esserci nella pittura stessa una forza di resistenza a questo sistema di diffusione, di corruzione e di commercializzazione? Può ancora essere sovversiva un’opera grazie alla sua forza interna, contro il mercato stesso che l’ha fatta conoscere? C’è ancora qualcosa che si possa fare contro il conformismo, contro la dittatura del mercato, contro il sistema dei valori, contro le potenze stabilite? Ad esempio, il punto di partenza demografico dei tuoi quadri solleva un problema umano generale, universale. Tu pensi che, al di là della loro potenza plastica, contribuiranno a cambiare le cose? La demografia, nessuno la controlla, è una sorta di destino implacabile della specie e ci si domanda se ci sia una possibilità di resistenza a questa fatalità. Contro il sociale, contro le potenze politiche, come tu hai fatto con i “generali”. Questi ultimi si possono combattere in termini visibili, ma un problema come il problema demografico è al di là della nostra volontà. Allora, come denunci con la pittura? In che cosa l’opera è qualcos’altro che un’illustrazione drammatica del problema?
EB: Credo che, per quanto mi riguarda, io continui come prima a prendere delle posizioni e a dare dei significati alle mie opere, dei significati che non siano soltanto delle cose formali e che dunque vadano ben al di là dei puri valori estetici. Il problema dell’esplosione demografica esponenziale denunciato dai grandi quadri come sette miliardi per l’anno 2000 che diventeranno nove miliardi e più nell’anno 2020, quindici miliardi nell’anno 2050 e così via, è una cosa che, considerata nel nostro campo, evoca un altro pericolo: quello della massificazione dell’arte. L’arte, che è strumento di riflessione e di contemplazione, è stata trasformata in un fenomeno di massa, quasi come una partita di calcio. A mio avviso, la massa non ha niente a che fare con l’arte, annullando, la folla, ogni possibilità di percezione del fenomeno estetico. È quanto si può constatare alle inaugurazioni, in cui non si vedono i quadri esposti. E, per non parlare solo dell’arte contemporanea, ma anche del genere classico, sappiamo bene che la folla dei turisti al Louvre distrugge l’immagine di Monna Lisa: non si riesce a vederla correttamente. Allora, di fronte alla Gioconda, ti poni tutta una serie di altre considerazioni che riguardano piuttosto la massa che l’estetica. Innanzitutto si constata che il quadro più famoso del mondo non è un quadro, ma un feticcio. Si tratta qui, come spesso in tutta l’arte contemporanea, di feticismo. A tutti i livelli e in ogni campo, la folla rappresenta un grande supporto: se ne è quasi drogati e se ne trae, come fa il potere, la propria giustificazione, il proprio alibi. Malgrado tutto, l’artista non può che vivere e lavorare nella solitudine del proprio studio, tranne nel caso in cui decide di trasformare il suo studio in una “factory”. L’arte pittorica non è un teatro, come si vorrebbe dimostrarlo oggi: l’arte si nutre di solitudine e di silenzio, nozioni che esistono sempre, anche se si ha l’impressione che svaniscano. La massa produce solo delle visioni, delle riflessioni, dei sogni. La massa non produce che kitsch. Trasforma in kitsch anche ciò che non lo era. Vedi la Gioconda con i baffi e l’iscrizione L.H.O.O.Q.: è Duchamp (e Picabia) che ha fatto questo interpretando la trasformazione di questo capolavoro dalla massa.

JB: Io direi che la stessa massa è kitsch, che è la nostra super-produzione kitsch attuale, il prodotto kitsch per eccellenza, nello stesso tempo specchio del potere anch’esso diventato kitsch a un punto tale che non si può più concepirlo in termini di volontà politica: è piuttosto una sorta di figurazione, di scenario fantoccio, proprio perché è riflesso da una massa che è essa stessa kitsch. Non si tratta dunque più di una sovversione dalle masse, ma di una disqualifica del potere attraverso la sua estensione nella massa. Quando il potere si avventura nella statistica, è come l’arte che perde ogni specificità. Ne risulta una specie di contratto perverso tra il potere e la massa, un contratto di manipolazione reciproca. Tutto ciò ci riconduce al problema: cosa si può fare? Suppongo che la tua pittura sulla catastrofe demografica e la sovrappopolazione abbia di mira anche la sovrappopolazione dell’arte e l’eccesso di opere d’arte. Dappertutto c’è un eccesso di informazione e di comunicazione che sono come delle proliferazioni cancerose. Com’è possibile trovare dei rallentamenti, delle lentezze, dei segreti, delle solitudini, come si può capovolgere questa tendenza? Si è persa la forma classica dell’enunciazione e così si è persa anche quella della denuncia. In ciò che fai, cerchi ancora questo punto di denuncia. Ma nel frattempo, forse le cose si sono mosse, sono diventate instabili, pensi ancora di essere al centro di un dispositivo di sovversione, di critica radicale e, in modo sottile, non sai più dove sei. Quando la pittura vuol essere portatrice di un’idea, incorre nel destino attuale delle ideologie.
EB: Tu sai che, ormai, la crisi è permanente dappertutto.
JB: Attraverso la storia, vediamo che le civiltà e le culture si seguono e che, finalmente, accade sempre qualcosa di nuovo. Ma ci sono anche culture totalmente scomparse: dunque può esserci una catastrofe nel senso apocalittico del termine, che non ha più nulla a che vedere con la crisi. Catastrofe nel senso di un processo di accelerazione, di uno svolgimento accelerato delle forme. Tutta la teoria del caos rintraccia così una rivoluzione non più critica, ma accidentale delle forme. Non è la natura a risuscitare le forme, ma il loro passaggio dalla catastrofe, dal fenomeno estremo. Tu hai fiducia nel bene, nella possibilità vitale, naturale, indistruttibile, nella natura, nel desiderio, di resuscitare passando dalla crisi. Nelle ultime opere c’è un brulichio, una promiscuità, c’è senz’altro una parte di orrore. Ma io trovo che, rispetto al periodo dei “generali” e di queste cose, la forma sia molto più riconciliata con se stessa. C’è qualcosa di molto più felice. Può essere il giudizio universale, ma nel contempo è il paradiso terrestre. Non è più esattamente la denuncia caustica di un mondo cinico. Non so se mi sbaglio, ma c’è un’evoluzione… Ora ci sono dei corpi, dei volti, mentre nei “generali” c’erano solo maschere. Io ho meno fiducia di te nella natura, ho più fiducia nella catastrofe per portare il sistema a un punto di esplosione, senza illusione né certezza su ciò che possa accadere. Non ci credo nel senso di una verità, ma faccio l’ipotesi di andare fino al limite e in qualche modo di precipitare il movimento. Tu stesso, quando rappresenti l’apocalisse, quando presenti la catastrofe demografica, giochi con il peggio.
EB: Gioco una certa vitalità che è una sorta di speranza, gioco con il fantastico; penso che una delle forti speranze riposi sul potere dell’immaginario. Ciò non mi impedisce di vedere il peggio come te. Ma non vedo l’accelerazione del peggio come soluzione privilegiata. Effettivamente esiste questa idea del peggio, il peggio come soluzione possibile, seguito da un’apocalisse finale che faccia posto a qualcos’altro. Anche se viviamo in una situazione di noia e di accettazione piatta, cosa puoi sperare, che non ce la caveremo? E che si resti ad attendere la distruzione finale?
JB: Vi sono diverse soluzioni, ed è qui che Warhol mi interessa, a proposito dell’utopia. Tu corri sempre verso l’utopia, ma se è provato che l’utopia (l’immaginario) abbia perso molto del suo impatto, allora la risposta di Warhol è:“Io, sono il vero utopista, cioè non sono letteralmente da nessuna parte, ci sono arrivato”. Vale a dire, tendendo in fondo lo specchio di un’utopia realizzata, anche se quella della banalità totale. Io faccio un po’ lo stesso, spingere le cose, i concetti al limite al fine di provocare una violenta abreazione. Non cerco più l’azione progressiva, positiva, ma l’abreazione negativa, o paradossale, del fenomeno estremo. Strategia della provocazione, e non più dell’invocazione, che è quella dell’ampio e dell’immaginario. Warhol m’interessa poiché sviluppa questa strategia mediatica, macchinale, conforme a quella del sistema, ma più veloce del sistema stesso, senza contestarlo, ma facendolo verificare sino all’assurdità, forzando sulla propria trasparenza.
EB: Ci occupiamo d’arte, di uomini, di antropologia. Ma diciamolo francamente: il nostro amico Warhol, ci interessa maggiormente delle armi nucleari, dell’inquinamento e della desertificazione del mondo
JB: Hai qualche speranza nell’ecologia?
EB: Non ho tanta speranza. Ma non si può pertanto ignorare che c’è un tale inquinamento a tutti i livelli, inquinamento che è sia nell’aria, nelle questioni politiche e anche nell’arte, inquinamento per la deviazione del significato delle cose. Hai notato la confusione terminologica ed estetica che è trionfata all’ultima Biennale? La Francia, invece di opere plastiche, ha presentato dei progetti di architetti. Il premio della scultura è stato assegnato a delle foto. Il premio agli artisti di meno di trentacinque anni è stato assegnato a qualcuno più vecchio e così via. E cosa si può pensare dei “truismi” di Jenny Holzer?
JB: Ah no, è macabro! Ma hai ragione. L’inquinamento non è solo quello dell’aria e dell’acqua, ma pure quello della promiscuità e della confusione dei generi. L’inquinamento per la proliferazione, a mo’ di arte, di qualsiasi cosa, che occupi tutto lo spazio e prenda l’immaginazione in ostaggio. Ordunque, offrire qualsiasi cosa da vedere, è prendere la gente per delle persone qualsiasi, è un ricatto all’insicurezza (quella del giudizio, quella del piacere) ed è cosa inaccettabile. L’arte ha seguito le due vie, a parere mio. Esiste una via rarefatta, in cui le forme si rarefanno; e una via di espansione, del genere polistirene espanso. Lì si può ancora parlare di estetica? Puoi ancora giudicare dal punto di vista estetico qualcosa che non risponde più realmente a una finalità, a una pulsione, a un desiderio, ma che risponde soltanto alla propria scomparsa? Da quel momento il problema è metafisico, non è più il problema dell’arte. Se l’arte ha mai avuto una definizione, è perché si tratta di un lavoro di maestria, per l’illusione, dell’illusione, obbiettivo del mondo. Dunque la maggior parte dell’arte attuale, da tempo, fin dal Dada, io non riesco più a vederla come arte, ma come una sorta di automacchinazione sintomatica di una specie di nevrosi. Così il giudizio estetico diventa secondario, visto che non è più veramente in causa e che non posso più chiedermi se è bello o no. De Duve ne parla nel suo libro: fino a un certo punto, si è potuto dire “questo è bello, questo è brutto” Giudizio estetico. Poi a un certo momento, non si pensa più al termine di bellezza, si dice: “questa è arte questa non è arte” È una linea di demarcazione importante. Ma c’è forse uno stadio ulteriore in cui non è neanche più questione di arte. Quando ci si ritrova a dire “questa è arte, questa non lo è” significa che l’arte, come pratica specifica, è scomparsa. Si è già a uno stadio molto avanzato dell’involuzione. Per analogia con gli stadi degradati dell’energia fino allo stadio inferiore dell’energia calorica, si può dire che siamo a uno stadio molto avanzato di degrado dell’energia estetica.
EB: Si parla spesso di scomparsa dell’arte: prima, si parlava piuttosto di morte dell’arte. In Italia, è stato pubblicato da Giancarlo Politi un libretto tuo sulla scomparsa dell’art… Scomparsa dell’arte in una società che non è ancora scomparsa.
JB: Ma io dico che la scomparsa dell’arte ha in compenso l’arte della scomparsa, non si tratta cioè della fine dell’arte, visto che la scomparsa è tutta un’arte.
EB: Ma tu hai aggiunto inoltre che, in fondo, l’arte non è obbligatoria, non è un fenomeno che deve assolutamente esistere. Dunque una scomparsa dell’arte non porterebbe danni irreversibili.

JB: Ne abbiamo l’esempio. Si sa che certe culture sono pur ben esistite su di una base altra che quella estetica. L’estetica non vi esisteva. Semplicemente, io non credo che finora si sia visto l’esempio di una cultura in cui l’arte sia esistita, poi scomparsa, e passata a un altro modo di espressione. Ma trovo appassionante la fattispecie. Che cos’è una società in cui l’estetica si è costituita quale sistema di valori forti, sistema che ha preso il seguito dei sistemi sacrificali; cosa diventa una tale società se perde questo riferimento simbolico? Si torna allo stadio anteriore oppure si sviluppano ulteriori forme? Non ho realmente una risposta, è un vero problema antropologico. Forse siamo questo futuro tipo di società.
EB: Io penso alla possiblità delle società combinatorie. È quello che sperimento nel mio lavoro in cui tu avrai notato che i grandi quadri sulla popolazione e l’esplosione demografica sono stati realizzati assemblando in modo combinatorio piccoli quadri. Abbiamo parlato della scomparsa dell’arte, o dell’arte della scomparsa, che ti interessa maggiormente. Abbiamo parlato della non necessità dell’arte, e della possibilità del passaggio di una società estetica a una società non estetica o transestetica. Effettivamente, tutta questa massa di gente che rappresento nei miei quadri potrebbe anche essere la massa stessa della pittura, dei pittori. C’è un’incredibile quantità di pittori oggigiorno.
JB: Una demografia galoppante, una generazione spontanea come quella dei germi. Ora, dinnanzi a un tale allargamento fantastico dell’offerta, non si sa più dove sia la richiesta, sempre lo stesso problema: l’aspirazione è problematica quanto l’ispirazione. La gente consuma arte, ne divora. Ma non si saprà mai veramente se ne aveva bisogno, se ne volesse. A ogni modo non si lascia alla gente nessuna scelta. Al limite, tutti diventeranno creatori e saranno dalla stessa parte dell’offerta. Ci saranno ancora dei consumatori?