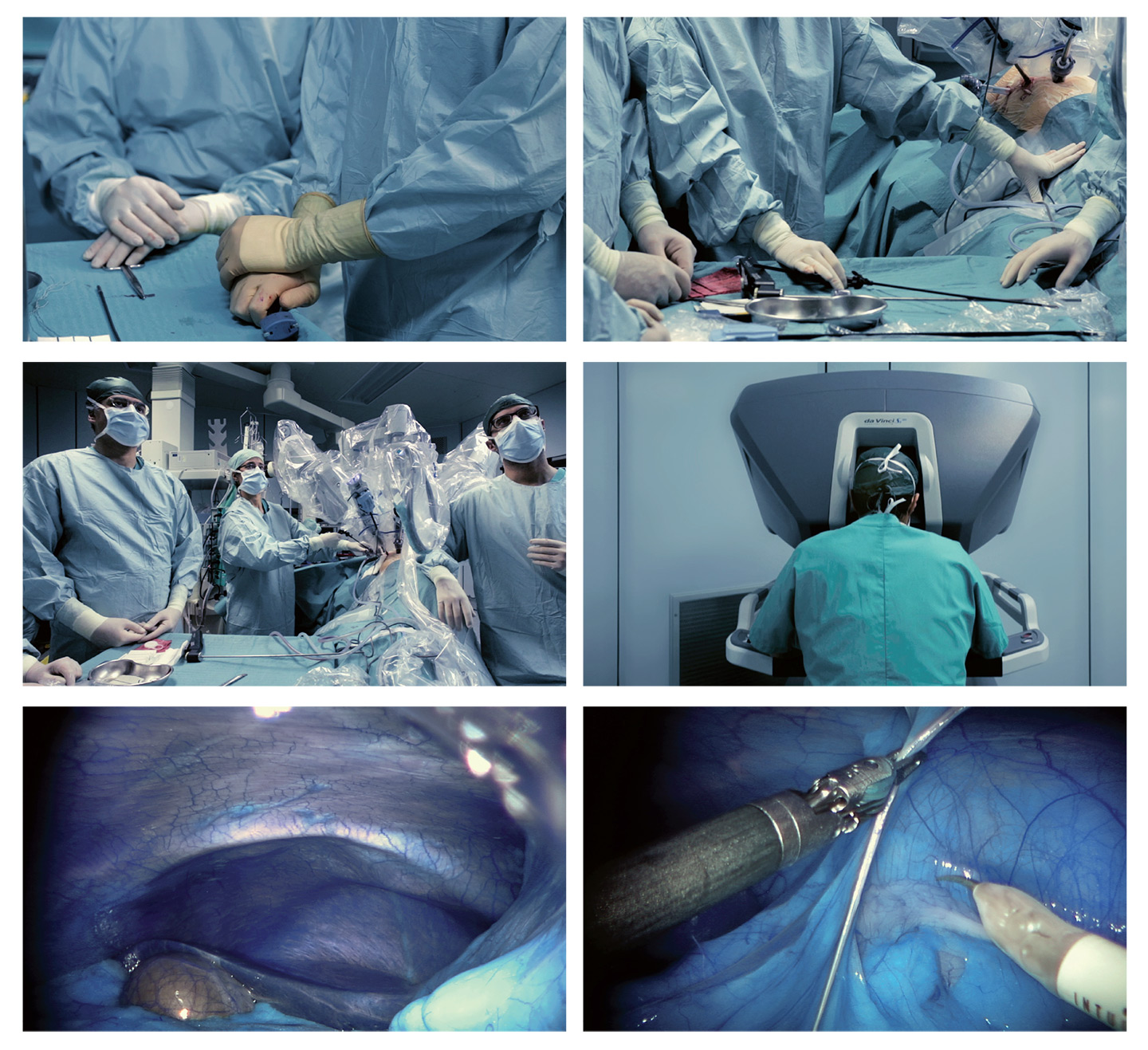Gilad Ratman è uno che cerca. E si stanca di cercare solo quando il suo materiale di base si è interamente consumato e non ha più nulla da offrire, spremuto fino all’essenza. Allora si può occupare d’altro. Perché, da quel momento, è il suo lavoro a parlare, tramite le immagini e i suoni. L’artista israeliano s’interessa, soprattutto, alle origini delle cose. La sua opera video è impregnata di un’atmosfera epica che porta lo spettatore a essere testimone di eventi inconsueti, a volte unici e anomali, eppure carichi di una dimensione universale, nei quali, per assurdità, ci si può riconoscere pienamente.
Spesso, come l’artista riconosce, non esiste un vero punto di partenza nel suo lavoro, tutto è un gran magma, confuso e complesso. Il risultato appare invece chiaro e coinciso, raffinato. Per esempio, nel 2007 si trova a New York, senza un’idea precisa sulla quale lavorare, e per caso scova su Internet l’esistenza di un personaggio alquanto bislacco e molto discreto, the Boggyman, il quale, nel tempo libero, ha l’abitudine di immergere completamente il suo corpo in enormi pozze di fango, fino a scomparire. The Boggyman non è un artista, non è un performer. La sua è una passione amatoriale che nel tempo l’ha portato a divenire un esperto di questa disciplina, fino a diventare il punto di riferimento per un’attivissima comunità online internazionale di “deep sinkers”, con la quale condivide la medesima passione. Affascinato da questo comportamento, tanto radicale quanto insolito e viscerale, Gilad Ratman si mette sulle tracce del personaggio e della sua comunità. Al termine di un processo di lavoro molto laborioso, crea il video The Boggyman (2008) e poi The 588 project (2009) nei quali indistinti esseri umani che ricordano i nostri antenati della preistoria, s’immergono nella melma, emettendo suoni ancestrali, gutturali, liberatori, fra le sabbie mobili. Nella sua opera, c’è sovente una relazione alla natura quasi atavica, una dimensione mitica e profonda, e un rapporto sensuale con la materia e i liquidi. Presentando nel complesso un sentimento di spaesamento combinato a un sottile senso dell’umorismo, le opere video di Ratman sfuggono a una narrazione discernibile. Sembra che l’artista non si preoccupi di raccontare, ma preferisca evocare. I suoi lavori Lublin’s Grip (2001), Che Che the Gorgeous (2005) o Alligatoriver (2006) ben rappresentano tutti questi elementi, condensandoli in pochi minuti. In The Days of the Family of the Bell (2012), l’elemento ironico è presente più che mai.
Dall’intenso viaggio nel mondo del fango, nasceranno altre opere video, tutte legate in un certo senso alla medesima materia di base. Ma tutte differenti. In Buried Metal (2012), Gilad Ratman chiede a cinque band rumene di hard rock di eseguire un concerto nella campagna della Transilvania, con gli amplificatori sotterrati in una grande fossa scavata dagli stessi musicisti, e poi ricoperta, nottetempo. C’è una tensione costante fra l’atto della performance e la messa in scena finale, fra immaginazione e documentazione. Forse non esiste un progresso cosciente nel suo lavoro. Gli elementi che ne fanno parte, però, evolvono all’unisono e in maniera organica. Solo retrospettivamente, quando osserva il risultato finale, con distacco, l’artista riconosce l’esistenza di un elemento comune nel suo cammino, una sorta di traiettoria invisibile. E allora è pronto a ripartire in un’altra direzione.
Ci sono sempre tanti corpi nei lavori di Gilad Ratman. Sono corpi che lottano, che strisciano, che s’inerpicano. Corpi liberi, dalle fatture inaspettate, che esprimono un’autonomia con movimenti e comportamenti che non appartengono alla sfera quotidiana. Eppure sono corpi comuni, sono i nostri corpi. Nella videoinstallazione The Multipillory (2010), l’artista s’ispira a strumenti di tortura medioevale, ma ancora una volta, il risultato è una video installazione scultorea, ironica, lontana dalle sue cupe origini dove il corpo umano, in particolare il volto, diventa veicolo di patetica poesia dal sapore surrealista.
Oggi, Gilad Ratman è l’artista più giovane a rappresentare Israele alla Biennale di Venezia. Presenta The Workshop (2013), un’installazione multimediale che raggruppa sculture, suono e immagini, iscrivendosi nell’atmosfera architettonica del padiglione. Il progetto considera il contesto specifico della Biennale e la complessa e fondamentale questione della rappresentazione nazionale. In esso, Ratman documenta un viaggio sotterraneo, inesistente, di un gruppo di cittadini, che inizia in Israele e termina nel padiglione medesimo. Anche in questo suo ultimo progetto, Ratman documenta un evento al limite dell’accettabile, della realtà, addirittura dell’immaginabile, esplorando l’impossibile e interessandosi soprattutto a corpi nascosti e invisibili, che affiorano solo in un secondo tempo.

In un mondo, a suo dire, sempre più controllato dai satelliti di Google Earth, il solo modo per sfuggire a un controllo intellettualmente sfiancante è affrontare un viaggio sotterraneo, fra le viscere della nostra terra, dove forse esiste libertà.
E cosa succede quando si riaffiora in superficie? In questo caso, il modello di Ratman non è certo attuabile. Appare persino, secondo le parole dell’autore stesso, “assurdo”. Ma è un modello intellettuale che suscita domande, tramite un’elegante messa in scena che scruta il nostro comportamento quotidiano.