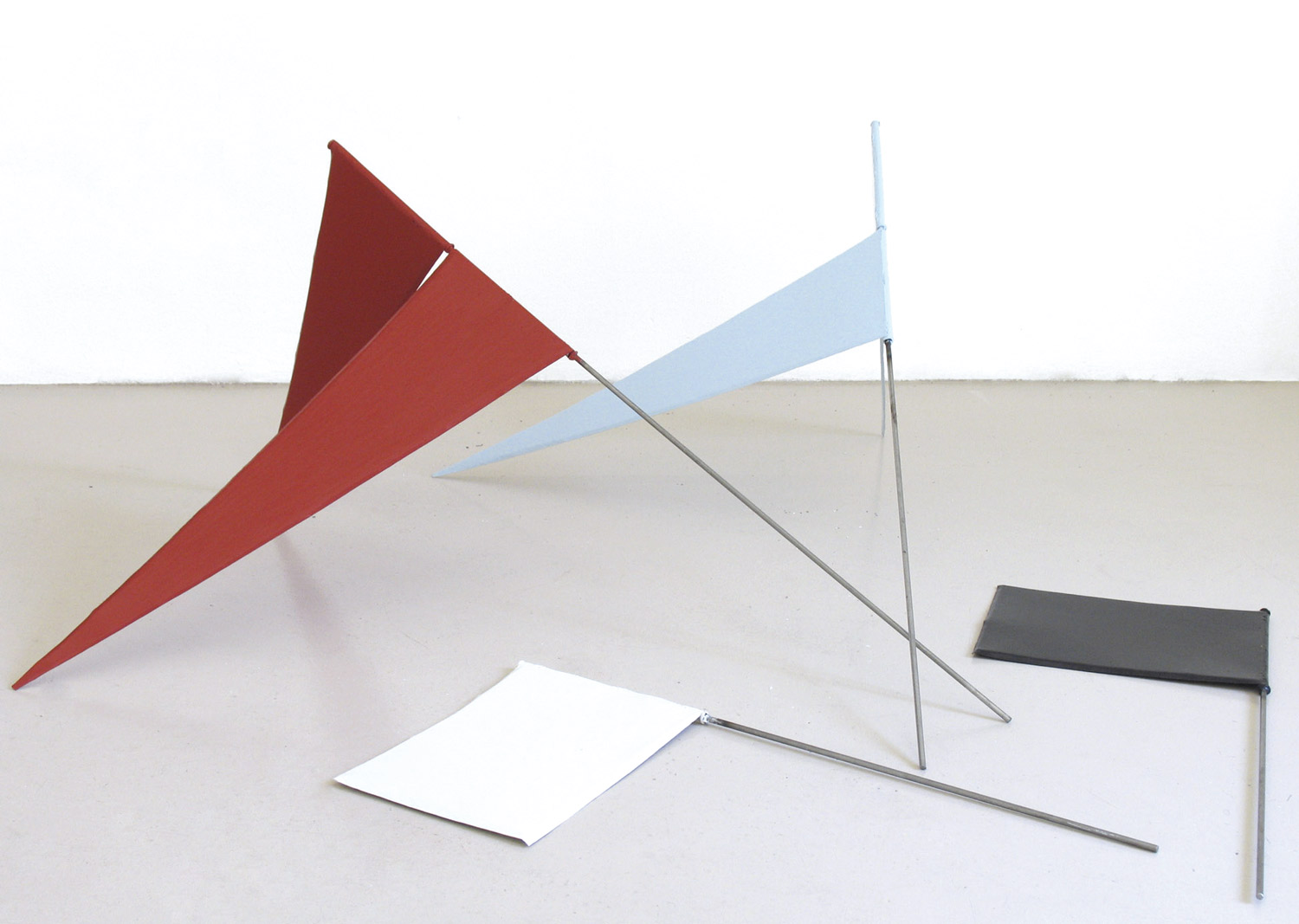Lo scorso 6 ottobre, si è tenuto a Faenza l’evento di apertura del primo Festival dell’arte contemporanea “Futuro presente/Present Continuous”, la cui parte principale avrà luogo nel maggio di quest’anno, proponendosi come il primo forum globale di discussione sui problemi e sulle prospettive dell’arte contemporanea. Nel corso della giornata di apertura si è tenuto un dibattito sul senso e sul ruolo attuale della figura del curatore, che ha coinvolto, oltre a chi scrive, gli altri due componenti del comitato scientifico del Festival, Carlos Basualdo e Angela Vettese, oltre a Okwui Enwezor, Massimiliano Gioni e Michelangelo Pistoletto. Francesco Bonami, in collegamento da Chicago, non ha potuto partecipare attivamente per problemi tecnici. Riportiamo qui alcuni dei momenti salienti della discussione, che ha sollevato questioni di grande attualità.
Pierluigi Sacco: Durante la tavola rotonda ci interrogheremo sul tema del curatore e, in particolare, sul ruolo che questa figura sta assumendo all’interno del contesto internazionale dell’arte contemporanea. Si tratta di un ruolo sempre più visibile, sempre più importante, per molti versi decisivo. Allo stesso tempo però è anche un ruolo che è cambiato nel tempo, assumendo una visibilità spesso paragonabile o addirittura superiore a quella dell’artista. Siete d’accordo?
Angela Vettese: Intanto partiamo dalle esperienze pratiche di ognuno di noi all’interno di un presente che è connotato da una grande mancata quadratura del cerchio: il problema della relazione con il pubblico. Un pubblico che spesso non ha dimestichezza con l’opera, anche se ama cercare una relazione con essa. E poi c’è anche il problema del rapporto con l’opera da parte di chi se ne occupa professionalmente: i curatori. Ovviamente il rapporto con essa, come spesso dicono gli artisti, è qualcosa di estremamente libero. Una volta che un artista ha messo un’opera al mondo e la lascia seguire il suo percorso, le interpretazioni cui essa è soggetta si susseguono, salvo poi arrabbiarsi con chi, nel gioco interpretativo, tocca tasti sbagliati o va fuori binario. Abbiamo visto mostre tematiche giocate molto sulla figura e sulle idee di un curatore, in cui le opere sono trattate più come parole di una frase che come veri e propri testi da rispettare integralmente. Ci sono diversi livelli di comunicazione: ciò che l’opera comunica a tutti, ciò che l’opera comunica a un curatore, ciò che un curatore comunica attraverso un’opera, ciò che una mostra comunica attraverso le sue diverse opere messe in relazione l’una con l’altra. C’è anche un problema di comunicazione tra opera e opera. Questa molteplicità di livelli è il punto su cui non si finisce mai di discutere, su cui i curatori continuano a interrogarsi, e direi che ogni successivo problema nasce proprio da queste dinamiche di relazioni tra testi e lettori dei testi. E quando dico testi intendo la mostra, l’opera o addirittura il libro sull’arte; e quando dico lettore intendo lo specialista o il non specialista, o una sorta di pubblico che non è reale ma è solo pensato da chi, come noi, cerca di proporre qualcosa a quel pubblico.
Massimiliano Gioni: Una cosa a cui ho pensato mentre parlavi, Angela, e che è un aspetto che ultimamente mi interessa e mi intriga molto è che mentre prima l’arte contemporanea era l’incomprensibile per antonomasia, ciò che il pubblico non capisce — e in virtù di questa ignoranza ne è alienato — ora c’è quasi un ribaltamento di 180 gradi: il pubblico sembra quasi amare l’arte contemporanea proprio perché non la capisce. L’arte contemporanea sta cioè diventando sempre più cugina dell’entertainment, proprio perché non trasmette un messaggio dominante e può quindi essere trasformata, modellata allo scopo di intrattenere. È una questione molto delicata, perché da una parte assistiamo a un vero boom del pubblico dell’arte contemporanea, ma dall’altra è giusto chiedersi, senza snobismi: “A cosa stiamo partecipando tutti? Stiamo mettendo in scena una versione easy dell’arte, quasi svuotata del suo significato e quindi buona per tutte le occasioni?”. Ovviamente non ho una risposta, ma in qualità di curatore di alcuni eventi a Milano che generano quasi sempre reazioni o di iconoclastia o di intrattenimento totale, sono domande che io stesso mi pongo. Quando Pawel Althamer espone alcuni suoi autoritratti in cui è nudo, ad esempio sotto forma di pallone areostatico, mi chiedo cosa venga colto di quel percorso artistico, se solo l’aspetto di intrattenimento o anche la dimensione di riflessione più umanistica. Questo è uno dei temi che mi piacerebbe sollevare in questa discussione, soprattutto in relazione a ciò che dicevi tu, Angela. Un altro è questo: è vero che gli anni della decostruzione sono passati, ma è anche vero, come curatore, che certe volte mi viene una gran voglia che gli artisti si mettessero a leggere Roland Barthes o Umberto Eco, perché se paradossalmente l’arte diventa sempre più aperta al grande pubblico, la mia esperienza mi dice che gli artisti sono sempre più convinti di essere gli unici detentori del significato dell’opera, del modo in cui presentarla e del controllo di tutti i dettagli che circondano l’opera e che non sono strettamente collegati ad essa. Non so se questa è solo la mia esperienza, dovuta al fatto che lavoro da meno tempo di voi — per cui mi sembra un atteggiamento nuovo da parte degli artisti — o se è sempre stato così. Però credo che sia interessante discuterne oggi: da una parte assistiamo a un’emigrazione del significato e dei contenuti in un’arena sempre più allargata di pubblico, e dall’altra incontro sempre di più, nella mia esperienza quotidiana, artisti che non solo vogliono che l’opera venga presentata in un certo modo, ma che desiderano magari anche che la tipografia del testo a parete utilizzi un certo font, di una certa dimensione, che il courtesy sia fatto in un certo modo e così via. Mi sembra cioè che il dominio e il controllo dell’opera da parte dell’artista tendano a espandersi sempre di più.
Angela Vettese: Trovo particolarmente interessante quest’idea dell’artista che preme sempre di più per avere il controllo dell’opera fino ad estremi quali l’avere l’ultima parola sulla grafica dell’invito che accompagna la mostra. Mi chiedo però se siano in ultima analisi atteggiamenti estremi o prese di consapevolezza del fatto che questi aspetti collaterali rischiano di generare ulteriori effetti collaterali molto importanti. In fondo sono queste le cose che rimangono in mano a chi visita la mostra: l’invito, il catalogo, e così via. Ovviamente questo è un problema che non si pone con gli artisti deceduti ma con gli artisti vivi, e allora mi piacerebbe chiedere a Okwui Enwezor, che ha lavorato con tanti dei grandi artisti di questi anni, se anche per lui c’è stato questo tipo di esperienza. Penso soprattutto a Documenta XI, con tantissimi artisti da domare…
Okwui Enwezor: La domanda che mi poni Angela è molto interessante, anche se ritengo che la pratica curatoriale sia soggetta non solo al problema dell’equilibrio tra curatela e quest’astratta nozione di opera d’arte, ma anche a molte negoziazioni con le istituzioni, il contesto sociale e intellettuale, la tradizione, eccetera. Riguardo al mio lavoro di curatore e alla sua dimensione intellettuale, parto dal presupposto che il mio intervento non possa mai soppiantare il primato dell’idea dell’opera, dal momento che l’opera è materia viva, in grado di fornire molti e complessi punti di vista, angolazioni e chiavi di lettura di cui il pubblico può fare esperienza. A questo proposito, la relazione migliore che riesco a concepire tra curatore e artista è quella del rispetto dell’opera e dei confini estetici che essa definisce, non tanto per i confini stessi ma per lo spazio di idee che questi sono in grado di generare al loro interno, anche grazie all’interazione con il lavoro del curatore. Non ho mai, in fondo, considerato il mio lavoro come un modo per facilitare l’interazione del pubblico con l’opera, ma più come un serrato dibattito tra me e l’opera. In questo senso, mi muovo in relazione con l’artista, nello spazio che si crea attorno all’opera, che si anima di idee, non solo grazie al modo in cui l’opera viene presentata, ma proprio grazie a questa relazione tra opera e curatore. Più che definire rapporti gerarchici tra artista e curatore, tenderei a considerare la pratica curatoriale come un modo per qualificare, modificare e tradurre l’incontro tra queste due realtà, che diviene fondamentale sia per il binomio opera-artista, sia per chi guarda l’opera. L’esperienza dello spettatore poi è un altro punto fondamentale per chi cura una mostra.
Angela Vettese: Chiederei invece a Carlos Basualdo cosa significa lavorare in un museo, il Philadelphia Museum of Art, così centrato sulla presenza di un’opera inamovibile quale il Grande vetro di Marcel Duchamp, un’“opera-segno” così forte da attrarre — immagino — molti, se non la maggior parte, dei visitatori del museo stesso.
Carlos Basualdo: L’altro giorno, durante una riunione per l’organizzazione della mostra di un artista defunto, il capo degli allestitori mi ha detto: “più l’artista si allontana dal pubblico e più il pubblico ha paura”. Non so però se le persone abbiano più paura quando si allontanano dall’artista o quando si allontanano dalle opere. Il fatto che l’artista non ci sia ci allontana dall’opera. Lavorare con gli artisti, per noi curatori, è magnifico perché ci immette nell’opera. E quando non ci sono il nostro lavoro diventa molto più difficile. Se penso al Grande vetro esposto insieme ad altre opere di Duchamp in una sala del museo, certamente — per le persone che si interessano di arte moderna e contemporanea — quella è la stanza più visitata e io stesso ci sono andato più volte. Per noi che lavoriamo nel museo quella stanza mette paura. Ma allo stesso tempo ci ispira. E mi accorgo che a volte cerchiamo, strategicamente e metaforicamente, di dimenticarci che esista. A volte mi ritrovo a lavorare per mostre di artisti attivi negli anni Cinquanta che non ci sono più. Quello che cerco di fare non è tanto dimenticarmi di loro, ma dimenticarmi del fatto che non ci sono. È un grande sforzo ma è l’unico modo possibile, perché la loro assenza ci impaurisce e rischia di farci allontanare dall’opera.
Angela Vettese: Questo mi fa venire in mente un altro problema ancora più complicato: come fa un artista a dimenticarsi di se stesso? Questo è forse un problema che Michelangelo Pistoletto deve affrontare. Come fa un artista a dimenticare la propria centralità, la propria storia di successo, una storia lunga che comincia negli anni Cinquanta? Come fa a mettere il proprio io da una parte pur dovendo continuare a usarlo come motore per costruire il suo percorso? Certo Michelangelo Pistoletto è un caso unico in questo senso, poiché ha creato una sorta di azienda dell’arte, un luogo in cui la creatività viene diffusa il più possibile, in cui ai giovani viene consentito di lavorare autonomamente senza sentire il peso dell’artista, dell’esperienza dell’artista, ma avendo ben presente la figura del maestro. Questa seconda fase della sua vita in cui è sia artista che imprenditore deve essere una bella sfida.
Michelangelo Pistoletto: La risposta potrebbe essere molto semplice. Fin dall’inizio ho cercato la mia identità, non avendo nessuna idea di chi io fossi, di cosa ci stessi a fare al mondo. Osservavo cosa stava succedendo in arte, ma non avevo ancora capito come poter contribuire a questo straordinario fenomeno, che non era molto facile da avvicinare negli anni Cinquanta. C’erano esperienze forti davanti a me, come l’Action Painting, che parlavano di se stesse, del proprio segno… Il segno individuale era diventato “assoluto”, un segno che la gente finisce per non capire, perché è individuale appunto e così poco pubblico. Arrivare a capire il valore del segno individuale sarebbe una conquista per il pubblico e porterebbe a capire che c’è una possibilità di autocoscienza, di compressione intellettuale personale che può anche diventare un mezzo utilizzato non solo dagli artisti ma da tutti. Per quanto mi riguarda, ho voluto risolvere il problema non con il segno ma con la raffigurazione, e quindi mi sono dedicato all’autoritratto. Ed è attraverso l’autoritratto che ho cercato non più una soggettività che era quella che aveva caricato di forze il segno personale, ma una oggettività. Volevo passare dal soggettivo all’oggettivo, dalla mia problematica individuale a una problematica condivisa o condivisibile. Ecco perché davanti allo specchio, vedendo che riportava la mia immagine in modo oggettivo, ho dovuto accettare la mia immagine riflessa come opera d’arte. A quel punto mi sono trovato a fare un autoritratto che non era più solo l’autoritratto dell’artista ma l’autoritratto del mondo, perché insieme a me, nel mio lavoro, era entrata la società. E in quel momento ero diventato anche spettatore di me stesso, perché mi vedevo così come si vedeva ogni spettatore nel mio lavoro. Ecco perché sono diventato una persona in mezzo a tante, un creatore in mezzo ai creatori. Creatori perché siamo in una società evoluta che a partire dal famoso morso della mela, quando l’uomo ha cominciato ad assumere la propria autonomia, ha reso possibile la creatività. Ecco la radice della creatività, che ha portato poi a fenomeni straordinari come le religioni, le politiche, le filosofie e così via. Dunque la creatività è ciò che oggi ritrovo in questo essere se stessi davanti allo specchio e nell’essere con gli altri nello stesso specchio. L’individuo, insomma, nel momento in cui si specchia vede l’umanità. E quest’umanità è entrata nel gioco e da lì, piano piano, il mio lavoro si è indirizzato a mettere l’arte nella condizione di poter interagire attivamente con il contributo di quella molteplicità di persone, nei vari ambiti del sociale, ed esprimere, individuare quei messaggi, che sono importanti, come ricordava anche Massimiliano Gioni, sui quali bisognerebbe ragionare e discutere. Secondo me il messaggio non deve essere più solo dell’artista o del curatore, ma deve passare dalla relazione tra questi due termini. Io credo che quando non ci sarò più la gente continuerà a guardarsi allo specchio, quindi c’è sempre un modo di essere vivi attraverso un’attività che fa passare i messaggi attraverso gli altri. Sono i messaggi a mantenerci vivi.
Per chi lavora, dunque, il curatore? Per il pubblico, per gli artisti, per se stesso? Per tutti e forse per nessuno. Eppure, paradossalmente, mai la sua presenza nella pratica dell’arte contemporanea è stata tanto forte e percepibile quanto lo è oggi.
Questo rapido scambio di opinioni ci dà delle istantanee su un dibattito che forse non può avere fine né conclusioni, ma che continua inevitabilmente a informare di sé le pratiche di tutti coloro che lavorano nell’arte e con l’arte. E senz’altro a Faenza se ne parlerà ancora, e molto. Arrivederci a presto, quindi…