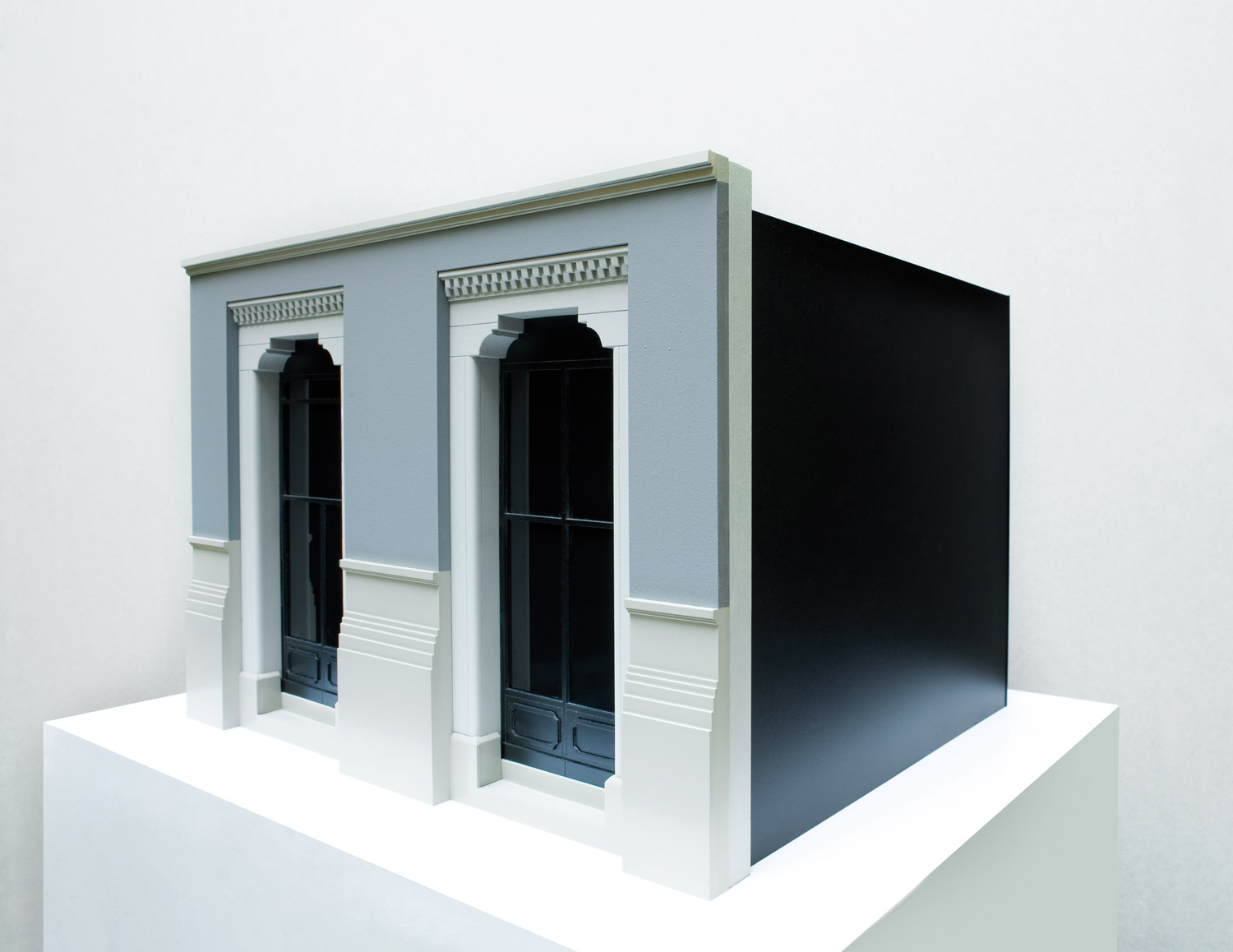Inquietante: “Agg. Che turba l’animo toccandolo nel profondo”. Così il dizionario italiano definisce e spiega il termine che vorrebbe accomunare le immagini selezionate da Germano Celant e Melissa Harris, caporedattrice di Aperture. Eppure non è un caso che questo aggettivo venga spesso usato in riferimento ai sogni, in relazione a qualcosa di inconscio, di profondo appunto. Talvolta i cavilli linguistici hanno una loro ragion d’essere e infatti oggi le immagini che ci inquietano maggiormente non sono certo quelle che vogliono sconvolgere, mostrando l’orrore preconfezionato cui siamo in gran parte abituati, bensì quelle più difficili, più sottili, quelle che accennano al dramma senza risolverlo. Esattamente come accade nelle celebri fotografie di Diane Arbus che, a ragione, aprono la mostra. Poi però le scelte dei curatori proseguono lungo molteplici sentieri, talvolta difficilmente percorribili, in cui spesso si ravvisa più la libertà di scelta e di associazione tipica di un caporedattore — che nel proprio giornale può accostare servizi su artisti anche assai diversi tra loro — che non la rigorosa progettualità di un curatore.
Alcuni degli autori invitati sono tra i nomi più noti della fotografia internazionale, gli altri sono le grandi promesse. Di ciascuno è presentata una selezione di opere esaustiva che, a seconda dei casi, o ne delinea chiaramente il modo di operare o ne mette in evidenza progetti ad hoc. Questo è forse il merito maggiore di una grande collettiva che affianca ventiquattro autori, spesso molto distanti tra loro, di fronte a tematiche di difficile soluzione.
Accanto ai celebri e inquietanti freak della Arbus, i corpi di Sally Mann si rivelano di una bellezza raccapricciante e inspiegata. Le silenziose immagini dai colori pastello di Lise Sarfati trasmettono una tristezza vagamente artificiale vicino ai noti ritratti di Nan Goldin, sempre attuali, irruenti e veri. E se, proseguendo nelle sale, le fotografie di Mary Ellen Mark e Donna Ferrato sono una continuazione coerente del percorso espositivo così come (seppur di tutt’altro genere) quelle estremamente posate di Elena Dorfman e Nina Berman, il lavoro di Letizia Battaglia sembra un superfluo “omaggio” italiano mentre la celeberrima serie “Portfolio X”, di Robert Mapplethorpe, una provocazione prevedibile e forse fuori tema. Poi l’attenzione passa troppo velocemente dal corpo ai luoghi ed ecco allora che le straordinarie documentazioni di Richard Misrach con la loro silente imponenza riescono a passare quasi inosservate nonostante la loro grandiosità. E accanto e in mezzo a questi autori ve ne sono molti altri di tutt’altro genere che rivelano uno sguardo necessariamente diverso, più diretto, oggettivo e meno introspettivo: i reporter. Quelli militanti, che ogni giorno e in ogni parte del mondo documentano quello che succede, primo fra tutti ovviamente James Nachtwey con due progetti, uno sull’Iraq e uno su Haiti. Ma non mancano le immagini di Philip Jones Griffiths sugli effetti dell’Agente Arancio [defoliante utilizzato dall’esercito americano durante la guerra in Vietnam, ndr] — tutt’altro che inquietanti — semplicemente strazianti, o la toccante installazione di Gilles Peress sulle morti in Ruanda intitolata emblematicamente “The Silence”.
Tuttavia il vero silenzio e dunque la vera condanna è quella di Alfredo Jaar che incornicia l’indifferenza delle copertine di Newsweek di fronte al genocidio ruandese. Perché l’arte che parla veramente alle coscienze non è più quella dei grandi proclami.