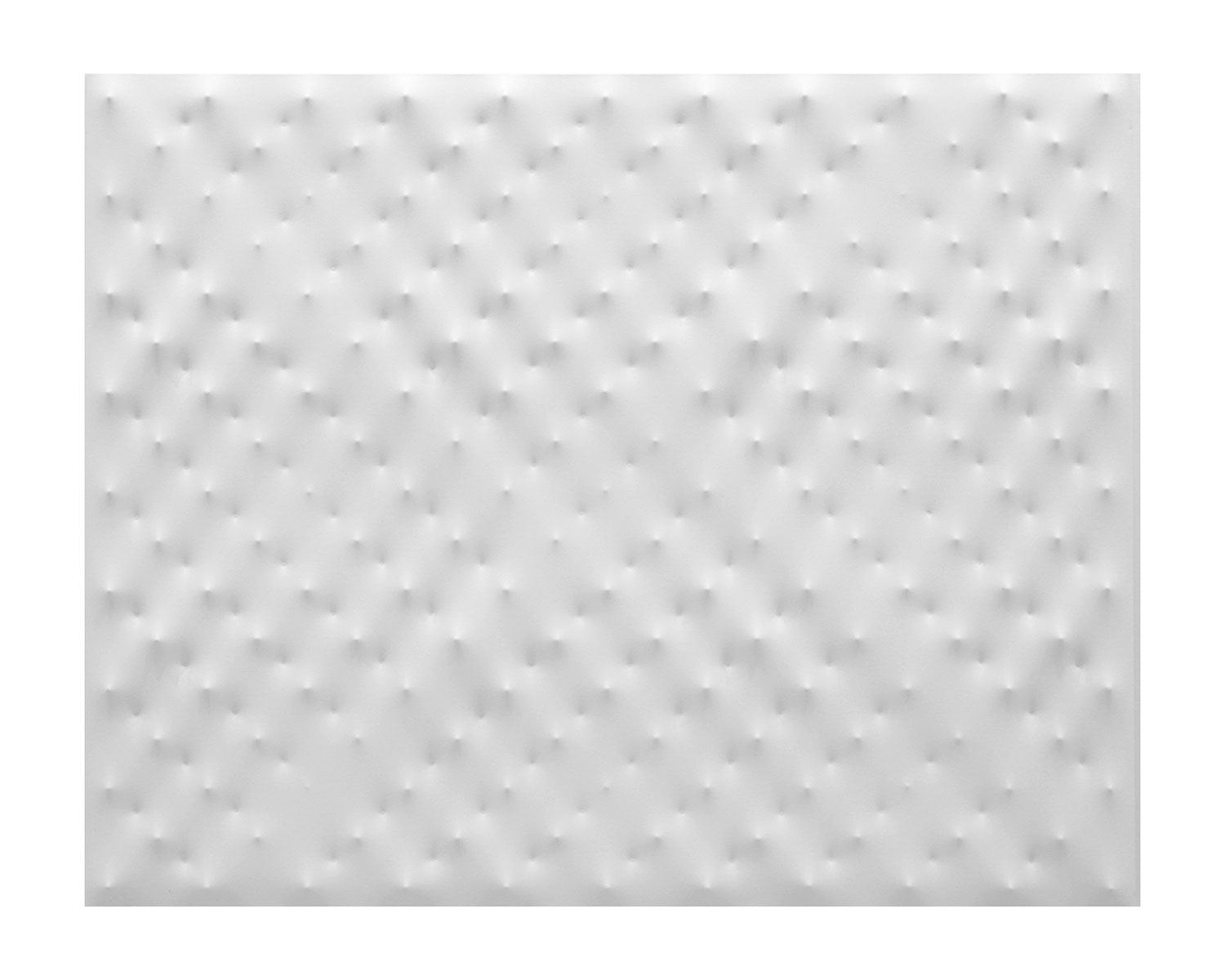A incarnare uno dei look più iconici della serie “Body” di Issey Miyake è la figura di una modella accigliata, con i capelli impomatati pettinati all’indietro e l’ombretto rosso, che veste una gonna plissettata di pelle e un corpetto di rattan simile all’esoscheletro di un insetto. In quest’ultimo capo è evidente la ricerca sulla plasticità del corpo, condotta da anni dal team di Miyake.
Miyake si è conquistato la copertina di Febbraio 1982 di Artforum segnando un punto di svolta nella fusione tra arte e fashion e decretando quanto la moda possa ufficialmente valere quanto l’arte.
L’editoriale della rivista, a firma di Ingrid Sischy e Germano Celant, ha definito l’outfit una “moderna convergenza di segni”, in grado di esprimere qualcosa “fra intaglio e modellatura, fra rigidità e morbidezza, fra il naturale e il dipinto […] un dialogo con passato e futuro, con la condizione dell’individuo all’interno di una tecnocrazia che caratterizza l’avanguardia rivolta alle masse”. Gli abiti di Miyake sono celebri per le plissettature e le pieghe, l’uso hi-tech di tessuti industriali e le costruzioni multiuso che fluttuano intorno al corpo. Alimentati dalla missione utopica di “realizzare vestiti che chiunque possa indossare”, hanno confermato che la moda può davvero fondersi con altre discipline. L’esposizione del lavoro di Miyake di quest’anno al National Art Center di Tokyo è la più recente delle pregevoli mostre istituzionali dello stilista (fra le precedenti degne di nota ricordiamo quelle al Laforet Museum Iigura, Tokyo 1983, al Musée des Arts Décoratifs, Parigi 1988, alla Fondation Cartier, Parigi 1998, e al Vitra Design Museum, Berlino 2001). Oggi la moda è più che mai intrecciata ad altri settori. Sono diversi i musei nati recentemente associati ai grandi marchi, basti pensare a Fondazione Prada e Fondation Louis Vuitton. Inoltre, l’autunno scorso, ogni angolo di Parigi dichiarava l’amore di Céline per John Giorno, l’artista e poeta “amato” anche dal Palais de Tokyo.

In un simile contesto fa quasi sorridere quanto Miyake sia stato in anticipo sui tempi. Nel 1971, con l’apertura del suo ufficio stampa a New York, è divenuto il primo stilista giapponese globalizzato. Ha sempre tenuto in gran conto tecnologia e collaborazione: alla pagina del suo sito web dedicata alla filosofia su cui si fondano le creazioni si legge che negli anni Settanta Miyake “coinvolse una serie di collaboratori sviluppando diversi tessuti nuovi […] che fondevano la manifattura tradizionale alla tecnologia più recente”. L’esempio più evidente è la linea “Pleats Please”, che inventava una nuova forma di plissettatura permanente ottenuta comprimendo i tessuti nella pressa a caldo fra due strati di carta. Ancora, nella collezione “Starburst” del 1998, è possibile leggere una risposta tecno-utopistica alla contrazione delle risorse: imprimendo sottilissime lamine metalliche su cotone, flanella, lana e feltro si ottenevano abiti dall’effetto aerospaziale, lucenti e cangianti. Final Home, il marchio concepito da un componente del suo staff, ha preso spunto dalla paura verso la fine del mondo per creare giacche che si possono riempire di giornali per aumentarne il calore o di “scorte d’emergenza” in caso di evacuazione. È importante sottolineare quanto Issey Miyake non sia unicamente uno proiettato verso l’“high tech”.
Lo stilista infatti ha dato forma a uno dei look più celebri al mondo: il dolcevita nero di Steve Jobs, divenuto poi simbolo dell’intellighenzia tecnocratica.
La storia — raccolta nella biografia del 2011 di Walter Isaacson dal titolo Steve Jobs — inizia verso i primi anni Ottanta, quando Jobs conobbe il presidente della Sony Akio Morita. Durante una visita presso l’azienda, rimase profondamente colpito dalle divise dei dipendenti, disegnate da Miyake. Si trattava di una casacca in nylon antistrappo che, all’occorrenza, si poteva trasformare in gilè attraverso la rimozione delle maniche. Jobs chiese a Miyake di disegnare dei modelli di uniforme anche per la Apple, in modo da rendere il team più affiatato, ma il progetto naufragò a causa dello scetticismo dei dipendenti. A Steve sembrava invece “piacere l’idea di avere un’uniforme per sé, sia per comodità (sua giustificazione) sia per esprimere uno stile caratteristico”. Isaacson, nella biografia, ricorda quando Jobs chiese a Miyake la realizzazione di alcuni dolcevita neri da lui tanto amati e lo stilista gliene mandò “un centinaio”. A riprova di ciò, mostrò al biografo l’armadio in cui li conservava impilati. “Ecco cosa indosso”, disse. “Ne ho abbastanza per tutta la vita”.
Come il personaggio dei cartoni animati Doug Funnie, che apre l’armadio per mostrare decine di grucce con la sua divisa quotidiana composta da gilè verde, camicia bianca e shorts, così Jobs aveva un armadio pieno di Miyake. Portava i dolcevita neri con i Levi’s 501 e le New Balance grigie. Le scarpe rappresentavano la solida comodità, i jeans alludevano allo stile dell’operaio americano e il dolcevita, ovviamente, rimandava al rapporto designer/stilista, l’incontro ottimale fra poeta e architetto.
È straziante pensare che fosse in possesso di una scorta sufficiente per i secoli a venire quando in realtà gli restava poco tempo da vivere. Eppure rivela quella che a mio avviso è l’essenza del desiderio di avere un’uniforme personale: l’illusoria fede nell’eternità.

Negli anni, diversi sono i tentativi celebri di creare uniformi personali. Fra i potenti noti per aver indossato ogni giorno gli stessi capi ricordiamo Giorgio Armani (T-shirt di seta blu, maglione di cachemire, pantaloni blu con il laccio in vita, scarpe da ginnastica bianche), Daniel Libeskind (giacca di pelle di Brioni, T-shirt di Prada, stivali da cowboy) ed Erik Satie (che ha investito una piccola eredità in una decina di completi identici di velluto castano). Secondo Mark Zuckerberg, il suo indossare la felpa con il cappuccio, oramai divenuta iconica, fa parte di una strategia altruistica: “Ho la fortuna di svegliarmi ogni mattina e poter essere utile a oltre un miliardo di persone. Nella mia vita non voglio orpelli, in modo da poter prendere meno decisioni possibili su tutto tranne che su come assistere al meglio questa comunità”. L’uniforme personale fa risparmiare tempo e resiste alla storia, dimostrando che chi la indossa non si lascia intaccare dai cambiamenti del quotidiano e supera l’inquietante conflitto fra autenticità personale e rilevanza sociale.
Ovviamente l’ironia di quello che mi piace definire vestiario a “zero obsolescenza” sta nel fatto che non esiste. L’uniforme eterna diventa sia storicizzata sia profondamente caratteristica. Per me l’inclusione del lavoro di Miyake sul corpo (ora deceduto) di Steve Jobs è rilevante perché mette in contrapposizione due idee di stili e uniformi molto diverse. Steve Jobs rappresenta l’incapacità di avvicinarsi a un look eterno e coerente per la rigidità con cui osservava uno stile. Di contro Issey Miyake si è avvicinato moltissimo a un’estetica eterna — forse più di ogni altro stilista — negando del tutto la coerenza pura.
Nelle sue dichiarazioni è assai diretto a proposito della difficile situazione in cui versa la moda. Il suo obiettivo originario era creare una moda democratica, al contempo “ispirata all’estetica attuale” ma capace di andare “oltre le mode e le tendenze del momento”. Nella pratica, ciò si traduce nel fatto che i suoi modelli si dispiegano in vari contesti dentro e fuori la “vera” moda. Le signore di mezza età, specie in Asia, adorano la linea “Pleats Please” per la sintesi di indulgenza verso il corpo e l’eccentricità visiva. E molte curatrici mi hanno fatto notare che i capi di Issey sono “l’uniforme del mondo artistico”. Alla Frieze Art Fair dello scorso autunno un’amica scherzava sul fatto che, se si dovesse bere uno shottino ogni qualvolta si vede una borsa Bao Bao in resina di Miyake, si morirebbe d’intossicazione alcolica entro la fine della giornata, tanto sono diffuse. Eppure i suoi vestiti non saranno mai “uniformi” nell’accezione di Steve Jobs malgrado abbiano il Dna degli indumenti da lavoro giapponesi. Questo perché nelle loro pieghe, plissettature e volute, i materiali di Miyake hanno un’insita casualità. Si riversano sul mondo in modo fortuito. È come se in ogni indumento superficialmente simile ci fosse una dimensione temporale sconosciuta.

Due linee — la A-POC e la 132 5. ISSEY MIYAKE — esemplificano al meglio come lo stilista abbia usato la tecnologia dei materiali per sovvertire o riadattare il concetto di “adatto a tutti”.
Fra i sovvertimenti e le innovazioni, forse la linea A-POC è la più fenomenale poiché bypassa la costruzione tradizionale, producendo tubi di materiale che consentono variazioni di abiti senza cuciture da ritagliare da un unico tubo. Lo spreco è minimo. Il nome è semplice — A-POC sta per “un pezzo di stoffa” — e gioca sull’assonanza con “epoca” (un accenno alla bomba a orologeria al cuore della moda). Alla mostra “Issey Miyake: Making Things” esposta nel 2000 al Museum of Contemporary Art di Toyko una gigantesca bobina di tessuto, da cui spuntavano forme umane, si srotolava con continuità nello spazio. Ognuna era una diversa declinazione del codice di ciascun indumento. Come scrive Dai Fujiwara, che ha collaborato alla collezione: “Analizzando un abito della A-POC si individua una serie di puntini. Se li si paragona a geni umani, ogni abito può essere formato da duecento milioni di ‘geni’”.
La linea più recente 132 5. ISSEY MIYAKE distilla questo principio in un totale di dieci forme di base piegate, ciascuna delle quali diventa una camicia, una gonna, una borsa o un vestito a seconda di come la si taglia. Aprendolo, un disco piatto di bronzo diventa una borsa o un tubino aderente con una sola spallina. I numeri del nome della collezione sono il codice della strategia di design pluridimensionale: 1 (pezzo di stoffa) può diventare un indumento in 3 (dimensioni) e poi essere ripiegato in un pezzo di stoffa in 2 (dimensioni). Il 4 mancante rappresenta il salto nel futuro. Il 5, infine, rappresenta “la dimensione temporale che prende vita quando l’indumento viene indossato dalle persone”.
La pausa nella sequenza è eloquente. Nella moda la vera eternità non è l’uniforme che fa risparmiare tempo, quanto piuttosto quello che suggerisce il termine: moda senza tempo o che se ne sbarazza del tutto. La residuale segmentazione dei diversi abiti per i diversi momenti del giorno (pantaloni da equitazione per il maneggio, abiti da sera per la cena) è rispecchiata dalla segmentazione dei diversi indumenti per le diverse parti del corpo. Gli abiti dalla struttura piatta tipo quelli di A-POC, di 132 5 o anche il kimono tradizionale cancellano le linee di segmentazione superandole con le loro pieghe. Come ha scritto lo studioso Richard Martin a proposito degli attuali (all’epoca) stilisti giapponesi nel suo saggio del 1995 Our Kimono Mind: “La presenza emotiva e spirituale del vestiario non prende in considerazione il momento del giorno, ma solo l’atteggiamento emotivo e intellettuale dello stilista e quindi di chi lo indosserà”.
È un concetto in netto contrasto non solo con chi indossa uniformi restando aggrappato al proprio stile unico e personale, ma anche con la strategia del pastiche storico di marchi quali J.W. Anderson e Vetements, che tentano di sfuggire all’immaginario temporale della moda fondendo in tutta fretta, in un unico look, significanti di periodi diversi nel tentativo di battere in astuzia un sistema sempre più frammentato costruito su microstagioni, prevacanze e “fast fashion”. In tale contesto, il rotolo di materiale di Miyake sembra più uniforme e fluido che mai. I suoi design convogliano l’eternità nella loro visione estetica e nella casualità della loro declinazione materiale. Catturano lo spirito dell’uniforme — il desiderio di una moda eterna — senza tuttavia osservarlo alla lettera né a spese della realtà corporea. Lunga vita a Issey Miyake.