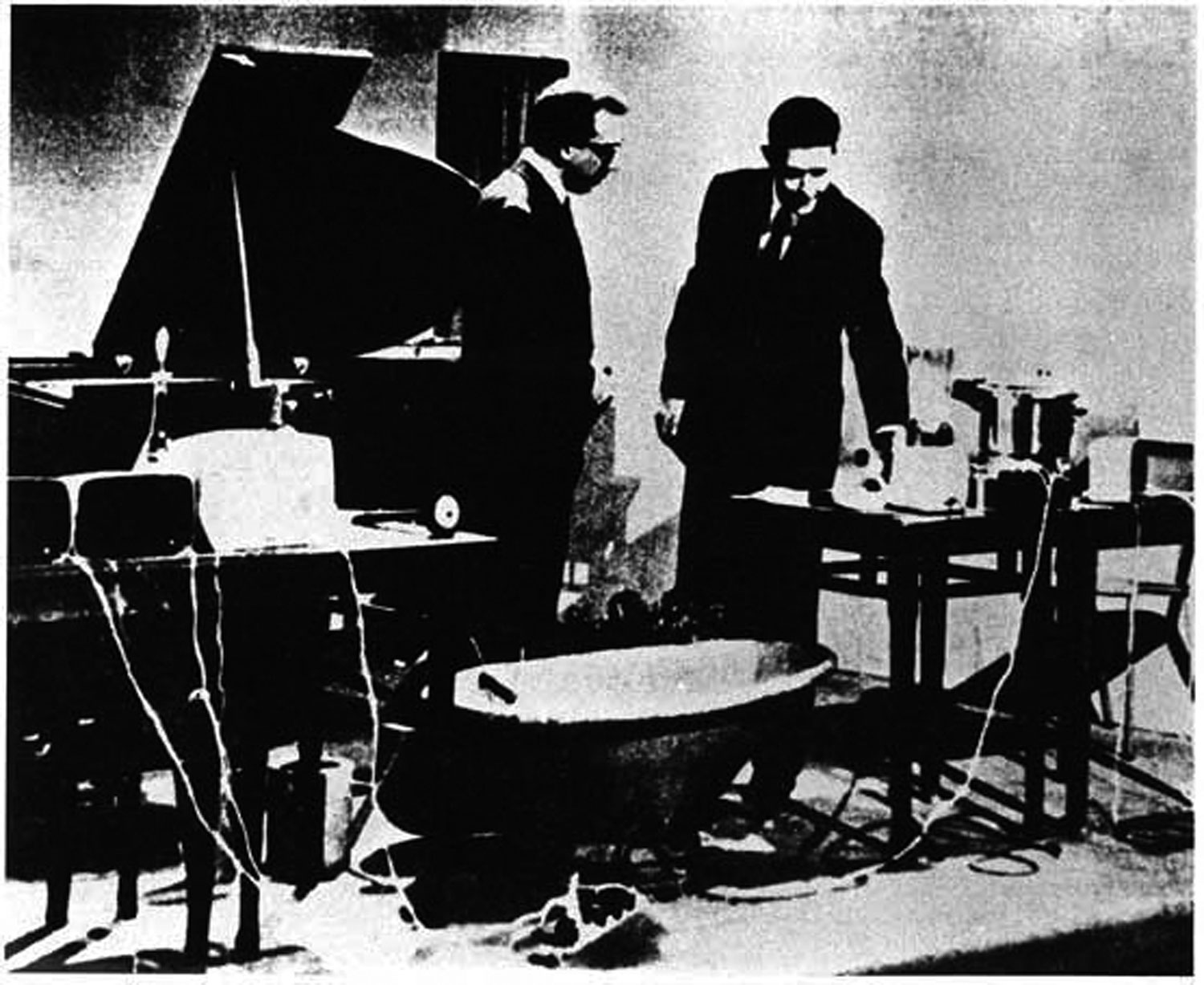Kris Martin è certamente uno degli artisti europei più interessanti tra quanti emersi nel corso di questo primo decennio del nuovo millennio. Qualche tempo fa Massimiliano Gioni tratteggiò un ritratto puntuale di questo mysticus dell’arte, sottolineandone lo humour nero, l’ossessività compulsiva e l’attitudine filosofi co-esistenziale. Trascorsi un paio d’anni, Martin ha nel frattempo realizzato altre opere. Senza inquadrarle nuovamente sul cupo sfondo esistenziale già individuato, che continua a informare la sua produzione più recente (anche se in tono minore), vorrei approfondire il discorso su quella particolare classe di lavori che più di altri hanno caratterizzato fin dagli esordi il modus operandi dell’artista: mi riferisco a tutte quelle opere realizzate attraverso la manipolazione di comuni oggetti d’uso quotidiano. Come un novello Michelangelo, infatti, Martin è maestro nel “cavare” fuori dalle banali cose di tutti i giorni delle autentiche perle, tanto da suggerire l’esistenza di una serie di consuetudini operative. Penso che un’analisi strutturale del corpus di oggetti fin qui collezionati da Martin possa essere molto utile per comprendere meglio come, a un livello più generale, le cose di tutti i giorni tendono a comportarsi e rispondono alla loro “messa in opera”.
La pratica di Martin di per sé non è nuova: muove dall’ortodossia classica del ready made duchampiano innestato sull’eredità concettuale degli anni Sessanta e Settanta. La modalità proiettiva propria dell’objet trouvé dadaista è contemplata, ma sempre molto calibrata. Accanto a questa modalità della somiglianza (qualcosa sta per qualcos’altro), vi è, infatti, un secondo approccio all’oggetto, molto ricercato dall’artista e più rispettoso della cosa-in-sé (qualcosa rimane ciò che è). L’“oggetto retorico” di Martin oscilla continuamente tra i due poli della rappresentazione e della tautologia, mantenendosi in una posizione di relativo equilibrio.

Fatta questa prima, importante considerazione, inizierei col dire, a proposito dell’utilizzo vero e proprio degli oggetti da parte di Martin, che cosa egli non fa: non costruisce mai un oggetto ex nihilo, ma usa sempre e solo oggetti preesistenti o al limite calchi. L’artista non indulge alla semplice de-contestualizzazione di un oggetto — per quanto efficace e spettacolosa questa possa apparire —, ma opta piuttosto per la ricontestualizzazione di oggetti che sappiano istituire un discorso retorico. Possiamo rilevare come, nella maggior parte dei casi, gli oggetti di Martin abbiano subito quattro differenti trattamenti “cosmetici” ben riconoscibili, cui se ne aggiunge un quinto di pertinenza solo semantica. Questi si traducono in quelle che possono considerarsi come delle vere e proprie indicazioni operative: 1) sostituzione della sostanza fisica dell’oggetto; 2) trasformazione della sua sostanza fisica originale; 3) sottrazione di una parte dell’oggetto; 4) combinazione di due oggetti diversi; 5) attribuzione di un titolo. Può verificarsi il caso raro di occorrenze spurie — per esempio in The Readers (2005), dove occhiali, candela e libro dipinti di nero sono ascrivibili addirittura a tutti i gruppi — ma quasi sempre una qualsivoglia opera oggettuale dell’artista è riconducibile a una delle modalità elencate. L’attribuzione di un titolo, spesso determinante in Martin, rappresenta una vera e propria modalità operativa congiunturale a tutte le altre. Qui basti dire che i titoli che ci interessano sono unicamente quelli a carattere indicale. Quando un oggetto, pur rimandando ad altro, rimane se stesso, è difficile che possa innescare da solo la fi gura retorica che l’artista ha in mente. Ecco che un titolo a funzione denotativa, da Martin riferito sempre al termine di paragone in absentia, consente quel nesso referenziale (il cosiddetto tenore) che è poi la vera sostanza dell’opera. Ma vediamo più nel dettaglio i quattro casi di manipolazione dell’oggetto in praesentia individuati.
Nel primo caso, Martin contrappone le marche denotative e connotative dell’oggetto, rintracciando nel sopraggiunto contrasto semantico la sua nuova sostanza fi sica, che in un certo senso contraddice la funzione originale dell’oggetto. Il risultato sono degli ibridi a metà tra oggetto e scultura, degli ossimori visivi colorati di sfumature moralistiche a carattere gnomico e proverbiale: pensiamo all’enorme — e per questo inutilizzabile — spada (Mandi XV); all’umile chiodo, all’imbuto rovesciato e all’ape stecchita forgiati in oro (Golden Spike, Funnel, Bee); all’imperitura fusione in bronzo del teschio dell’artista (Still Alive). Quando invece passa a trasformare la sostanza fi sica originale di un oggetto (o la trova già trasformata), Martin pone l’accento sull’aggressività di quelle forze fi sico-chimiche che agiscono nel tempo minandone l’integrità costitutiva. L’oggetto di turno è trascinato in una sorta di deriva processuale dalle valenze esistenziali, venendo così, di fatto, metaforizzato. È il caso del grande vaso frantumato e ricomposto a ogni occorrenza espositiva (Vase); del cumulo di orologi rotti (Mandi XII); delle sfere perfette che esploderanno tra cent’anni (100 Years); del globo terrestre talmente consunto da apparire irriconoscibile (Globus); della vecchia diapositiva segnata dal tempo (Dia).
La terza modalità operativa è forse quella con cui Martin ha insistito di più, ottenendo, a mio avviso, il meglio della sua produzione. Il meccanismo è sempre lo stesso: la rimozione di una parte dell’oggetto genera la percezione di una compensazione di tipo iperbolico che ha origine dal confronto tra i due termini di paragone costituiti dal prima e dopo dell’oggetto. Pensiamo alla sua copia in gesso del gruppo del Laocoonte privata del serpente: eliminando dalla scena la causa riconoscibile dello strazio che attanaglia Laocoonte e figli, il temibile serpente diviene letteralmente il “rimosso”, cosicché l’angoscia si fa “indicibile” (Mandi VIII); o pensiamo alle campane di bronzo private del suono e non più udibili all’orecchio umano (For Whom). E che dire, sempre in tema di campane, di quelle leggiadre capsule di vetro svuotate delle decine di santi lignei che custodivano al loro interno e che Martin ha ridotto a puri spiriti semplicemente facendoli sparire? (All Saints). Riguardo ai punti conclusivi estrapolati da romanzi famosi (End-Point Series) e al tabellone nero con gli arrivi e le partenze cancellate (Mandi III), si può dire che mentre i primi sigillano dei tumuli, il secondo è un sestante per l’oblio; osservate quindi i remi di legno tutti bagnati che, lungi dall’essere stati tirati in barca, sono fi niti in galleria, senz’altro remando più lontano di quanto non abbiano mai fatto (Ad huc III); o il sottilissimo specchio (mirror) che riduce la vanità dell’uomo (mister) a un’esile fessura (Mr). Menzionerei, infine, l’incredibile mongolfiera, privata di cielo e passeggeri, distesa su un lato e gonfiata all’interno della galleria Johann König in modo che gli ospiti accorsi numerosi al vernissage potessero riversarsi estasiati al suo interno. Vero capolavoro retorico, qui Martin rovescia ogni nesso logico-causale trasformando il velivolo stesso e la mostra in un viaggio (T.Y.F.F.S.H.).

Alla quarta modalità operativa individuata è riconducibile un’altra importante compagine di lavori dell’artista, ovvero quelli che prevedono la compresenza di due oggetti diversi combinati fra loro. Il rispetto quasi reverenziale di Martin per lo statuto tautologico dell’oggetto concede qui qualcosa in più al discorso retorico. Nella fattispecie, in tutti quei casi in cui uno o entrambi gli oggetti componenti l’opera assumono — ora per contiguità metonimica ora per sostituzione metaforica — le veci di “altro”, riscontriamo gli effetti di quella che abbiamo defi nito modalità proiettiva. È il caso della freccetta rossa conficcata a mò di tirassegno su una sezione di tronco d’albero appesa al muro e che, con l’aiuto del titolo, viene trasfi gurata in un cursore a caccia di ricordi (Memoria); o di quelle variopinte calamite con cui si appendono gli avvisi nelle bacheche e che con Martin infestano letteralmente un metallico corpo di Cristo: sono vessilli di tutte le asfi ssianti richieste dell’umanità a Nostro Signore o di annunci del Padre? In ogni caso Cristo è qui un “ponte” (Thirteen Idiots). Pensiamo poi a quel gioiello d’intelligenza psicologica, filosofica e artistica costituito dal pipistrello sotto forma di adesivo applicato a uno specchietto circolare: evocando il disorientamento che la luce provoca al volatile, nonché l’invisibilità del vampiro allo specchio, l’opera fa le veci di un oscuro mondo interiore restio alla riflessione (Soul); non meno geniale è il caso di quel pennello intinto di rosso che ha lambito appena la piccola porzione bagnata di un foglio: un sole al tramonto che, tuffandosi nel mare, lo tinge di sé. Siamo qui al grado zero (al tramonto?) dell’acquerello e insieme all’apice delle sue possibilità espressive (Sunset). Concluderei con la teoria di pietre su piedistallo esposte alla recente personale presso la galleria Sies+Höke: la semplice aggiunta di minuscole croci sulle cime aguzze dei massi ci restituisce una collezione di inaccessibili santuari su una serie di picchi montuosi (Summit). Per quanto riguarda la classica modalità di reiterazione e accumulo di uno stesso oggetto, essa è talmente rara nella ricerca dell’artista da non riuscire a costituire un vero e proprio gruppo di lavori. Mi vengono in mente i due soli casi delle capsule di vetro di All Saints e del cumulo di orologi rotti di Mandi XII (già ricondotti ad altri gruppi).
Il ventaglio di possibili manipolazioni dell’oggetto qui dispiegato non esaurisce certo tutti gli episodi creativi dell’artista e vede inscrivere gli esclusi in un’ultima e onnicomprensiva categoria delle eccezioni. Pensiamo, solo per fare qualche esempio, agli altoparlanti nella mostra tenutasi al White Cube di Londra (What’s the Time) e, soprattutto, a tutti gli estemporanei ma riusciti incontri con la fotografi a e il disegno [Spatium e Untitled (II)]. ?