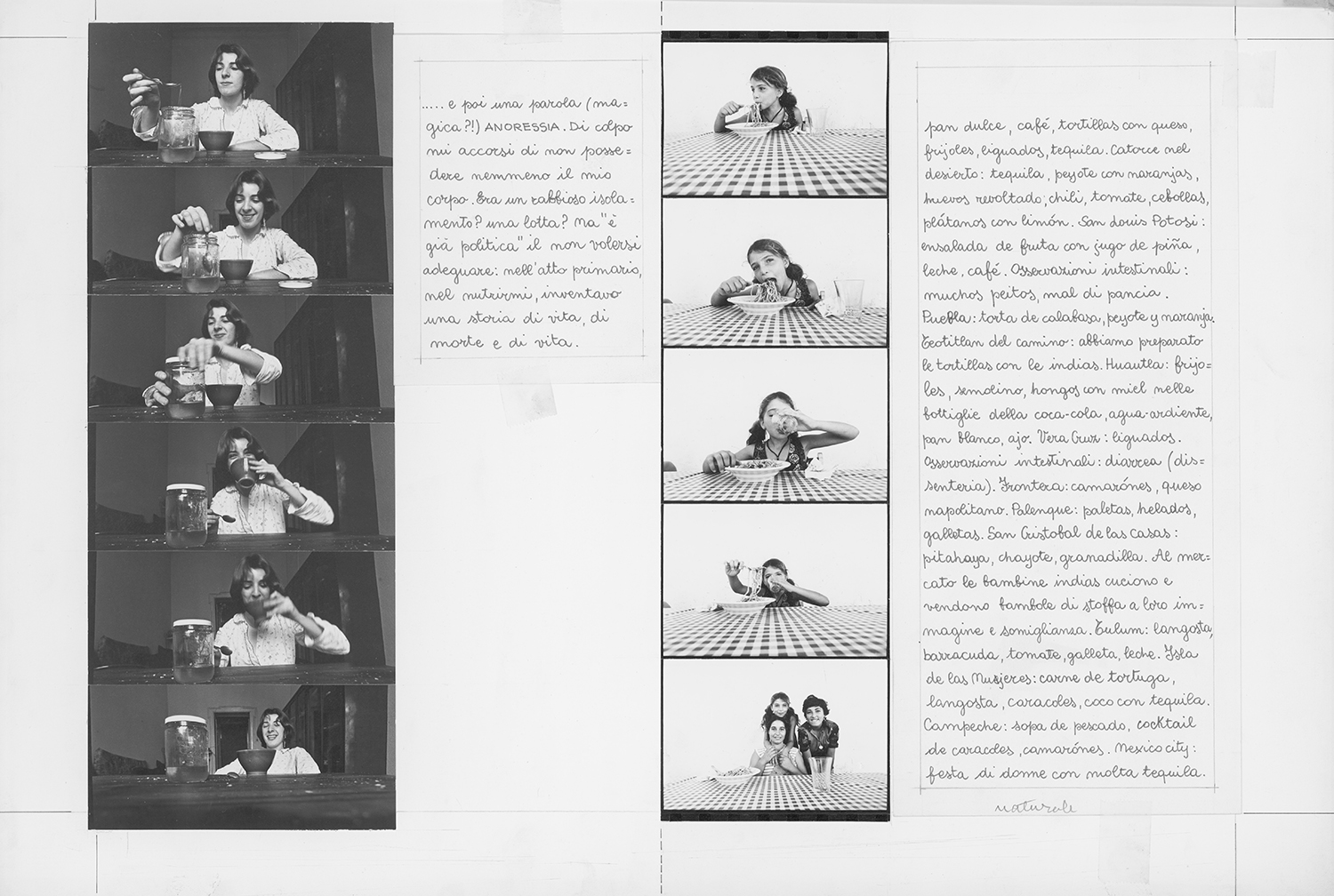Esistono nell’arte contemporanea le fondamenta per la formulazione di un discorso postcoloniale in Italia? Alessandra Ferrini e Simone Frangi passano in rassegna i contributi in ambito artistico che, in anni recenti, hanno promosso un’indagine critica sul progetto coloniale italiano.
Simone Frangi: Il lavoro critico sul colonialismo italiano in ambito artistico è spesso emerso in Italia come un fenomeno “fuori fuoco”, diluito o attenuato. Esso ha fatto rare, alle volte incisive, apparizioni nelle preoccupazioni di alcuni practitionners, in particolare negli anni Duemila, spesso come un tema, a volte come un metodo, raramente come un’etica. Poche artiste e artisti ascrivibili al contesto italiano sembrano aver deciso di inserire nella loro agenda critica e nella loro elaborazione politica la colonialità evidente che popola lo spazio culturale dell’“italianità” e che necessariamente deriva da un filtraggio selettivo del nostro ruolo in quanto potenza coloniale nel passato. Eppure una compensazione sembra necessaria nonché urgente.[i]
ll 9 maggio del 1936 – dopo l’occupazione illegale dell’Etiopia e sette mesi di campagna militare violenta anche con armi chimiche – Mussolini proclama la nascita dell’Africa Orientale Italiana – un impero “creato con sangue del popolo italiano”. Nel discorso di proclamazione del nuovo assetto imperiale, egli descrive la vittoria italiana sull’Etiopia come un momento taumaturgico che associa il popolo etiope al destino dell’Italia, un destino di “civiltà e di umanità”. Ironico e atroce presagio, che aprirà sei densissimi anni di crimini di guerra giustificati come operazioni di “pacificazione violenta” dei territori occupati, estrattivismo, segregazione razziale e madamato. La nascita ideologica dell’AOI è l’ennesimo capitolo di una tossica mitologia della conquista, alimentata dalla volontà della neonata nazione italiana di possedere un impero oltremare e ricalcata su una romanità fantasmata. Essa prolunga un’iperbole ramificata, iniziata con gli acquisti di Assab e Massaua tra il 1882 e il 1884, e l’annessione della colonia primigenia, l’Eritrea, e del protettorato somalo nel 1890; e resa sistemica con l’occupazione della Libia e della Tripolitania e del Dodecaneso tra il 1911 e il 1912.
Nel 2005 Rossella Biscotti dà un iconico contributo alla comprensione dell’impresa coloniale italiana e della sua traslitterazione in impero, sintetizzando quelle utopie espansioniste in The Inauguration of the Empire, mattone in marmo nero realizzato in riferimento alle “prime pietre posizionate nelle colonie italiane per annunciare la costruzione di una nuova società”.[ii] Biscotti mette a fuoco infatti come l’elemento ingegneristico dell’architettura e della costruzione, e quindi della modifica sensibile e della corruzione del paesaggio africano, sia stato un dispositivo di edificazione duratura del futuro coloniale oltremare.[iii] Proprio la fondazione dell’Impero intensifica le ambizioni dell’architettura coloniale, proponendo un richiamo all’ordine degli stili locali delle colonie e un loro allineamento a quello che emerge in quegli anni come il razionalismo mediterraneo. Uno strumento infingardo di training all’oppressione, che ritroviamo ritratto da Vincenzo Latronico e Armin Linke come ancora inalterato in Narciso Nelle Colonie (Quodlibet Humbolt, Macerata / Milano, 2013), reportage testuale e fotografico che esplora l’eredità dell’occupazione italiana dell’Etiopia; e un’occupazione severa, a cui Alessandro Ceresoli dedica il suo progetto espositivo “Ritorno al futuro” del 2011, incentrato sul ruolo dell’architettura coloniale italiana, incarnata dalla stazione di servizio Fiat Tagliero (1938) dell’architetto futurista Giuseppe Pettazzi.[iv]

Sempre nell’obiettivo di articolare la funzione di supporto della produzione culturale alla legittimazione e alla trasfigurazione eroica delle azioni militari abusive eseguite oltremare, Biscotti realizza in due versioni (una nel 2004 e una nel 2007) l’installazione muraria La cinematografia è l’arma più forte, in cui viene ripreso letteralmente il claim che Mussolini utilizzò per inaugurare nel 1937 Cinecittà, che insieme all’Istituto Luce fondato dieci anni prima, costituì il crogiolo privilegiato della propaganda fascista attuata parassitando la cultura di massa. Riflettendo sui medesimi temi in “Secret Modernity”, saggio estremamente analitico del 2009, Peter Friedl osserva come le energie investite da Mussolini nel piegare la produzione culturale al fascismo, abbiano fatto sì che per quelle generazioni cresciute politicamente durante il Ventennio, la conquista dell’Etiopia fosse diventato un altissimo momento di “grande cinema” e che, per Mussolini, le colonie imperiali africane potessero essere controllate come una pura “fantasia cinematografica”.[v] Indagando riflessivamente il ruolo della camera, anche il tuo film Negotiating Amnesia (2015) esordisce con una serie di pannelli che prendono di petto quei luoghi comuni che riducono sistematicamente il portato del colonialismo italiano, le sue dimensioni e la sua atrocità.
Alessandra Ferrini: Come per Biscotti, anche per me precisare l’estensione temporale e geografica di quel momento storico è stato cruciale per calcolarne la gravità. Il progetto coloniale italiano inizia con l’Unificazione d’Italia nel 1861 ed è al centro del processo di costruzione dell’identità nazionale italiana. Oltre ai vantaggi economici, esso si poneva come scopo quello di cancellare la vicinanza simbolica e materiale dell’Italia con il continente africano: affermando il dominio sull’Africa, la carnagione sospetta dell’italiano – un bianco che non era poi così bianco – poteva, infine, essere “sbiancata”. Inoltre, durante l’epoca repubblicana, anche se tutte le colonie erano state perse o restituite all’indipendenza tra il 1943 e il 1947 con i Trattati di pace di Parigi, l’Italia continua a essere un potere coloniale essendole stato concesso un mandato di dieci anni in Somalia (1950-1960).
Ciò nonostante, in Italia, non abbiamo la formazione di un discorso decoloniale specifico, che si è sviluppato invece in Francia, Gran Bretagna o Portogallo in riferimento ai movimenti anti-coloniali nelle colonie stesse. Questa mancanza di contestazione e l’urgenza di lasciarsi alle spalle il Ventennio hanno portato, da una parte, all’identificazione del colonialismo con il fascismo e, dall’altra, alla creazione di narrative autocompiacenti e opportunistiche, volte a ritrarre i colonizzatori italiani in modo benevolo – l’espressione “italiani brava gente” o la nozione di “colonialismo straccione”. Queste vicende hanno contribuito alla rimozione del colonialismo dal discorso pubblico, compreso il sistema d’istruzione. Fanno eccezione gli storici Angelo del Boca, Giorgio Rochat, Richard Pankhurst e, più tardi, Nicola Labanca che si sono dedicati a contrastare questa tendenza amnesica. È solo negli ultimi due decenni che un numero crescente di studiosi si è interessato con legittimità a questa ricerca, portando alla nascita degli studi postcoloniali italiani.
SF: Circa ottant’anni di impresa coloniale, quindi, espressa sotto varie forme, durate e intensità, nessuna delle quali fu lieve, trascurabile, “stracciona” o minore. Come vediamo in Negotiating Amnesia, le categorie storiche, le narrative comuni e la pedagogia italiane sviluppate dopo il 1947 sembrano mirare a una riduzione di portata dell’evento storico e a una revisione della crudeltà e dell’incisività dei programmi coloniali italiani. Un vero e proprio “abbandono strategico” della responsabilità nei confronti di questa storia insabbiata che ha avuto di conseguenza un impatto malsano sul modo in cui regoliamo blandamente i conti, oggi in Italia, con immaginari razziali di stampo coloniale, forme surrettizie di suprematismo, razzismo endemico ed eurocentrismo derivativo.
L’Italia ha assistito quasi inerte a una lunga e lenta carrellata di sintomi di quest’amnesia e dei suoi contraccolpi razzisti e xenofobi: l’ambigua pubblicazione nel 1947 del romanzo abissino di Ennio Flaiano, Tempo di uccidere[vi] o la libertà con cui Indro Montanelli annuncia nel 1968 sul canale nazionale, di aver “sposato” – e quindi di aver legalmente acquistato dal padre insieme a un cavallo e a un fucile – una ragazza Bilena di dodici anni per i due anni di permanenza in Etiopia come sottotenente fascista volontario; o l’ancora più sconvolgente disinvoltura con cui, in un’intervista televisiva con Enzo Biagi del 1982, lo stesso Montanelli parla della sua madama come di un “animalino docile”; la censura e il blocco della distribuzione italiana nel 1981 del film Il leone del deserto di Moustapha Akkad, “lesivo dell’onore dell’esercito italiano” perché dedicato alla resistenza anti-coloniale in Libia condotta da Omar al-Mukhtār contro l’occupazione italiana negli anni Venti; fino alla paradossale erezione ad Affile (Roma) nel 2012 di un monumento celebrativo al “macellaio” Rodolfo Graziani, tempestivamente denunciato alla Procura della Repubblica per apologia del fascismo e, nel 2017, ancora eretto, in attesa della sentenza.

AF: I primi a rompere con questa inerzia e questa muta complicità che ricostruisci furono Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, che attraverso un lavoro meticoloso sui fascismi contemporanei e sulla colonialità residua dell’Europa, riuscirono a ricucire gradualmente una nuova complicità tra produzione artistica e azione e indagine storica. Inaugurata nel 1986 con Dal Polo all’Equatore – esplorazione critica dell’aggressività imperialistica occidentale – e rilanciata nel 1996 con Lo specchio di Diana – angosciosa ricostruzione del culto mussoliniano come conseguenza del colonialismo pre-fascista – la loro iperbole anti-coloniale si compone di più di trent’anni di lungometraggi e cortometraggi.
Attraverso una stampante ottica, Gianikian e Ricci Lucchi riproducono filmati d’archivio un fotogramma alla volta, al fine di dissezionare e smantellare l’immagine (come documento e testimonianza) di una storia di violenza fisica, visiva e culturale. È attraverso questo scavo quasi archeologico che possiamo finalmente restituire lo sguardo di coloro che sono stati violati dalla telecamera e dal sistema di oppressione che ha rappresentato.
Questo è alla base, ad esempio, del film Pays Barbare (2013), in cui Gianikian e Ricci Lucchi cercano di tracciare le radici del fascismo e del suo rapporto con la storia coloniale. Quando l’ho visto avevo appena terminato Negotiating Amnesia e ci ho trovato molti parallelismi. Da un lato, entrambi si basano su un coinvolgimento diretto con la materialità degli archivi visivi – rivelando la prossimità fisica necessaria nel processo storiografico. Dall’altra, esibiscono la volontà di rovesciare “come un guanto”[vii] quelle gerarchie della visibilità su cui si basa l’archivio coloniale e di dialogare con il presente – perché, come afferma Ricci Lucchi parlare di colonialismo significa parlare di neocolonialismo e dei razzismi dell’oggi.[viii]
SF: Proprio a questa relazione di filiazione diretta tra colonizzazione della Libia e del Corno d’Africa e produzione sistemica di immaginari razziali in Patria, Patrizio Di Massimo dedica un onesto e acuto testo, “Orientalismo italiano. Mamma li turchi!”, pubblicato su Flash Art nel 2009,[ix] nel quale dà esordio a un lavoro auto-critico con la ricostruzione di un inventario personale di immaginari culturali orientalisti, assorbiti come costruzione storica e collettiva e reiterati individualmente senza essere digeriti. La tesi di Di Massimo che il rapporto imperialista nei confronti di un generico Oriente o Sud colonizzato nasca da una trasformazione dell’erotismo e della fascinazione carnale in volontà oppressiva[x] è esplorato negli anni precedenti nelle serie di disegni Neretto con palme (2005-09) e Ten Little Niggers (2009), che replicano analiticamente la costruzione della mascolinità nera tramite la stereotipo iconografico coloniale e che porteranno nel 2010 alla video installazione Faccetta nera, faccetta bianca, in cui le canzoni coloniali commissionate durante la guerra d’Etiopia vengono tradotte parodicamente in una posizione erotica tra un corpo bianco e un corpo nero. Trionfalismo razziale e tecniche di razializzazione che verranno poi messi in scacco anche nella performance a Villa Necchi Campilio Fuga dal Disordine (2010), in cui Di Massimo approccia l’uso politico strategico fatto nel fascismo del concetto di “razza italiana” e il suo impatto strutturante nelle arti.
Sfuggendo inoltre al pregiudizio di un colonialismo esclusivamente fascista,[xi] Di Massimo dedica un corpo di lavori consistente alle occupazioni italiane in Medioriente e nel Mediterraneo. Nel 2009 nasce il video collage Oae che, ibridando materiale d’archivio e footage di viaggio girato l’anno precedente in Libia, cerca di rilegittimare la figura di Omar al-Mukhtār. Al simbolo della resistenza anti-imperiale libica, Di Massimo dedica anche una ricerca sonica, basata su testi del processo segreto che al-Mukhtār subisce a Benghazi, mostrando tramite l’uso di opposte intonazioni di lettura, come il revisionismo storico nei confronti di questa figura abbia permesso la censura vantaggiosa dei crimini italiani in Libia.
Con Il turco lussurioso, tra il 2012 e il 2013, Di Massimo cerca di sintetizzare e materializzare con dipinti, disegni, wall painting e sculture oggettuali la sua ormai matura ricerca sull’assimilazione orientalista dell’altro geopolitico e la sua approssimativa identificazione razziale e sessuale, così come sono state agevolate dalla colonialità. Rileggendo il romanzo pornografico anonimo inglese The Lustful Turk – che, in un micidiale incrocio di stereotipi coloniali e orientali, ricostruisce le tappe della seduzione da parte del reggente di Algeri di una donna adolescente inglese tramite lo strumento dello stupro reiterato – Di Massimo mette a fuoco come il corpo sessuato registri, in una prospettiva intersezionale, gli impatti della razzializzazione più cruenta e l’epopea misogina della corruzione della whitness vittoriana da parte di “turco” amorale, approssimativamente costruito.
AF: Dopo Di Massimo, il testimone del lavoro critico sul colonialismo sembra essere passato a pratiche video-based. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom di opere che si occupano della storia coloniale italiana, manifestato principalmente in settori più tradizionalmente interessati alla rappresentazione della realtà come il film documentario.[xii] L’assegnazione nel 2016 del Globo d’Oro per Miglior Film Documentario a If Only I Were That Warrior (2015), diretto da Valerio Ciriaci, è anche prova di un interesse crescente su scala nazionale. Questo lungometraggio segue alcuni protagonisti della campagna per la demolizione del mausoleo a Graziani che menzionavi prima e presenta in dettaglio le atrocità commesse in Etiopia durante il dominio italiano. Contemporaneamente, crea una triangolazione di storie e personaggi tra Italia, Etiopia e Stati Uniti che rivela il carattere transnazionale dell’identità italiana.[xiii]

Parallelamente, investiti dal cosiddetto “documentary turn” che si è affermato con insistenza nella scena internazionale dell’arte contemporanea, molti artisti visivi si sono avvicinati a pratiche documentarie sperimentali. In questo contesto, una nuova generazione di artisti si è dedicata – più o meno direttamente – al passato coloniale italiano, come Martina Melilli nel corto di stampo autobiografico Il quarto giorno di scuola (2015) che tratta della storia degli Italiani espulsi dalla Libia nel 1970, e Francesco Bertocco in Index (2017) nell’ambito di uno studio sulla storia del volo in Italia. In particolare gli Invernomuto (Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi) si sono contraddistinti con la produzione di un vasto corpus che spazia dal video all’installazione.[xiv] Negus (2016) è un documentario concettuale che, attraverso interviste e un sofisticato utilizzo del suono e della performance for camera, scandaglia la complessa eredità di Haile Selassie, l’ultimo imperatore dell’Etiopia, muovendosi tra Giamaica e Italia. Mentre, il video essay MALÙ – Lo stereotipo della Venere Nera in Italia (2015) indaga l’ipersessualizzazione del corpo femminile nero nella cultura italiana.
La decisione di non ricordare o una discutibile insistenza inconscia nel non ricordare; il far timidamente intravedere senza mai rendere pubblico; o il ricostruire storicamente senza mai prendere posizione rispetto ai vizi coloniali hanno sedimentato negli anni un’amnesia colpevole e un eterno ritorno di quell’adesione alle ideologie egemoniche forgiate attraverso l’esperienza attiva della colonizzazione. Iniziare a parlare di questo passato insabbiato è una responsabilità che non possiamo continuare a declinare. Occorre tuttavia farlo con cautela e pensare in modo critico al nostro posizionamento. Soprattutto impegnandosi in un’approfondita ricerca, basata su un codice etico che, sebbene sia una prassi standard nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali, sembra essere arbitrariamente applicato alle arti visive, forse per l’assenza di un’infrastruttura per pratiche artistiche che si impegnano in modo rigoroso in questo lavoro.
La scena artistica italiana è inoltre ancora un luogo di incontestata bianchezza, dove manca una comunità in grado di renderci responsabili – dinamica fondamentale per l’identificazione e lo smantellamento di meccanismi culturali così radicati. E l’unica via per la costruzione di un vero discorso postcoloniale.