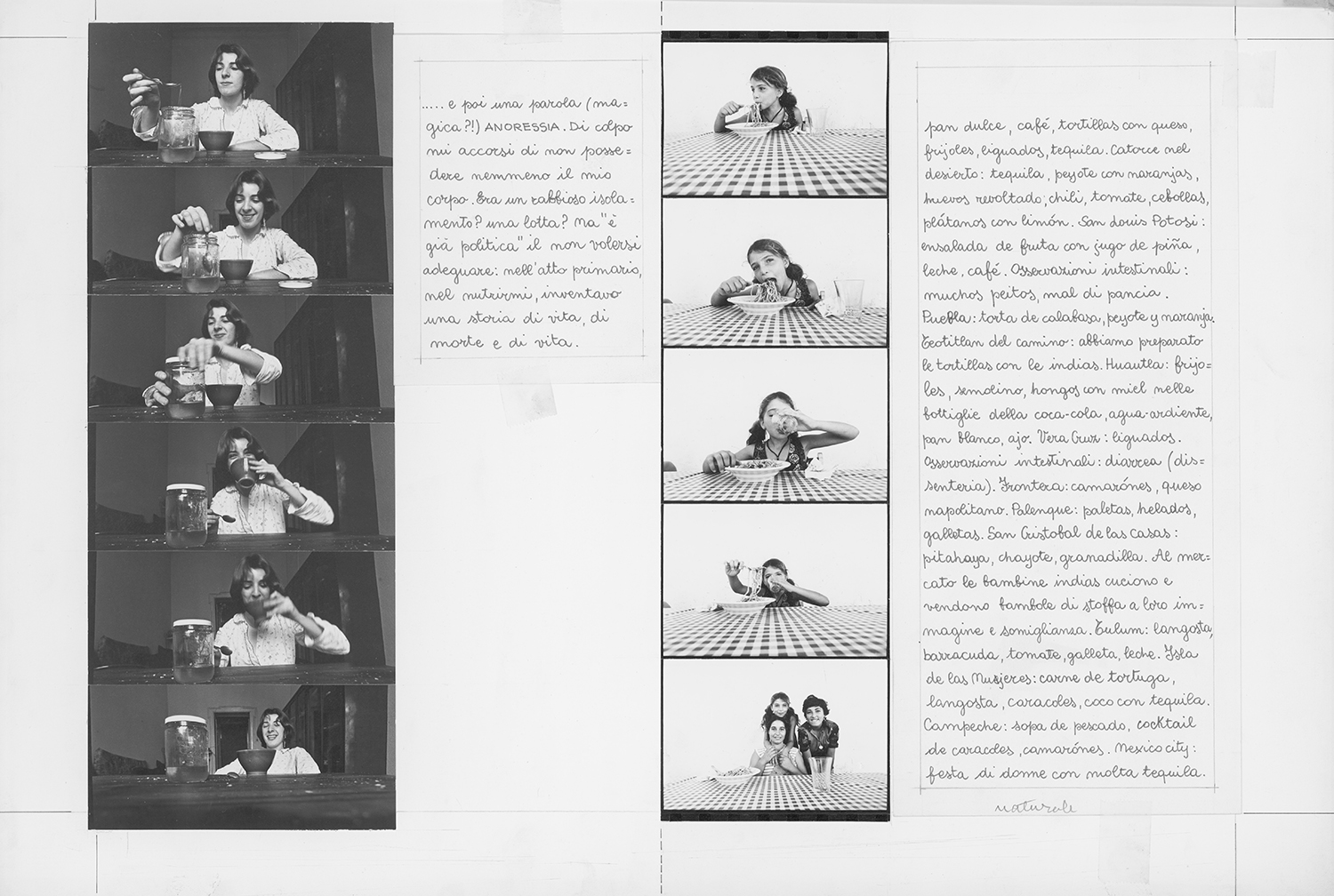Tra il 1967 e il 1968, Piero Gilardi pubblica su Flash Art un diario dei suoi viaggi tra Stati Uniti e Nord Europa. Tornando a quegli scritti, Marco Scotini svela il ruolo chiave che Gilardi avrebbe giocato nel favorire l’emersione delle tendenze postminimaliste, poveriste e concettuali degli anni Sessanta.
Com’è noto, nella primavera del 1969 due pietre miliari nella storia delle mostre definiscono un nuovo statuto per l’arte contemporanea: nelle sue forme di produzione e ricezione, nelle sue assegnazioni di ruoli, nei suoi modi d’essere. Divenuta mitica l’una e caduta nell’ombra l’altra, le mostre “When Attitudes Become Form” e “Op Losse Schroeven” riemergono oggi come il doppio ingranaggio di una stessa macchina espositiva. Un apparato capace di segnare uno spostamento paradigmatico nella definizione dell’arte e delle sue relazioni istituzionali, in risposta alle spinte sociali centrifughe e libertarie del ’68.
Aperte a distanza di una settimana l’una dall’altra e capitanate rispettivamente da Harald Szeemann e Wim Beeren, le due mostre parallele della Kunsthalle di Berna e dello Stedelijk Museum di Amsterdam, pur nelle rilevanti differenze, coinvolgono più o meno gli stessi artisti (al di qua e al di là dell’Atlantico), adottano la stessa strategia allestitiva (improvvisata e informale) così come la stessa configurazione spaziale. Danno forma, infine, a quella tendenza artistica postminimalista, poverista e concettuale, che sarà destinata a rimanere egemonica negli anni a venire.
Ma se tutto ciò è ormai acquisito, meno noto è il ruolo chiave che Piero Gilardi avrebbe giocato al loro interno, nonostante le riletture che recentemente ne hanno fatto figure come Christian Rattemeyer o Robert Lumley. Se si trattasse però di restituire a un artista come Gilardi il solo ruolo di advisor delle due mostre ci allontaneremmo molto sia da una ricostruzione storiografica corretta, sia da un’adeguata formulazione del problema teorico che la sua partecipazione al processo comporterebbe. Al contrario, il recupero di questa genealogia apre a tutta una serie di domande imprescindibili non solo sulla figura di Gilardi (nella sua complessità e potenzialità) ma, più ampiamente, sui modi concreti con cui i dispositivi culturali e le industrie creative si calano – allora come ora – nel vivo dei rapporti di produzione: con le strategie di valorizzazione che mobilitano e le forme di controllo che legittimano.
Qual è, dunque, il senso attuale della riaffermazione della forza propulsiva di Piero Gilardi all’interno di questo processo? Quali sono gli interrogativi che, attraverso il recupero della sua esperienza, sarebbero rimessi in campo? Quali le certezze che ne sarebbero intaccate? Il dato storico in quanto tale non avrebbe alcun significato se non riuscisse a trasformarsi in fattore paradigmatico e, cioè, in un appello allo spostamento (se non al rovesciamento) dei canoni interpretativi correnti.
Di fatto, gli anni tra il ‘67 e il ‘69 sono quelli in cui Gilardi abbandona la produzione dei suoi celebri tappeti-natura e, con essa, l’approccio oggettuale all’arte (che qui è “arte da usare”), in pieno accordo con i processi di de-materializzazione che allora si andavano definendo. La febbrile funzione catalizzatrice e teorica, che si sostituisce ora alla precedente attività dell’artista torinese, non interrompe però l’esercizio della sua dimensione creativa. Piuttosto, questa nuova iniziativa lo vede passare da inventore di forme a quello di formazioni: con spazi deputati che le accolgono (come il Deposito d’Arte Presente di Torino) e nomi propri che le designano (come la definizione “arte micro-emotiva”). I viaggi tra Stati Uniti e Nord Europa, così come la corrispondenza con la neonata Flash Art o le pubblicazioni per la rivista americana Arts Magazine, la svedese Konstrevy e la francese Robho, sono gli strumenti di questa nuova fase creativa. Ma è soprattutto dalle pagine di Flash Art che è possibile capire quali sono gli artisti che Gilardi va selezionando in giro per il mondo e che poi proporrà tanto a Beeren che a Szeemann per le due grandi mostre. Quella sorta di diario di bordo che Gilardi pubblica in cinque puntate su Flash Art nell’arco di un anno – dal settembre ’67 al dicembre ’68 – è un vero e proprio cantiere in cui si raccolgono i superamenti tanto della scena pop che minimalista, in rapporto all’emersione di una nuova tendenza generazionale che Gilardi indicherà come “energia primaria” (in riferimento alle “primary structures”) o arte microemotiva. Le pagine cruciali di Flash Art diventano, in sostanza, una sorta di back stage per “Op Loosse Schroeven” e “When Attitudes Become Form”. Alcuni nomi, fino allora sconosciuti, entrano per la prima volta in Italia come quello di Joseph Beuys (“un vero personaggio tedesco”[i]), di Richard Long (“il più in gamba di tutti gli allievi” della St. Martin[ii]) o di Marinus Boezem (“il personaggio più tipico per un certo modo di vivere degli artisti del nord”[iii]). Altri – in parte conosciuti come Bruce Nauman, Keith Sonnier e Barry Flanagan – cominciano a disporsi all’interno di una costellazione per cui Gilardi scrive “siamo ancora lontani dal sintetizzare una nuova dimensione artistica ma si sente forte e determinante la presenza di una nuova attitudine mentale a vivere in modo individuale all’interno dell’entropia”.[iv]
Gilardi inizia il suo tour da New York dove sta per chiudere la sua importante mostra alla Fischbach Gallery. Si tratta di una fuoriuscita dichiarata dal pop che aveva avuto la propria consacrazione a Venezia tre anni prima. Una fuoriuscita tanto mentale che fisica. Gilardi, di fatto, esce nudo dalla vasca trasparente all’interno del set di The Loves of Ondine (1968) sotto gli occhi di Andy Warhol che lo blocca con “un finto-entusiastico: terrific!”.[v] Ma anche l’inerzia spaziale della minimal gli appare superata da un’apertura sul “tempo”. Tra hippies, manifestazioni contro la guerra del Vietnam e messaggi elettronici alla McLuhan, Gilardi passa da New York a Londra, da Düsseldorf ad Amsterdam fino a Stoccolma – in compagnia di Paolo Icaro o di Tommaso Trini. È convinto che tra i vari centri ci sia “una forte, anche se inconsapevole, unità di intenti”. “Io sento – scrive – che in questo momento la ricerca di taluni artisti italiani non è differente da quella di Boezem, o di Long, o di Nauman e questo non perché si sia creata una universalità di linguaggio ma anzi perché lo si è superato attraverso una visione primaria e una concreta prospettiva individualistica”.[vi] I nomi che Gilardi registra – Carl Andre, Joseph Beuys, Marinus Boezem, Ger van Elk, Barry Flanagan, Olle Kaks, Eva Hesse, Paolo Icaro, Richard Long, Robert Morris, Bruce Nauman, Pino Pascali, Keith Sonnier, Frank Viner, Gilberto Zorio – finiranno tutti nella lista degli artisti delle due grandi mostre.
In quest’ampia costellazione artistica Harald Szeemann è l’ultimo protagonista che Gilardi si trova a incontrare, dopo aver raccolto attorno a sé a Torino la giovane comunità cosiddetta poverista e aver contratto rapporti con artisti olandesi come Marinus Boezem e Ger van Elk, nonché con il curatore Wim Beeren. Come ricorda Jan Dibbets, “Gilardi aveva parlato a tutti noi prima [del contatto con Szeemann] ed era interessato ad unire un gruppo di artisti. Ha giocato un ruolo chiave dicendo che tutti avremmo dovuto collegarci, unirci in vista di un diverso approccio all’arte – cambiando il modo in cui l’arte veniva venduta, sfidando il sistema della galleria e del museo”.[vii] Anche per Marinus Boezem era stato proprio Gilardi “a preparare le menti per “Op Losse Schroeven” in Olanda”.[viii] In effetti, la prima stesura del progetto che Wim Beeren presentò al direttore dello Stedelijk Museum nel dicembre 1968 aveva come titolo “Criptostrutture e Microemozioni” che era direttamente tratto dal concetto di arte microemotiva formulato dall’artista torinese. Il testo di Gilardi “Primary Energy and the Microemotive Artists” era stato infatti pubblicato in settembre su Arts Magazine, mentre la versione olandese “Microemotive Art” era comparsa nello Stedelijk Museumsjournaal con l’introduzione di Ger van Elk.
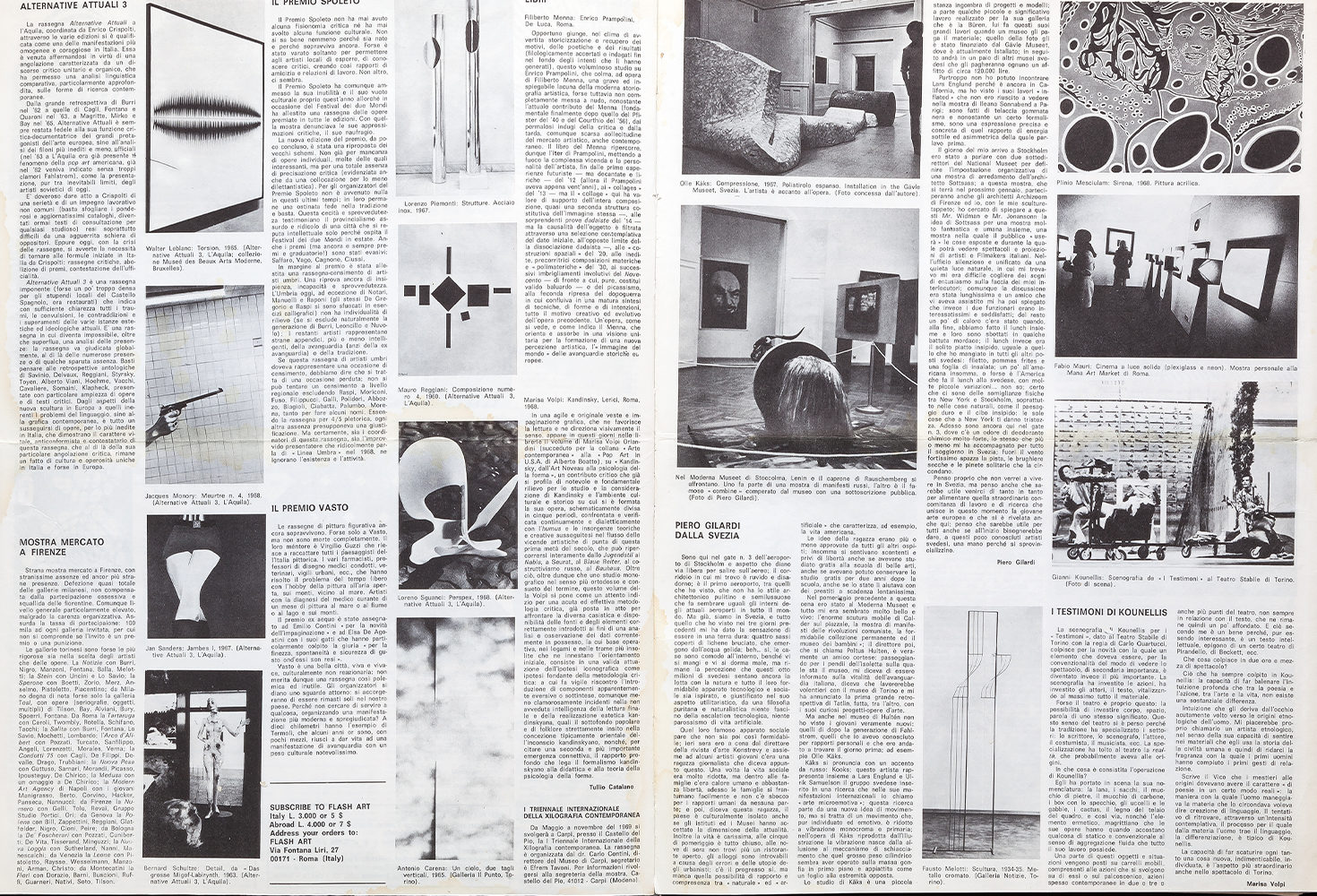
La cornice concettuale attraverso la quale Gilardi leggeva artisti diversi – da Nauman a Hesse, da Long a Merz, da Boezem a Zorio – si fondava sulla dimensione molecolare del movimento, sull’imponderabilità dell’energia, sull’allargamento percettivo, sulla messa in crisi di quel primato della visibilità che era stato l’elemento chiave del modernismo. Una condizione nuova si affacciava: quella che avrebbe permesso l’apertura a un’azione creativa totale, svincolata tanto dagli oggetti che dai segni. Come pure una partecipazione definitiva alla realtà nella promessa ricombinatoria di arte e vita. “Individuare il sottile rapporto energetico tra una cosa e la negazione delle cose”[ix] significava, per Gilardi, eleggere a proprio strumento l’indeterminatezza tra forma e azione. Che in tale modalità l’energia primaria si contrapponesse alle “strutture primarie” così come la micro scala emotiva alla macro scala della “inazione monumentale” dell’entropia (proposta da Robert Smithson), era una consapevolezza che si andava affermando.
Il debito contratto da Wim Beeren nei confronti dell’artista torinese sarà reso noto dal suo saggio in catalogo, così come dal testo “Politica e Avanguardia”,[x] che Gilardi scriverà per la stessa pubblicazione. Mentre chi rimuoverà totalmente il coinvolgimento emblematico di Gilardi dalle fasi preparatorie di “When Attitudes Become Form” sarà lo stesso Szeemann, a seguito di un sostanziale disaccordo sulla gestione della mostra, i termini politici del quale si ripropongono oggi – in tempi di finanziarizzazione dell’arte – in tutta la loro radicalità. In una nota di fine novembre 1968 Szeemann appuntava nel suo diario: “La notte di discussione alla casa di van Elk non riguarda la necessità dell’esposizione quanto il modo in cui questa dovrebbe essere realizzata. Gilardi voleva vedere l’intera cosa come un’assemblea di artisti, da cui l’esposizione sarebbe poi emersa naturalmente: nessuna spedizione, nessun mercante d’arte, piuttosto i risultati dei dibattiti tra gli artisti, e un’autocritica del museo in quanto istituzione. Il titolo della mostra dovrebbe essere il meno impegnativo possibile, non un’ultima tendenza che postuli di nuovo un movimento”.[xi] Com’è noto le attese saranno totalmente tradite e le supposte forme di autoproduzione collettiva della mostra sfoceranno nel loro esatto opposto: nel finanziamento privato del brand Philip Morris e il coinvolgimento di un dealer come Leo Castelli. Altrettanto noto è il fatto che la scelta del curatore svizzero servirà da vero e proprio detonatore per Gilardi che, in perfetta consonanza con le istanze del ’68, sarà costretto a rivedere tanto il proprio ruolo che gli esiti del movimento d’avanguardia che lui stesso aveva contribuito a configurare. Non solo ritirerà il proprio nome dall’iniziativa ma abbandonerà lo stesso sistema dell’arte, per poi passare a una più diretta azione dentro la vita. Anche in questo caso Gilardi doveva chiudere il nuovo percorso con l’amara constatazione dei limiti che il capitalismo pone al soggetto e alle sue possibilità d’azione. Visto che le micro-rotture, le micro-libertà vengono poi riassorbite dalla dimensione molare dell’istituzione pare non esserci altra amara soluzione che quella per cui “l’arte deve restare arte, magari un po’ folle e arrogante, ma non diventare vita”.[xii]
Interpretare il dualismo arte-vita in un’accezione vitalistica e, cioè, come un’eccedenza o un flusso che si contrappone all’inerzia della rappresentazione è totalmente insufficiente (se non fuorviante) rispetto alla ricerca radicale di Gilardi. Se così fosse rimarremmo all’interno di un’estetica “poverista” che non è la sua. Con Gilardi l’antagonismo del binomio arte-vita non si pone tanto all’interno di un momento determinante dell’esistenza moderna, quanto entro un momento ulteriore del dominio del capitale. Dietro la critica a un divenire ridotto a immagini, dietro la scelta diretta del vissuto e non più del rappresentato, c’è il conflitto in atto tra le forze produttive della società e i rapporti di produzione. La separazione tra tali forze e ciò che esse possono emerge sempre più netta con il ’68. Gilardi è tra i primi a riconoscere lucidamente che l’arte non è un’esteriorità data alle relazioni di mercato. Lì dove non c’è più differenza tra pratica artistica e azione, come nell’arte micro-emotiva, la reificazione in segno e cosa sembrerebbe impossibile. Ebbene, anche lì risulta impraticabile portare l’arte alla vita: abbiamo pur sempre a che fare con uno spazio che prima va decolonizzato. Per questo il processo di cattura e integrazione messo in atto da “When Attitudes Become Form” e da “Op Loss Schroeven” (ma anche da “Arte povera più azioni povere” di Amalfi), così come l’asservimento volontario degli artisti d’avanguardia, assumono agli occhi di Gilardi il carattere di fallimento e controrivoluzione.