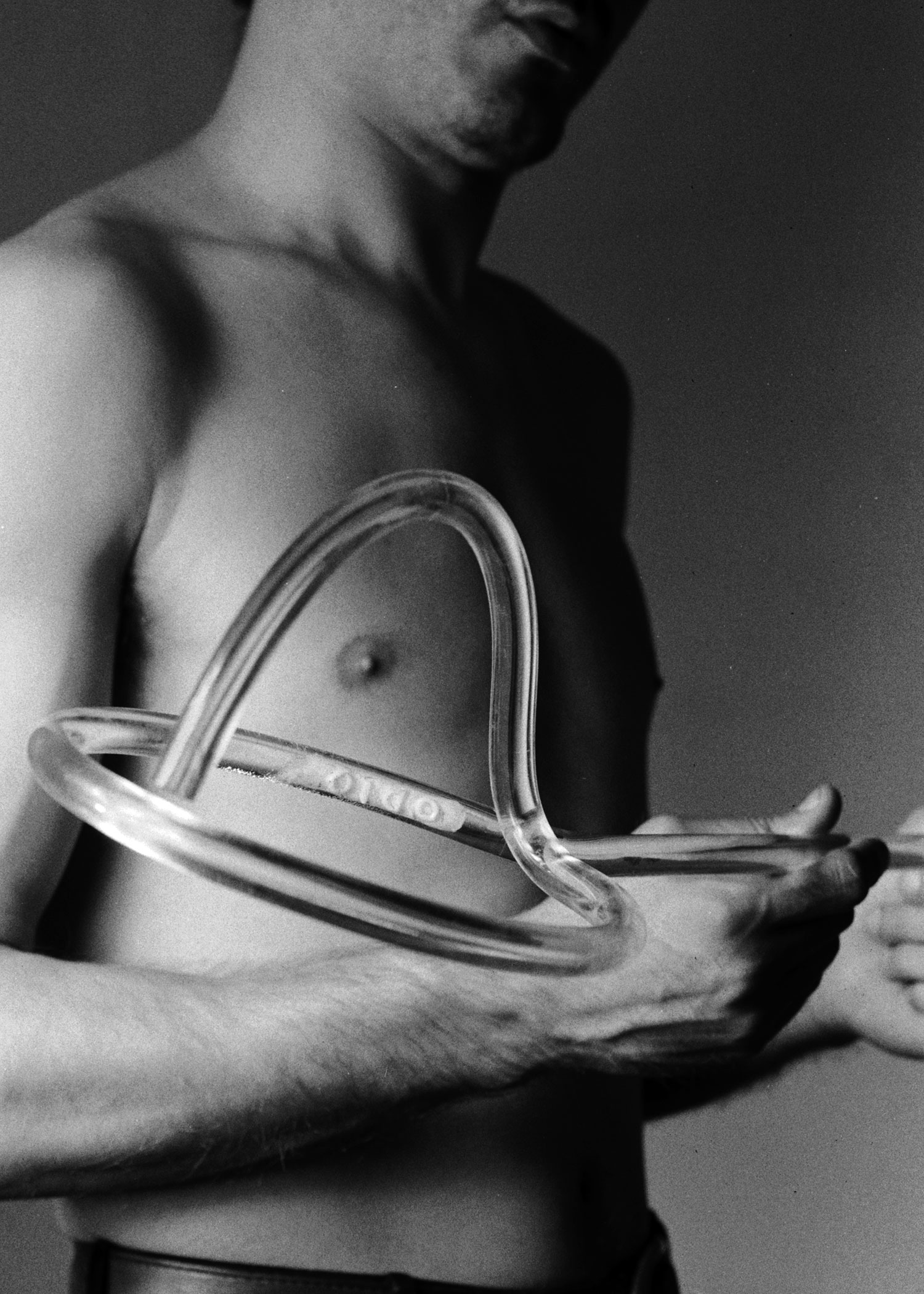Il dibattito pubblico odierno sull’arrivo e la presenza dei migranti in Italia è stato influenzato dai media che, secondo studi sia quantitativi che qualitativi, ne hanno fornito una rappresentazione discorsiva e visiva distorta. Concentrandosi, ad esempio, sulle notizie relative agli sbarchi sulle coste italiane (a Lampedusa, in particolare), all’immigrazione irregolare o agli atti criminali o terroristici, i media hanno rafforzato l’idea di un presunto legame tra migrazione e criminalità, solidificando un’immagine spersonalizzata e discriminante dei migranti come “delinquenti” o “invasori”. I politici italiani hanno ulteriormente corroborato l’identificazione della figura del migrante come “minaccia” per un’identità nazionale etnocentrica, avanzando la necessità di un approccio “emergenziale” per la gestione dei flussi migratori – approccio che implica la militarizzazione dei confini e alimenta ingiustizia sociale e processi di esclusione. Anche il discorso umanitario, come sottolineato nel lavoro di ricerca di Pierluigi Musarò e Paola Parmiggiani, ad esempio, ha prodotto un’immagine distorta dei migranti, rappresentati come “vittime” da aiutare: privati della propria agency, i migranti sono resi soggetti passivi, subordinati e senza voce.[i]
Valeria G. Castelli: Quali sono i fattori storici, socio-politici e culturali che hanno contribuito a generare questo tipo di rappresentazione dei migranti? Ci sono degli elementi che rendono il caso italiano peculiare rispetto agli altri paesi europei?
Giovanna Faleschini Lerner: L’Italia si distingue da altri paesi per due ragioni fondamentali, una legata alla sua configurazione geografica, e l’altra alla sua storia. Con i suoi 7600 km di coste e la sua posizione all’interno del bacino del Mediterraneo, l’Italia è sempre stata una destinazione privilegiata per accedere via mare all’Europa occidentale dall’Africa, dal Medio Oriente, e dai Balcani. L’incrocio tra culture, religioni, lingue ed etnie diverse si è riflesso nel corpo stesso della nazione, che al momento dell’unità ha faticato ad affermare una propria identità centrale in relazione a una molteplicità di identità marginali. David Forgacs, in Italy’s Margins. Social Exclusion and Nation Formation since 1861, analizza in dettaglio come, in risposta alla propria fragilità di nazione, l’Italia ha avuto bisogno di escludere dal corpo sociale certe culture, esperienze e identità etniche ritenute “altre”.[ii]
Nell’attuale momento storico, l’altro contro cui si definisce e rafforza l’identità nazionale è il migrante. E l’analisi di Forgacs considera anche quella che potrebbe essere vista come una seconda ragione per un certo tipo di rappresentazione mediatica dei flussi migratori in Italia; e cioè il mancato riconoscimento a livello pubblico del ruolo italiano nei processi globali di colonizzazione, e le responsabilità italiane nei confronti delle popolazioni che subiscono ancora le conseguenze della colonizzazione europea. L’assenza di un processo di riconoscimento e riconciliazione, nella coscienza nazionale, fa sì che certi atteggiamenti rimangano latenti ed emergano in relazione ai migranti, i quali vengono quindi rappresentati come minaccia all’identità nazionale – in un’eco delle proibizioni relative alla mescolanza razziale – oppure come oggetti della benevolenza civilizzatrice italiana.
Alessandro Triulzi: Parlare di migranti come si fa nell’Italia di oggi (un oggi che dura da più di un ventennio) in modo strettamente binario come pure “vittime di trafficanti” oppure “criminali/invasori” del territorio, dell’identità nazionale e delle sue norme, vuol dire tornare a una concezione dell’altro da sé essenzialmente coloniale. Tale concezione, come nota Giovanna, riflette una mancata decolonizzazione. Anche quando l’Italia cercava giustificazioni altisonanti alla sua espansione oltremare, la tentazione “liberatrice” e “civilizzatrice” del ceto borghese e di governo dell’epoca urtava con quella militare di scontro aperto con la “barbarie”, che andava sgominata e assimilata con la forza. Le amministrazioni coloniali italiane che sono subentrate al governo di Libia, Eritrea e Somalia – per non parlare della breve e violenta occupazione dell’Etiopia da parte del governo fascista – hanno sempre guardato e amministrato i coloni come “sudditi” perché estranei e stranieri alle norme e agli usi degli italiani. Questa concezione ha prevalso nell’impianto delle varie leggi sull’immigrazione che, dal 1991, sono state varate dal governo italiano confermando l’equazione: immigrati stranieri = non-cittadini. Per questo motivo i migranti di oggi sono spesso percepiti non diversamente dai sudditi coloniali di ieri, ovvero individui che non possono rivendicare diritti di cittadinanza ma solo svolgere mansioni esecutive o di manovalanza e risiedere sul territorio “patrio” unicamente con “permessi” di soggiorno e di lavoro che non ostino con i diritti dei nativi. È a causa di questa chiusura culturale, prima ancora che politica, che la “clandestinità” in Italia è percepita come caratteristica innata di ogni migrante e, come tale, è stata mantenuta e rafforzata nella legge (in particolare il “pacchetto sicurezza” approvato dal Parlamento Nazionale nell’agosto del 2008) e soprattutto nelle coscienze e negli immaginari diffusi della società italiana.
Nicolò Degiorgis: Credo dipenda da una visione superficiale e confusa del migrante, che non tiene conto delle diverse ragioni che portano un individuo a lasciare il proprio paese d’origine. Ci troviamo di fronte ad una situazione interdipendente tra conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici che costringono sempre più individui a migrare per sopravvivere. È irrealistico, quindi, pensare di potere frenare questi movimenti; ed è naturale che l’assetto sociale di un paese ne venga scosso. Occorre trovare strumenti giuridici più dinamici che permettano agli stati più permeabilità, senza criminalizzare i migranti a priori o indurli verso un percorso criminale a posteriori.

VGC: Sono molti gli artisti – scrittori, registi, documentaristi, fotografi, artisti visuali – che hanno affrontato il tema della migrazione nell’Italia contemporanea. Attraverso l’arte, questi autori hanno sottolineato, ad esempio, l’assenza della voce dei migranti nel discorso pubblico o hanno complicato l’immagine degli stessi al fine di decostruire stereotipi e racconti superficiali, fornendo nuove lenti interpretative e creando empatia. Tuttavia, la rappresentazione dell’“altro” non è mai neutrale e comporta il rischio di “sfruttare” il corpo del migrante e di renderlo oggetto di quello che Luc Boltanski definirebbe lo “spettacolo della sofferenza” osservato da uno “spettatore distante”.[iii] Lo stesso medium artistico instaura una mediazione e una relazione di potere tra chi rappresenta e chi è rappresentato. Quali sono, dunque, le implicazioni etiche della rappresentazione dei migranti? E quali le responsabilità degli artisti nei confronti dei migranti e del pubblico? Esiste in Italia la possibilità per gli artisti migranti di essere visibili e dare voce ad un’autorappresentazione?
ND: La relazione di potere di cui parli, e che coinvolge l’artista e il soggetto del lavoro, è inevitabile. Credo però non sia data dallo strumento di rappresentazione (come la fotocamera o la cinepresa), quanto piuttosto dal contesto sociale che differenzia la posizione privilegiata dell’artista rispetto al migrante. Non penso sia possibile definire delle implicazioni etiche che assumano un valore universale. L’arte per sua natura deve sapere sviare, oltrepassare o riscrivere le regole. Spetta dunque alla sensibilità e al coraggio dell’artista capire come affrontare certe tematiche, nel rispetto di chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto.
Più dettagliatamente, credo bisogni privilegiare progetti a lungo termine e valutare come verrà disseminato il lavoro. Portando un esempio personale, la scelta di focalizzare la mia pratica artistica sulla pubblicazione di libri nasce anche dal fatto che un libro richiede inevitabilmente una lettura, che si basa su un rapporto intimo tra lettore e autore, sulla narrazione piuttosto che sull’esibizione.
Per quanto riguarda l’autorappresentazione da parte dei migranti, credo sia un fenomeno che poco coinvolge le prime generazioni, occupate a interfacciarsi con problemi relativi all’integrazione. Le seconde generazioni, invece, tendono ad affermare la propria identità in modo più radicale, sia essa legata al paese d’origine dei genitori, oppure al paese in cui risiedono. Queste ultime stanno iniziando ad emergere nella produzione culturale italiana, ma la scena dell’arte contemporanea è pur sempre un ambiente elitario, spesso di difficile accesso.
GFL: Nel cinema, gli sguardi che hanno determinato la rappresentazione dell’esperienza migrante sono stati soprattutto quelli di registi e sceneggiatori italiani, motivati per la maggior parte dal desiderio di ribaltare i topoi dominanti nei mezzi d’informazione (e disinformazione). Gianni Amelio, con Lamerica (1994), è tra i primi a decostruire la possibilità di un discorso identitario permanente e definitivo, e a mettere in relazione il nuovo ruolo dell’Italia come paese di destinazione con il suo passato coloniale da una parte e la sua storia di emigrazione dall’altra.
Inevitabilmente, però, un cinema prodotto da registi italiani di nascita – tranne alcune eccezioni, inoltre, tutti di sesso maschile – per un pubblico italiano non può che confrontarsi con il dilemma che Gayatri Spivak descriveva già trent’anni fa nel suo saggio “Can the Subaltern Speak?”: come è possibile per chi occupa una posizione di privilegio (economico, razziale, culturale) dare voce a chi invece si trova in una posizione di subalternità?[iv] Le narrative di compassione e redenzione – come quelle di molti film sulla migrazione – rischiano semplicemente di confermare la posizione di marginalità dei soggetti della narrazione, piuttosto che restituire loro una voce autonoma.
Esistono, naturalmente, delle eccezioni, tra le quali la più significativa è, a mio parere, l’esperienza di ZaLab a Roma. Ispirato dal teorico del Neorealismo Cesare Zavattin, ZaLab è un collettivo di cinque filmmakers – Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise e Michele Aiello – che produce e distribuisce documentari e video partecipativi, soprattutto centrati sulle esperienze dei migranti. Il video partecipativo è strumento di libertà espressiva che permette ai migranti di comunicare il proprio sguardo sulla realtà, in dialogo con i registi del collettivo. Dai laboratori di ZaLab sono emerse auto-narrative di migranti, come per esempio quella di Ibitocho Sehounbiatou in Ibi (2017) diretto da Segre. Il film racconta la storia di una donna del Benin attraverso le sue fotografie e video realizzati nel corso del suo soggiorno in Italia, dai primi anni 2000, fino alla sua morte, avvenuta nel 2015.
AT: Le migrazioni nel mondo contemporaneo sono un tema che si trova un po’ ovunque nel panorama letterario, teatrale, musicale e audiovisivo in Italia e non solo. Ovunque artisti mettono in luce e denunciano la condizione del migrante come classe transnazionale di emarginazione, negazione di diritti e ipersfruttamento da parte di governi e opinioni pubbliche sempre più insensibili o inconsapevoli. Il rischio di questo registro interpretativo è il proliferare di rappresentazioni più centrate sulla sofferenza dei corpi, che sulla imprenditorialità dello spirito umano e la sua capacità di reazione di fronte ad avversità esterne. L’accentuazione del lato vittimario delle persone migranti colpisce la capacità di azione e determinazione individuale, che è fondamentale nell’esperienza migratoria. In questo continuo negoziato per la sopravvivenza, la rappresentazione dei migranti come corpi unicamente segnati dal dolore o dalla sofferenza, quando non dall’assenza stessa di vita, finisce per negare la vitalità di persone determinate a replicare o reagire alle avverse condizioni di vita e rischia di avvalorare la linea (cattolica) della carità e della tolleranza e non quella (civica) dei diritti e della condivisione di cittadinanza. Al di là dei mutati scenari politici e degli immaginari diffusi sull’altro clandestino e straniero nell’opinione pubblica italiana, la responsabilità degli artisti, anche quelli migranti, è di confermare l’impegno etico-estetico preso con se stessi di non violare la consegna del bello, cedendo a rappresentazioni spettacolari della sofferenza o del dolore che rischiano di alienare o svilire moti di empatia e vicinanza.
VGC: Come può la rappresentazione dei migranti in Italia proporre, attraverso l’arte, delle contro-narrazioni e delle visioni alternative rispetto a quelle che saturano le produzioni discorsive e visive dominanti? Quale può essere il ruolo degli artisti (migranti o non-migranti), da una parte, nel creare un documento che diventi testimonianza del vissuto dei migranti e di un sistema di securitizzazione dei confini che genera discriminazione e, dall’altra, nell’immaginare una società più aperta, inclusiva e multiculturale, che non derivi semplicemente dal possesso della cittadinanza, ma dal riconoscimento di una condivisa dignità umana?

GFL: Il progetto culturale e artistico di ZaLab – di cui già abbiamo discusso – è, a mio parere, il modello più efficace da seguire. Tuttavia, bisogna riconoscere che esistono ormai diverse generazioni di nuovi italiani, figli e nipoti di migranti, le cui storie hanno diversi contenuti rispetto a quelle delle generazioni precedenti. Penso, per esempio, al film di Suranga Deshapriya Katugampala, Per un figlio (2016), che racconta il rapporto tra una madre che ha lasciato lo Sri Lanka per lavorare come badante in un piccolo centro del Nord Italia, e il figlio adolescente, che desidera integrarsi tra gli amici italiani.
Se in letteratura Igiaba Scego, Gabriella Kuruvilla, e altri già da anni raccontano storie centrate sul contrasto generazionale e culturale all’interno di famiglie di origine straniera, nel cinema l’enfasi è rimasta per la maggior parte sull’epica del viaggio e su un altro tipo di conflitto, quello tra italiani e migranti. Credo che le produzioni più innovative e interessanti siano, a questo punto, quelle che spostano lo sguardo sulla quotidianità dell’esperienza migrante, e che di questa esperienza colgono le dimensioni concrete scostandosi dalle strutture del dramma realista: il romanzo Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2006) di Amara Lakhous; o nel cinema, Into Paradiso (2010) di Paola Randi, Là-bas. Educazione criminale (2011) di Guido Lombardi, Le ferie di Licu (2006) di Vittorio Moroni, o Giallo a Milano (2009) di Sergio Basso. Questi autori si allontano dalla “spettacolarizzazione della sofferenza” e trattano con leggerezza calviniana la normalità di una società italiana sempre più multiculturale, multietnica, e plurilinguistica.
AT: Il ruolo e la responsabilità degli artisti migranti nel proporre contro-narrazioni e visioni alternative a quelle prevalenti sui media e nel linguaggio della politica è fondamentale in una fase della società italiana in cui prevalgono scarsa consapevolezza e disinformazione. Naturalmente non è facile combattere un’emissione continua e disinformata di opinioni, pregiudizi e discorsi che oscillano tra il moraleggiante e il razzista.
Il razzismo non è più solo “strisciante” in Italia, ma si è radicato come incubatore e motore attivo di odio e si diffonde a macchia d’olio nel linguaggio comune sdoganando prese di posizione, linguaggi, e azioni apertamente repressive e discriminatorie impensabili solo pochi anni fa. Gli artisti migranti, e al loro fianco chi si oppone a questa deriva razzista, non hanno altra strada che ribadire – come ricordato da Nelson Mandela e da Desmond Tutu nel Sudafrica del post-apartheid – che la diversità è una forma di ricchezza e non di divisione, e che per prevenire chiusure razziste e rigetti dettati dalla paura occorre favorire forme di empatia e di immedesimazione della condizione umana che uniscano e rendano unico e imprescindibile ogni essere vivente. Gli artisti sono gli unici che possono farlo.
ND: Per quanto resti difficile finanziare e sviluppare progetti artistici complessi che affrontino in modo esplicito tematiche sociali e politiche, il mondo dell’arte rappresenta sempre di più un ambiente privilegiato nel quale tutelare visioni eterogenee.
Seppur mi trovi d’accordo sulla ricerca di una dignità umana condivisa e culturalmente trasversale, credo che il ruolo degli artisti debba restare il più indipendente possibile rispetto ai sistemi, partendo da quello dell’arte stessa fino alla politica. L’opera d’arte deve, a mio avviso, mantenere una sua ambiguità e permettere molteplici interpretazioni.
VGC: Nicolò, con Hidden Islam (2014) hai reso visibili attraverso le tue fotografie i luoghi di preghiera dei musulmani in Italia, mentre con Blue as Gold (2016) hai sottolineato attraverso un uso del colore che tu definisci “dialettico” le contraddizioni della rappresentazione dei migranti che cercano di arrivare in Europa attraversando il Mediterraneo. In quale modo ritieni che i tuoi progetti artistici sulla migrazione possano illuminare zone d’ombra, evocare ciò che è stato rimosso o dimenticato e diffondere una diversa sensibilità estetica e per questo politica?
ND: Utilizzo un linguaggio ibrido, che si appropria spesso di strumenti ispirati al giornalismo o alla sociologia. Di conseguenza i miei progetti possono sfociare in ricerche e trattare di tematiche trascurate; ma non saprei dire se ciò diffonda una diversa sensibilità estetica.
I miei progetti sono influenzati dalla mia storia personale, che mi porta quotidianamente a riflettere sulla mia identità e a contrastare pressioni esterne a volerla uniformarla etnicamente, culturalmente e linguisticamente. Attraverso di essi, spero di riuscire a far emergere un interesse per condividere quest’esperienza.
Nello specifico Hidden Islam nasce dal contesto nel quale mi trovavo nel 2009, ovvero il comune di Treviso alle prese con una politica discriminatoria nei confronti della comunità islamica. Mentre Blue as Gold è nato come possibile dialogo con un lavoro dell’artista e fotografo Richard Mosse intitolato Incoming, che narra dei movimenti migratori attorno al mediterraneo.

VGC: Giovanna, nella tua ricerca accademica hai analizzato come il cinema contemporaneo italiano abbia affrontato le sfide che l’immigrazione ha posto sulle strutture sociali, politiche e culturali italiane. In particolare, mi ha colpito il legame che hai elaborato tra la rappresentazione filmica del Mar Mediterraneo e il concetto di ospitalità di Jacques Derrida. Nei film che hai preso in esame, qual è il valore simbolico e ideologico dello “spazio” del Mediterraneo? Quali sono le scelte estetiche e retoriche attraverso le quali questi registi hanno “visualizzato” i limiti della politica dell’ospitalità e le possibilità dell’etica dell’ospitalità?
GFL: Il concetto di ospitalità, così come Derrida lo interpreta (in dialogo con Emmanuel Levinas e Martin Heidegger, tra gli altri), è profondamente radicato nella cultura mediterranea – Derrida stesso ne traccia le origini nel racconto biblico dell’incontro tra Abramo e i tre angeli. Virgilio ne dà un esempio pagano nell’Eneide, dove Didone offre ospitalità a Enea, promettendogli di non fare distinzioni di diritto tra cartaginesi e ospiti troiani. Da Massimo Cacciari a Pedrag Matvejevic, molti pensatori contemporanei invitano a rivalutare la “consuetudine con l’amicizia e l’ospitalità” che Francesca Saffioti identifica come valore mediterraneo.
Un film che mette esplicitamente in scena il legame tra spazio mediterraneo e ospitalità, e che ne visualizza i limiti è Io, l’altro di Mohsen Melliti (2006). L’azione del film si svolge interamente su una nave da pesca, che non a caso si chiama “Medea”, come l’eroina dell’omonima tragedia greca che si innamora dell’eroe Giasone e lo segue fino a Corinto. Medea, originaria della Colchide (regione che oggi corrisponde alla Georgia), è considerata dai corinzi una barbara, straniera per antonomasia; e nel momento in cui viene abbandonata da Giasone, si trasforma da hospes a hostis, da ospite a nemica. La vicenda di Io, l’altro segue una simile trasformazione, quando la voce del notiziario radiofonico che aggiorna il pubblico sulla caccia all’uomo seguita agli attentati di Madrid nel 2004 si infiltra nel rapporto tra il tunisino Yousef e l’italiano Giuseppe, e trasforma il primo da “fratello” a straniero da guardare con sospetto e paura. L’uso invasivo dell’editing e del montage mostra i personaggi in primo o primissimo piano da diverse angolazioni in inquadrature successive. Quest’attenzione per i volti è una strategia condivisa da altri film sulla migrazione, che così mettono lo spettatore davanti all’ineluttabile volto dell’“altro” – un volto che, come afferma Levinas, ci interpella e chiama a una responsabilità.
VGC: Alessandro, in uno dei tuoi saggi scrivi: “i migranti sono oggi come in passato dei frontier-maker, creatori di comunità diasporiche di frontiera, ma anche agenti di mediazione e stimolo per le comunità residenti […], innovando i nostri e i loro modi e stili di vita e offrendo occasioni di scambio e di rinnovamento per sé e per gli altri”.[v] Da circa dieci anni a Roma ti occupi insieme a un gruppo di volontari, ricercatori e artisti dell’Archivio delle Memorie Migranti. In quale modo la creazione di uno spazio dove narrare e archiviare le storie e la memoria dei migranti può restituire una nuova e autentica immagine di coloro che tu definisci “frontier-maker” e, allo stesso tempo, interrogare l’Italia sulla propria storia di emigrazione e il proprio passato coloniale?
AT: I migranti sono percepiti dai governi dei loro paesi, non meno che dalle società di accoglienza, essenzialmente come “saltatori di muri”, trasgressori o “bruciatori” di confini, frontier-breaker o harraga, un termine arabo che designa chi brucia i propri polpastrelli o documenti per cancellare la propria identità insieme a quella dello stato che rinnega. Molto meno si pensa ai migranti come frontier-maker, gente che migra per spostare in avanti il proprio orizzonte socio-culturale, che crea dal nulla comunità di riferimento e che diventa, nelle società di arrivo o di accoglienza, occasione di mediazione, stimolo e incroci multipli con i residenti. L’Archivio delle Memorie Migranti ha fin dall’inizio cercato di offrire uno spazio di ricomposizione tra il qui e il là del percorso migratorio sottolineando, nello spaesamento dell’esilio, l’importanza per ognuno di riprendere il proprio percorso personale, a cominciare dal racconto di sé, in prima persona e in mezzo agli altri. L’arrivo in un paese straniero getta le persone in una condizione di vulnerabilità ma è anche un tempo denso di vitalità, curiosità, voglia di sapere di sé e degli altri.
L’arrivo dei migranti in Italia, soprattutto quelli dal continente africano, ha innescato inconsapevolmente una nuova serie di domande finora evase o rimosse sul passato migratorio e coloniale del nostro paese. Il fatto che molti richiedenti asilo provenienti da Etiopia, Eritrea o Somalia, giungano in Italia dopo essere passati attraverso la Libia, un’altra ex-colonia che agisce allo stesso tempo come fornitore di migranti e controllore dei suoi flussi, ripropone domande inquietanti sull’ordine coloniale e la sua memoria nella Libia italiana, a lungo presidiata da gente che oggi imprigiona e reprime. È all’interno di queste contraddizioni, contaminazioni e contrasti che i frontier-maker migranti hanno aperto un nuovo negoziato di memoria con l’Italia di oggi – un paese che non dà la cittadinanza a 800.000 persone che sono italiane per lingua e cultura, ma non ancora per legge.