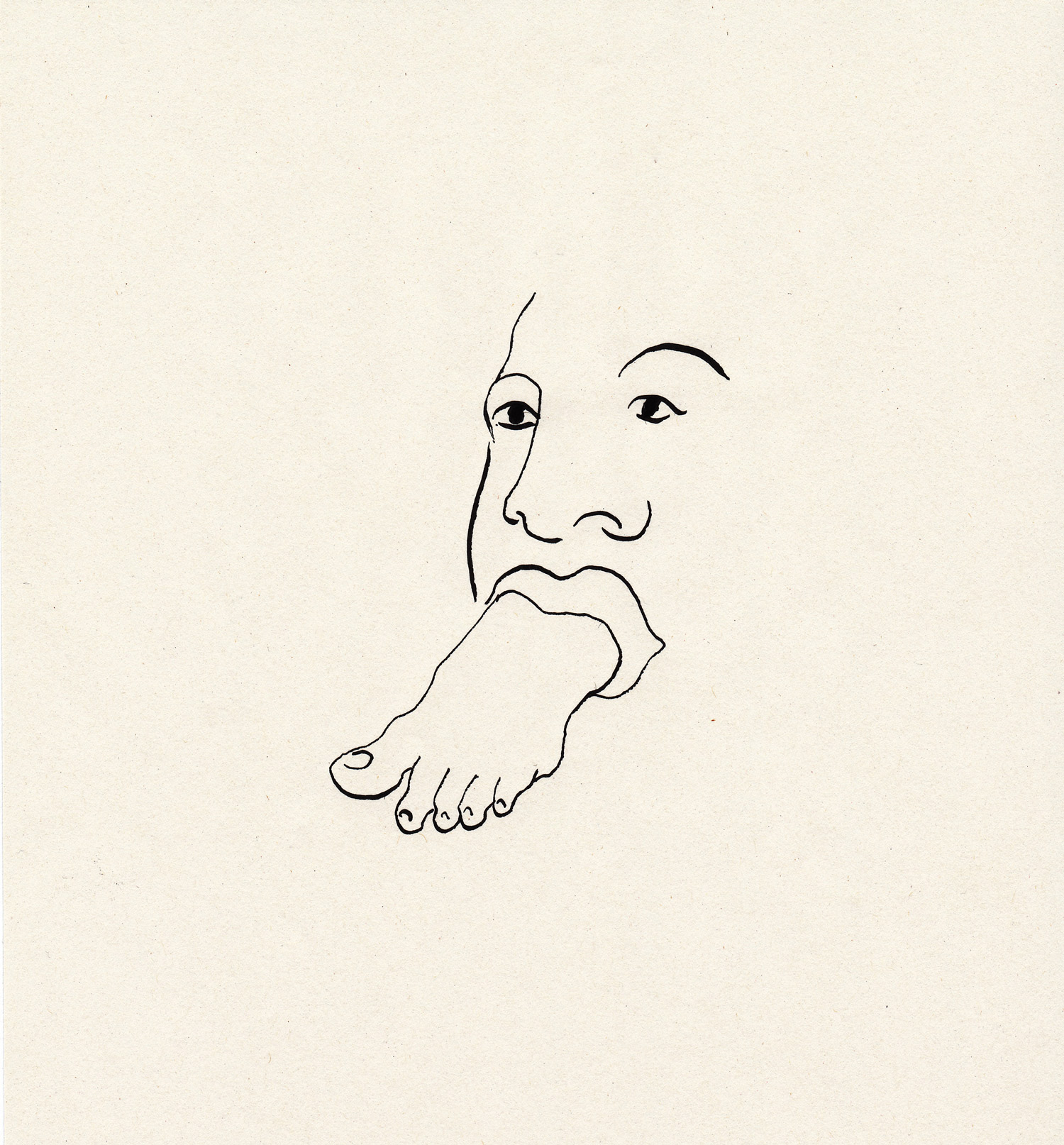Noah Stolz: Anni fa quando ti ho conosciuto la tua ricerca era essenzialmente incentrata sulla pittura. Più tardi, in un momento che tu stesso hai definito “di rottura”, hai cominciato a utilizzare altre tecniche e i tempi di lavorazione delle tue opere si sono notevolmente dilatati. Le tematiche del tuo lavoro si sono spostate su un piano molto più mistico, incentrandosi su riti arcaici. Parlando di ciò mi viene in mente il lavoro che avevi presentato a La rada, La danza del cervo (2005), una scultura di piccole dimensioni, un ramo ricoperto di fili di perle che nascondevano dei piccoli cervi, la cui lavorazione era avvenuta in un periodo di tempo molto lungo. Mi ricordo che al momento dell’esposizione non avevi ancora finito di lavorarci e che in realtà non era la prima volta che ti succedeva di dar vita a un’operazione simile; avevi avuto altri momenti di riflessione nei quali l’opera non nasceva più dalla necessità di rappresentarsi.
Luigi Presicce: La danza del cervo rimane il punto fermo di una sorta di rinascita e di abbandono completo della tecnica pittorica come pratica quotidiana. Credo che in un certo momento, una serie di concause mi abbiano portato a vedere l’invisibile anziché il visibile. Religiosamente ho iniziato a considerare l’opera come il risultato di una prova senza soffermarmi più sull’oggetto, ma sui gesti reiterati che la generavano. Sempre nello stesso periodo, per quasi un anno, ho continuato a uscire di casa convinto di essere un uccello, raccogliendo rami per potermi costruire una “casa” adatta alle mie dimensioni: Costruzione di un nido (2006). Anche in quel caso l’opera non era il nido, ma la raccolta. Il nido è stato poi donato ai bambini della scuola antroposofica di Milano che, giocandoci, hanno disperso di nuovo tutti i rami dai quali era composto. L’opera, nel suo compiersi, si carica non solo di significanti, ma anche di significati e diviene così mera presentazione dell’atto. Lo stesso principio è applicabile alle reliquie dei santi; queste non sono altro che resti umani che attraverso la fede diventano oggetti di culto e devozione. Seguendo questa sottile linea di confine tra sacro e profano e intuendo come quest’ultimo sia in realtà un concetto mutevole, che può essere facilmente nobilitato ed entrare così a far parte del sacro, ho individuato nell’atto e nel processo del “divenire delle cose” maggiore interesse che nell’oggetto in sé.
NS: Nel frattempo sono passati diversi anni, assieme a Luca Francesconi hai fondato una rivista on-line www.brownmagazine.it, e a questa si è aggiunto il progetto per uno spazio indipendente, Brown Project Space. Contemporaneamente la tua immagine pubblica è mutata notevolmente, per esempio da qualche tempo sei ritratto sulle riviste di moda e attualità, eppure questo non corrisponde apparentemente a una frenetica attività espositiva, sembra quasi che tu voglia creare un “te” di rappresentanza Browniana e un “te” artista. Il modo migliore infatti per conoscere il tuo lavoro è quello di visitare il tuo atelier, che tra l’altro è adiacente allo spazio espositivo di Brown. In relativa controtendenza con ciò che un curatore è abituato a vedere, il tuo atelier ha tutta l’aria di una camera delle meraviglie. Vi si trovano oggetti rituali e magici, animali impagliati con baffi e barbe, ex voto, marionette, costumi, immagini di maghi e documenti trovati accostati secondo un ordine che si fa fatica a decifrare, ma comunque “esposti” e passibili di modifiche repentine. A questi oggetti si vanno ad aggiungere diversi tuoi disegni e opere elaborate in collaborazione con altri artisti. Tutto ciò mi ha dato l’impressione che tu abbia lavorato sulla tua immagine esteriore per poi usarla come lo scudo di Perseo. In qualche modo ti è servito per proteggere il tuo lavoro e mettere ordine nelle tue intime priorità.
LP: L’opera muta, di conseguenza, o a prescindere da ciò, muto anche io. I salti quantici e le incoerenze rendono l’essere umano ciò che è, una “cosa” forse predisposta per incoerenza o completezza a credere in cose che non può vedere. Il mio “scudo specchiante” sarebbe potuto essere lì nonostante la comparsa di Brown. Forse però, Brown gli ha dato la possibilità di essere visto e di riflettere qualcosa o qualcuno… magari anche me, invece della Medusa. A proposito del riflesso, con la sua vuota pienezza, mi ricollegherei alla mia ricerca, che si basa su questa opposizione. Addentrarmi in questa città ha creato in me l’effetto caverna, quella del mito platonico; mi ha indotto per necessità a scavare dentro e, come un demiurgo, a creare un luogo nel luogo che, il più delle volte, ha al suo interno una differenza temporale notevole. Di conseguenza, l’opera, subendo la sua gestazione all’interno di questo meta-spazio, inevitabilmente ne riporta i segni. All’interno di questo luogo mutevole, la natura degli oggetti fa si che questi necessitino di una collocazione ben precisa e che di fatto, al di fuori di questo, perdano la loro sacralità. Ognuno di questi elementi rafforza l’altro creando un tessuto semantico, quindi, come dici tu, il modo migliore per accostarsi al mio lavoro è quello di entrare nella mia camera delle meraviglie, dove mi circondo di oggetti, li osservo e mi faccio osservare, cercando di diventare materia plasmabile, che assorbe informazioni e ne rielabora i codici. Da questa necessità di “capire” la santità degli oggetti e farne parte, nasce la mia percezione temporale dilatata delle cose, quasi a volerle dare il tempo necessario per diventare reliquie.

NS: Tornando al rapporto tra la tua opera e il progetto Brown, ho l’impressione, facendo scorrere gli articoli presenti su Brown Magazine, che si possa parlare di un rapporto di mitosi tra la tua pratica artistica e la linea editoriale della rivista. Cosa che in un certo senso è inevitabile. Mi viene in mente il caso di Jeff Wall che in un’intervista parla di un periodo di sette anni durante il quale ha smesso di operare come artista per cimentarsi nella teoria e nella critica d’arte. Questo periodo gli avrebbe permesso, dapprima, di smarcarsi dalla pesante eredità dell’arte concettuale, dall’altra di capire quali sarebbero state le basi per rifondare il concetto stesso di fotografia. Nel vostro caso si parte da un principio di riconquista dell’intero dispositivo che sottende alla presentazione dell’opera d’arte. Ho il sospetto però che dietro al progetto di Brown ci sia anche dell’altro; forse il desiderio di recuperare qualcosa dal passato, qualcosa che c’era e che oggi si stenta a trovare.
LP: Ciò che distingue Brown dalle altre riviste o spazi è proprio il suo carattere settoriale. Con Luca Francesconi e Valentina Suma abbiamo scelto di non occuparci di attualità dell’arte contemporanea in senso lato, ma di manifestare attraverso il progetto un’altra visione possibile. Crediamo di aver dato a questa città un’ulteriore possibilità che fino a qualche tempo fa era impensabile e, nonostante lo scetticismo iniziale, ora Brown è un punto di riferimento, non solo per chi lo visita, ma anche per noi che vi operiamo. Fondamentale nell’esperienza di Brown è stato il confronto diretto con altri artisti e l’occuparsi della curatela, intesa come ricollocazione teorico-semantica dell’opera all’interno di uno spazio di pensiero.
Credo invece che quello che ci leghi a un tempo anteriore è un filo che, passando per la spiritualità, tocca una serie di argomentazioni che negli ultimi decenni sono state considerate di second’ordine nel campo delle arti. Mi riferisco per esempio al popolare, al naif, alla metafisica, all’alchimia o l’esoterismo e alla magia. Ci sono poi anche altri elementi che, non solo in qualità di artisti, stiamo cercando di recuperare nell’opera, come la manualità e la legittimazione dei materiali intesi come linguaggio filosofico. Si tratta di aspetti che nel nostro operare, sia singolarmente che come Brown, diventano man mano più evidenti. Per me in particolare, credo sia stato fondamentale l’avere avuto un atteggiamento da antropologo prima e da archeologo poi, per amplificare il mio interesse verso le discipline magico-religiose che hanno influenzato la mia ultima ricerca, a prescindere da Brown. Sono convinto che ci sia una sottile linea che unisce il magico al religioso, il terreno all’ultraterreno, e si tratta in ogni caso di qualcosa di invisibile, di ermetico. Se penso al rapimento mistico e all’estasi, non posso fare a meno di considerare anche la cialtroneria da baraccone. Ciò che sta tra il vero e il falso è qualcosa di molto labile, almeno quanto quello che c’è tra il sacro e il profano. I voli estatici di San Giuseppe da Copertino non sono dissimili da quelli di tanti maghi illusionisti che hanno fatto lo stesso tipo di esperienza senza avere niente a che fare con la santità o il miracolo. Quello che però occorre prendere in considerazione in ogni caso è esclusivamente il volo, lo staccarsi da terra, l’invisibile-inspiegabile.

NS: A giugno hai dato luogo a una performance notturna in un bosco del Friuli, Il mago di Cefalù. Mi pare un ottimo esempio di come sta evolvendo il tuo lavoro. Dall’entropia della camera delle meraviglie passi al rituale vero e proprio in cui la messa in scena ha richiesto l’impiego codificato di una serie di oggetti rituali e di travestimenti.
LP: Il mio lavoro è una specie di cubo di Rubik che una volta rimescolato, a meno di aver elaborato qualche trucco diabolico o di avere una memoria visiva fuori dalla norma, non riesci più a ricomporre. Quando associo oggetti, fatti o immagini lo faccio seguendo una logica precisa che poi trasformo in un disordine apparentemente illogico e assurdo. Gli oggetti come i gesti e le sembianze agiscono dall’inconscio trasformandosi in linguaggio codificato dopo una serie di passaggi forzati. Ricreare il momento buio di uno dei personaggi più controversi del Novecento è stato solo un fotogramma di un’intera pellicola di riferimenti concatenati tra loro e, proprio per questo, non per forza associabili. Lo spirito del fiume — sei iniziati addestrati da un mago a suonare la tempesta con gli attrezzi dei liberi muratori — è l’anello di congiunzione tra uno dei rituali di passaggio più complessi e ancora esistente nelle popolazioni Bororo del Brasile e la pratica di magia nera — figurata attraverso forme geometriche simboliche, come lo svastica — utilizzata da quello che molti oggi definiscono il fondatore del satanismo moderno, Aleister Crowley. Fondere alchemicamente elementi attraverso forme simboliche risulta una pratica costante della mia ricerca. Creare il riflesso di un’entità che si coniuga continuamente, ma difficilmente si declina, muta, senza mai tornare indietro al punto di partenza, a quell’atomo che, come in una tavola periodica degli elementi, aspetta solo il momento della fusione. Camuffarsi sotto altre forme per riscrivere la trama, cercando di far diventare sacro e magico ciò che non lo è, e in contrapposizione profanare quello che sacro o magico lo è “a prescindere”.