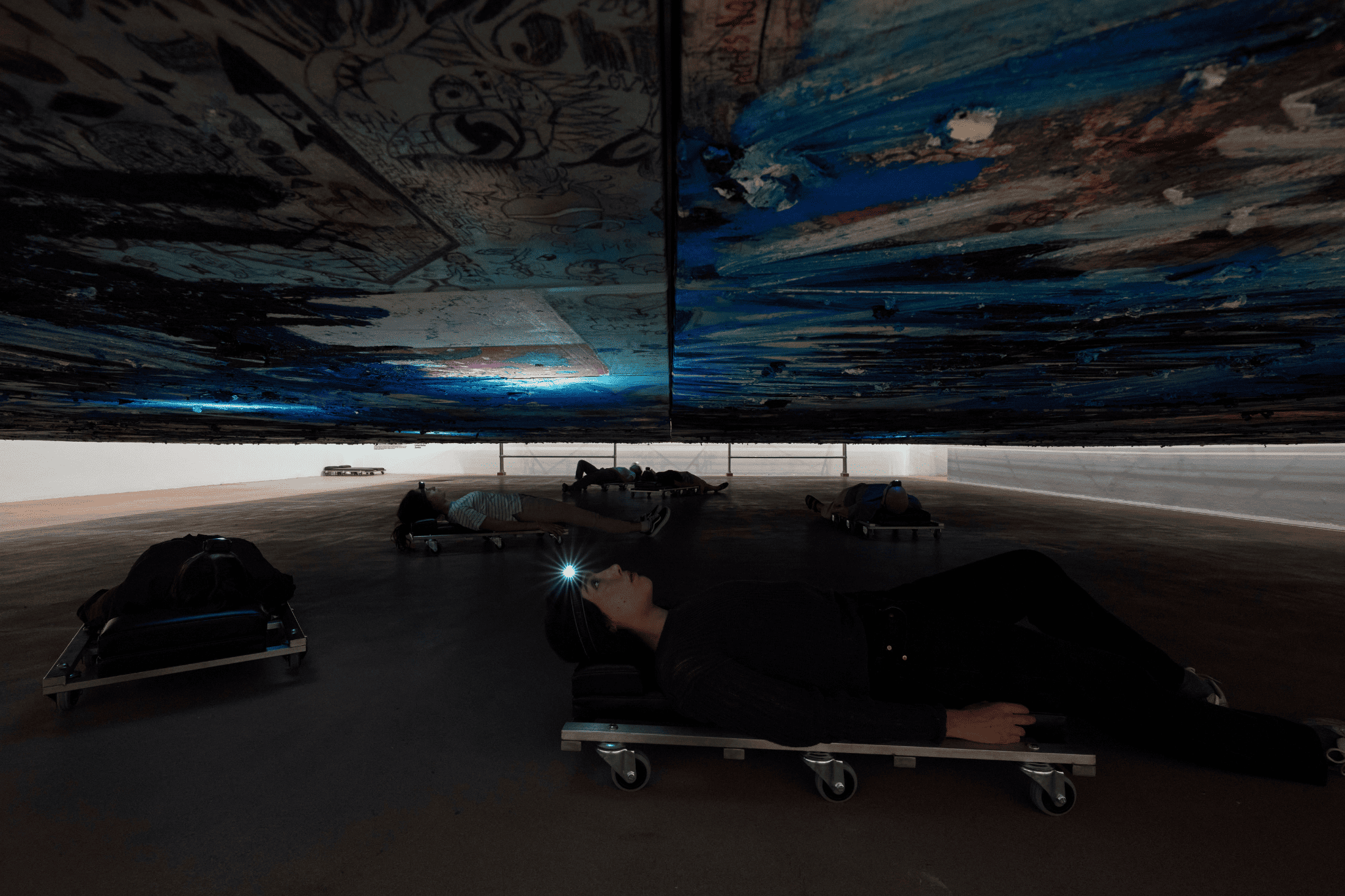Esiste un istante, nell’opera di Marcello Maloberti, in cui la martellata cessa di essere un colpo per trasformarsi in respiro: una pausa sospesa tra l’inizio e la fine delle cose, come se il gesto che frantuma coincidesse con quello che accarezza. Qui germina la sua poetica: non nella violenza del metallo che percuote, ma nella leggerezza inattesa che persiste dopo, simile a un’eco. Maloberti penetra nella tradizione lirica italiana attraverso una soglia laterale, quella dei margini, delle piazze di provincia, dei cortili dove il mondo appare circoscritto eppure contiene l’infinito.
Vi si riconosce la medesima traiettoria obliqua di Pasolini, non per imitazione ma per affinità elettiva: la capacità di scorgere l’assoluto nei frammenti, il sacro nelle fughe periferiche, la bellezza negli scarti. Maloberti procede come un poeta rionale che conosce la distanza tra una moto che sfreccia e un’invocazione, tra una maglietta stesa al vento e una dichiarazione metafisica. Le sue martellate non battono un testo: lo dischiudono. Non scolpiscono una parola: la scoprono là dove già dimorava, invisibile ai nostri occhi.
Eppure, dietro quell’apparente nonchalance – il sorriso che si insinua tra una frase e l’altra, la postura sempre decentrata – opera una consapevolezza profonda della storia lirica italiana. Come se le sue opere, asciutte e fulminee, costituissero costole segrete della nostra letteratura: un montaggio di luoghi e memorie che da Caproni giunge ad Amelia Rosselli, dalle prose disperate di Goliarda Sapienza alle invettive luminose di Pagliarani. In ciascuno di questi mondi, Maloberti individua una fenditura, un varco minimo attraverso cui far transitare la propria voce.
Giacché la sua è una poetica sognante ma non evanescente, timida eppure insolente. È la lirica delle periferie illuminate al neon, dei cortili estivi, degli autobus tramutati in teatri improvvisati; è la parola di chi ascolta il mondo con attenzione feroce, come se il rumore del quotidiano fosse materia preziosa da custodire. Ogni martellata persegue qualcosa di estremamente semplice e raro al contempo: un ritmo. Un battito. Una verità quasi infantile.
Quando Maloberti percuote la parola “poesia”, non la impone: la interroga. È come se chiedesse a ogni lettera se fosse ancora disposta a dire il vero, o almeno un suo frammento. La parola, colpita, vibra; e in quella vibrazione si avverte una tradizione che non opprime ma sostiene, una genealogia irriducibile che tiene insieme i poeti che hanno osservato l’Italia dalla linea d’ombra: Pasolini certamente, ma anche Pavese, Raboni, Tonino Guerra, i visionari dolci del nostro Novecento.
Maloberti opera in quel punto di cerniera tra delicatezza e urgenza, tra sogno e lama. Le sue martellate paiono cadere su ciò che non ha mai avuto voce, restituendo ai dettagli un suono, un colpo, una possibilità.
La sua è una poetica che non mendica attenzione: la magnetizza.
Che non ambisce a farsi monumento: predilige essere scintilla.
Che non insegue la grande Storia: privilegia le piccole esistenze che la faranno sopravvivere.
In fondo, ciò che rende Maloberti un caso unico è questa capacità al contempo infantile e sapiente: metamorfosare un gesto rude in gesto tenero, far vibrare la materia come fosse linguaggio, e persuaderci – anche solo per un istante – che una martellata può essere una carezza che dischiude il mondo.