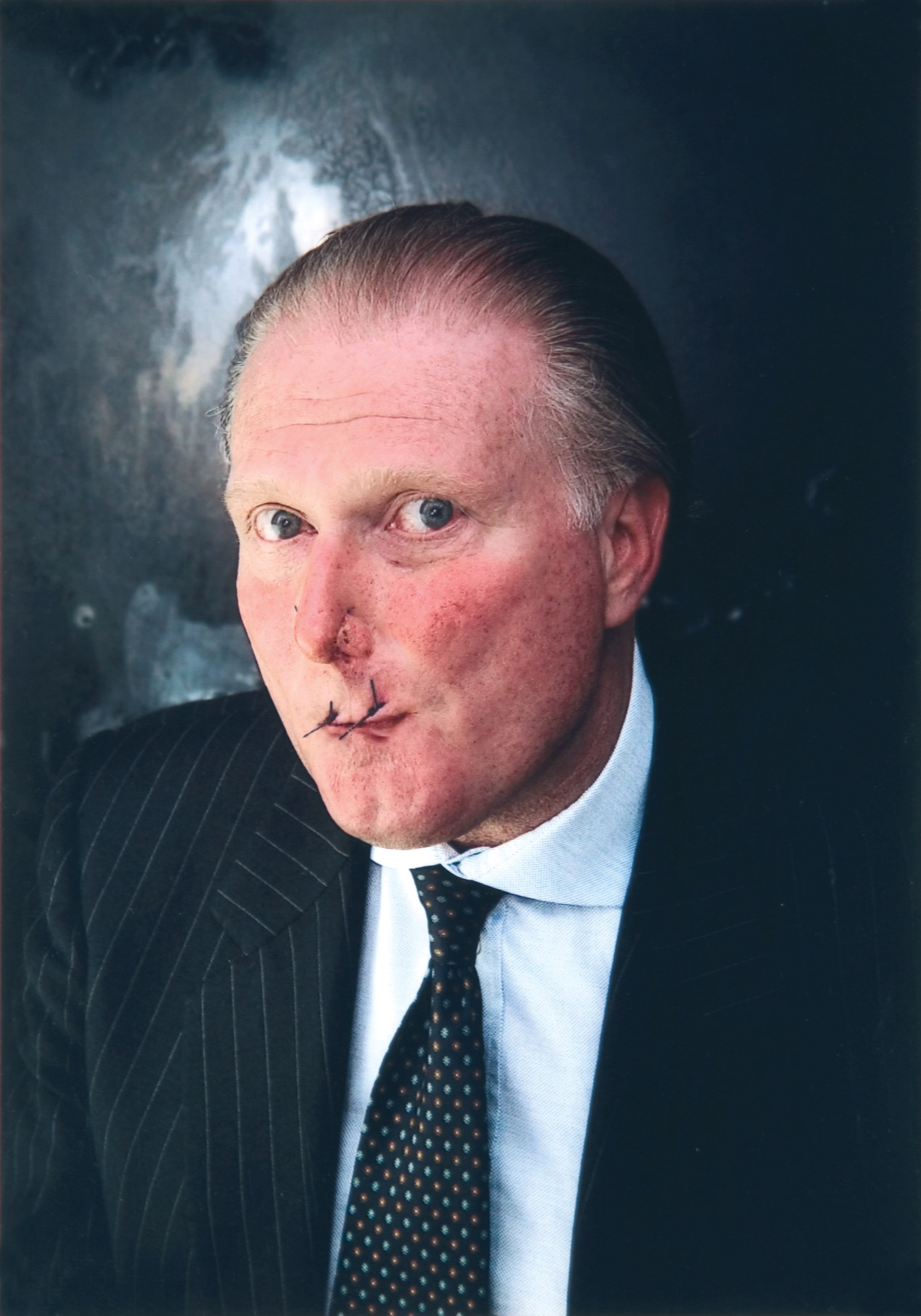Cosa significa essere una outsider, una donna e una straniera? In che modo il tema della nazionalità si riflette sulla produzione artistica? Ho invitato tre artiste “cult” a riflettere su questi temi. In un primo momento avevamo programmato di vederci a New York ma, dato che Vanessa si è appena trasferita a Los Angeles, abbiamo registrato la nostra conversazione su Skype da New York, Los Angeles e Milano. Ho chiesto a Marina di fare da moderatrice.
Marina Abramovic: Vorrei iniziare con il tema della nazionalità e parlare con voi di come questa si rifletta sulla nostra produzione artistica.Quando ho lasciato la Jugoslavia sono andata a vivere in Olanda; da lì ho viaggiato molto, mi sentivo come una nomade moderna. Nel mio lavoro, mi capita spesso di guardare indietro. All’inizio, ciò non aveva a che fare con le mie origini. Non sono mai stata un’artista jugoslava. Quando vivevo in Olanda, avevo un passaporto olandese ma non mi sentivo un’artista olandese, quando vivevo in Germania non ero un’artista tedesca, e qui a New York non mi sento un’artista americana. Non provo un senso di appartenenza per nessuno di questi Paesi. Mi piace pensare a una sorta di villaggio globale. Volevo sapere cosa ne pensava Shirin…
Shirin Neshat: La questione della nazionalità è sempre stata un argomento problematico per me; questo spiega perché l’identità è ancora un tema centrale nel mio lavoro. Forse non sarei nemmeno diventata un’artista se non avessi attraversato questa crisi emotiva. Come Marina, anch’io mi considero una nomade moderna, ma devo confessare che sono continuamente ossessionata dal desiderio di tornare a casa, o di ristabilire un rapporto con il mio Paese. Il pensiero di vivere come una nomade dell’Est in Occidente non mi affascina per niente. Ma se un giorno mi riconciliassi con il mio Paese e questo mio desiderio fosse finalmente appagato, potrei anche smettere di essere un’artista. In definitiva, credo che la mia situazione sia un po’ diversa da quella di Marina.
MA: è diversa perché io posso tornare quando voglio. Tu potresti tornare nel tuo Paese, se volessi?
SN: Quello che hai detto entra giusto nel vivo della questione. Inconsciamente, tu hai la sicurezza di poter sempre tornare nella tua terra. La Serbia e gli Stati Uniti sono due Paesi molto diversi, ma pensa all’Iran e agli Stati Uniti. Non sono solo culturalmente lontani, vivono anche un conflitto politico. Naturalmente, una tensione di questo tipo rappresenta un ulteriore peso per quegli iraniani che, non solo subiscono un trattamento ostile da parte del proprio governo, ma sono i bersagli di una discriminazione razziale internazionale.
MA: Questo è vero. Volevo sapere cosa ne pensava Vanessa, visto che vieni dall’Italia, dove è tutta un’altra storia…
Vanessa Beecroft: Vengo dall’Italia ma ho sempre avuto documenti inglesi. Ho sempre sofferto fin da piccola degli spostamenti. Sono cresciuta in Italia con un nome inglese e con una madre italiana. Non mi sentivo parte di quel luogo, ero nel posto sbagliato. Quando sono arrivata negli Stati Uniti mi sono integrata immediatamente perché ero un’emigrante come tutti gli altri, pur provando un risentimento verso la politica, l’imperialismo e la cultura di massa che invece proveniva dalla mia educazione. Continuavo a sentire di non appartenere al posto in cui mi trovavo. Quando sono andata in Sudan, un anno fa, ho sentito che quella sarebbe potuta essere la mia terra. Ho finito per identificarmi con quelle persone che vivono in una condizione di instabilità. Non mi sono mai sentita parte di un gruppo artistico, così, in un certo senso, mi sento isolata da qualsiasi sistema. Ecco tutto!
Helena Kontova: Il tema principale della Biennale di Praga di quest’anno è dedicato agli “outsider”, un tema molto dibattuto in un Paese che, come la sua comunità artistica, è ancora decentralizzato e isolato. Il ruolo dell’outsider nell’arte contemporanea rappresenta una figura fondamentale; ma essere un outsider produce ancora gli stimoli giusti? è ancora una condizione necessaria per un artista?
Per Shirin è stato un importante punto di partenza. Ma penso che lo stesso valga sia per Marina che per Vanessa, anche se in modo diverso.
MA: Per me è stato molto importante iniziare la mia carriera in Jugoslavia. Lavorare con la performance e l’installazione a Belgrado in quel periodo, quando queste pratiche non esistevano neppure lì, era come essere la prima donna sulla Luna, per cui c’era anche una specie di purezza e di innocenza nell’approccio a questi temi. Successivamente, quando mi sono spostata in Occidente, la cosa più difficile è stata sviluppare un linguaggio completamente nuovo, dato che il mio lavoro si concentrava soprattutto su tematiche legate alla mia terra d’origine: il sistema jugoslavo, la borghesia jugoslava, la borghesia rossa jugoslava, il comunismo jugoslavo, la famiglia e la società jugoslave. A quel punto dovevo utilizzare modelli universali. Ma la cosa strana era che più stavo via da Belgrado più riuscivo a vedere la situazione in modo diverso. Così, ora sto lavorando a molti argomenti che riguardano la Jugoslavia, più di quando abitavo lì. è un’idea di lontananza e vicinanza — e ancora distanza — che sembra funzionare molto bene.
Che ne pensi, Shirin?
SN: Tutto quello che ho fatto in vita mia si ricollega all’idea di outsider. Mi considero un’esclusa, sia tra la gente del mio Paese che tra gli occidentali. Quando penso al mio lavoro, col senno di poi trovo ironico che i miei personaggi femminili, per questioni sessuali, culturali o politiche, siano anch’esse delle escluse dalla società. Esiste una tensione costante tra l’individuo e la comunità, e spesso un’impossibilità di integrazione tra questi due elementi. Nel mio ultimo progetto, il film Women without Men, ispirato al romanzo omonimo della scrittrice iraniana Shahrnush Parsipur, la storia si basa interamente sulla vita di quattro donne emarginate dalla società. Ognuna di loro fugge dalla sua condizione, finché non giungono tutte in una casa di campagna dove daranno vita alla loro comunità utopica, indipendente dal mondo e dalle sue leggi. La scelta di questo tema non è altro che una metafora delle battaglie che sto combattendo: il tema dell’esilio, il bisogno di un rifugio, di un posto che puoi chiamare “casa”, e così via.
HK: Vanessa, tu hai parlato della difficile posizione che hai vissuto sentendoti diversa e isolata…
VB: Il mio problema non è l’appartenere o meno a un determinato luogo; non essere legata a un Paese ti consente di muoverti in modo più flessibile. Mi identifico con qualsiasi cosa voglia identificarmi. Paragonando la mia condizione a quella di Marina e di Shirin, mi identifico con la loro formazione, che per Marina è rappresentata dal periodo in cui ha iniziato a lavorare e dal suo contesto sociale, mentre per Shirin mi riferisco alla situazione del suo Paese.
Ho iniziato a lavorare in un periodo che non ha registrato sviluppi per quanto riguarda la cultura, che ha prodotto un’identità di cui non vado fiera. Per esempio, vorrei ringraziare Marina per le sue performance; le utilizzo come metodologia di lavoro, come una tecnica già sperimentata da lei e da altri come lei. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, non ho mai vissuto né un periodo politico come gli anni Settanta né una crisi politica come quella descritta da Shirin.
MA: Quello che dici è interessante. Proprio negli anni Settanta, quando arrivai in Italia per la prima volta, erano poche le artiste italiane attive. C’era Marisa Merz, ma era messa in ombra da Mario e difficilmente aveva delle mostre in corso. Il tuo lavoro, Vanessa, ha aperto una nuova strada. Trovo molto interessante che tu abbia ricevuto un consenso internazionale. Quale pensi sia il motivo? Perché hai lasciato l’Italia così presto? Se fossi rimasta in Italia, sarebbe stato difficile fare il tuo lavoro?
VB: Sono stata fortunata ad aver ricevuto un supporto da subito, per esempio da Giacinto Di Pietrantonio e da Flash Art, ma allo stesso tempo sentivo che il mio lavoro era reso volgare, subiva connotazioni sessuali, e volevo fuggire da una lettura di questo tipo. Per di più, non mi sentivo legata a movimenti del passato come l’ Arte Povera, con cui non avevo niente a che fare.
HK: Trovo che invece ci siano molte tracce dell’iconografia italiana nel tuo lavoro. Utilizzi molte immagini che fanno riferimento anche alla Storia…
VB: è vero, come per esempio Pasolini, e tutti i registi e gli intellettuali degli anni Sessanta. Ma non conosco l’attuale situazione artistica e non ho mai voluto farne parte. Sono legata alla lingua, all’iconografia e alle figure di alcuni politici e intellettuali del passato, ma non sento il bisogno di vivere in Italia.

MA: Shirin, cosa succederebbe se tu facessi una grande retrospettiva in Iran? Sarà possibile? Se sì, vorrei essere presente quel giorno. Mi sono fatta la stessa domanda e avrei paura.
SN: Sfortunatamente, dato il clima politico attuale, sarà impossibile che un evento del genere possa svolgersi nel futuro più immediato. Senza dubbio, il mio lavoro subirebbe letture diverse nel mio Paese. Da una parte, avrei l’impressione di essere capita, perché utilizzo un registro poetico radicato nella cultura iraniana; non si presenterebbe il problema che ho invece ogni volta che mi confronto con gli spettatori occidentali. Dall’altra, il mio lavoro potrebbe essere terribilmente frainteso, perché è concettuale, ed è influenzato dalla Storia dell’Arte occidentale. Rischierebbe di essere criticato per queste ragioni.
MA: Helena, tu vieni da Praga, dove sei stata testimone del ’68; qui sei entrata nel mondo dell’arte senza essere accettata, poi ti sei trasferita e adesso sei Editor di Flash Art e oggi ci hai invitate alla Biennale di Praga, di cui sei l’ideatrice. Vorrei solo sapere come ti senti a essere nomade, ad aver lasciato il tuo Paese per poi ritornarci con nuove idee…
HK: Sto vivendo questi spostamenti senza grandi drammi. Era drammatico trent’anni fa. Comunque, mi sento ancora una straniera, un’outsider ovunque io vada. Mi sento molto diversa dalle persone attorno a me, e la stessa cosa mi succede anche a Praga. Le persone lì, poi, mi considerano in modo diverso da come farebbero se invece avessi vissuto lì per tutto questo tempo. Penso che in qualche modo siano contenti della Biennale, ma per alcuni versi sono ancora molto chiusi.
Ma adesso vorrei chiedervi, qual è la vostra più grande aspirazione al momento (in termini artistici)?
MA: Il mio desiderio più grande, dato che ho quasi 60 anni, è di avere il tempo per seguire solo i progetti che voglio. Sto lavorando a delle performance che hanno una durata più lunga del solito. Così, finirà che troverò per le mie opere il tempo che non ho nella vita.
HK: Shirin, qual è il tuo più grande desiderio al momento?
SN: Vivrò in Marocco per i prossimi mesi, non vedo l’ora di passare finalmente un po’ di tempo in un Paese islamico. Girerò il mio film a Casablanca, una città molto interessante, che sta iniziando a piacermi. Grazie alla loro somiglianza nell’architettura e nell’aspetto più in generale, faremo credere che Casablanca sia la Tehran degli anni Cinquanta.
Questo film è la mia sfida più importante. Mi ci sono voluti quattro anni per prepararlo, ma ancora oggi continuo a trarre ispirazione da Women without Men, e mi sento profondamente motivata a raffigurare l’atmosfera politica dell’Iran negli anni Cinquanta.
La storia si svolge nell’agosto del 1953, durante il colpo di Stato organizzato dalla CIA contro il nostro governo, che spodestò il nostro Primo Ministro eletto democraticamente — il Dr. Mossadegh — e riportando al potere Shah, considerato da molti un dittatore. Questo evento ha cambiato la storia della politica iraniana, spiega la rivoluzione islamica del 1979, e, soprattutto, il sentimento anti-americano diffuso tra gli iraniani e i mediorientali. In un momento in cui un attacco militare dell’esercito degli USA contro l’Iran non sembra un’ipotesi così remota, trovo che parlare con franchezza di questi eventi storici abbia un’importanza critica. Ovviamente sono un’artista e tratterò questo argomento da artista.
Ma il mio sogno è che la storia di questo film si realizzi.
HK: Vanessa, tu invece sei appena tornata dalla Corea, mentre prima hai prodotto un intero progetto sul Sudan…
VB: La mia aspirazione in questo momento è quella di non sentire nessuna pressione nel mio lavoro. Sto cercando di concentrarmi ancora sul Sudan. Vorrei realizzare delle fiction documentative su questo Paese, o anche solo utilizzarlo come metafora per quello che sta succedendo in molti altri luoghi. Non sono sicura di riuscirci, ma voglio provarci anche a costo di allontanarmi dall’arte.
SN: Ho apprezzato molto, Vanessa, quello che hai detto riguardo al Sudan, e che questo progetto ti interessi al punto di lasciare da parte il tuo lavoro. Penso anch’io che si corra un grosso rischio. Mi considero, come forse anche tu, a metà della mia carriera artistica; c’è un punto in cui interroghi te stessa e il tuo lavoro e penso che valga la pena rischiare. Sono sicura che sarà di grande ispirazione per te.
MA: Non credo che l’idea di abbandonarsi alle situazioni sia così importante, molti artisti giovani non lo fanno, perché sono dipendenti dalla città e dal mercato. Per me è stato così importante vivere per un anno con gli aborigeni nel Deserto Centrale, con i Tibetani, perché ci sono situazioni che effettivamente ti cambiano in maniera profonda. Dobbiamo sempre stupirci, dobbiamo sempre avere il coraggio di rischiare, altrimenti finisci con il ripetere sempre le stesse cose. Credo che siamo tutte d’accordo su questo.
HK: Marina, il tuo recente lavoro Balkan Epic è stato realizzato nel tuo Paese d’origine. Pensi che questo abbia contribuito a darti una forza particolare, a creare questo immaginario così potente e convincente?
MA: Non sarei mai stata in grado di fare questo lavoro se fossi rimasta lì. Ricordo dei miei amici che mi chiedevano “dove hai preso tutto questo materiale erotico? Vivevamo lì e non l’abbiamo mai visto!”. Bisogna essere lontani dalle proprie origini per avere un’immagine più nitida. Se sei troppo vicino non ricevi gli stessi stimoli. Adesso che sono lontana — in più, sono passati 35 anni da quando sono partita — posso guardare il passato tradotto e trasformato e capire quello che sta succedendo. Vorrei fare questa domanda a Vanessa: dei tuoi lavori, quello che preferisco è “U.S. Navy” [VB39, 1999]. è incredibile il modo in cui hai utilizzato i marines, e sono veramente dispiaciuta che non hai continuato a lavorare in quella direzione.
VB: Volevo completare “U.S. Navy” con i veterani di guerra, ma non sono riuscita a realizzare questo progetto, che doveva essere esattamente come un disegno. Una formazione militare ufficiale di reduci del Vietnam, amputati e questa volta non allineati, che mostravano quello che gli era successo dopo la guerra, una continuazione di ciò che avevo mostrato all’inizio, con lo stesso ordine preciso, come un disegno geometrico con parti mancanti. Volevo modificare le uniformi perché si adattassero ai corpi monchi.
“U.S. Navy” non parlava delle differenze tra i sessi, il fatto che nella fotografia apparissero solo uomini è stato solo un caso. Era un progetto sul potere e sulle regole.
HK: Vorrei sapere come Shirin si ricollega alle donne erotizzate di Vanessa e di Marina, perché le sue figure femminili sono molto diverse, più psicologiche, più fragili. Sarei curiosa di conoscere la sua posizione a riguardo.
SN: Si tratta di lavori molto diversi tra loro. Nel lavoro di Vanessa, c’è più interesse verso il gruppo di protagoniste piuttosto che per la singola donna; i personaggi perdono la loro identità individuale e l’attenzione si sposta sulla relazione che hanno le une con le altre, o con la società. Nel lavoro di Marina, invece, il personaggio singolo è completamente assorbito dalla sua vita interiore. Per quanto riguarda i soggetti maschili, nel mio lavoro, in quanto artista donna e iraniana, ho sempre dovuto fare molta attenzione a come rappresentare l’uomo. Non ho nessun interesse a rappresentare gli uomini musulmani.
HK: Vorrei sapere cosa pensa Vanessa riguardo alla rappresentazione della femminilità e alla mascolinità nel lavoro di Shirin perché ci sono differenze con il suo lavoro ma ci sono anche dei punti comuni, come la separazione tra uomo e donna.
VB: Quando vedo un lavoro di Shirin, sento che possiede un peso diverso dal mio. Non sono abbastanza competente per esprimere alcun giudizio a riguardo, non lo so. Nel mio caso le donne rappresentano dei temi che preferisco estendere a un grande gruppo, utilizzando un gruppo più universale. Volevo ricreare un’immagine che, malgrado le sue apparenze, non fosse necessariamente piacevole, che creasse una sorta di senso di colpa, di imbarazzo. Volevo che il pubblico reagisse a livello psicologico. Non ottieni mai un disegno completo finché il pubblico non ne entra a fare parte.
MA: Quello che trovo interessante nel lavoro di Shirin è che possiede diversi livelli di interpretazione, oltre a produrre una risposta emotiva. In uno dei primi lavori che ho visto, l’impatto emotivo era così forte che tutti ne parlavano, perché il tipo di immaginario primordiale e il registro utilizzati non sono solo iraniani, ma appartengono a qualsiasi luogo ed epoca. Potresti ambientare il suo lavoro in qualsiasi altro luogo, dalla Sicilia al Montenegro, ai Paesi Baschi, dappertutto. Quindi l’aspetto più interessante per me è il potere trascendente dell’opera: non sono mai stata in Iran, ma riesco a proiettare alcuni riferimenti alla mia cultura su un’altra cultura.
SN: Penso che una cosa che i nostri lavori hanno in comune sia la tendenza a provocare il pubblico.
Le performance e le foto di Vanessa, il lavoro di Marina emozionano il pubblico. Anche se non amo creare delle separazioni, penso che spesso le artiste abbiano il potere di provocare una reazione emotiva sul pubblico. Altre artiste che apprezzo, come Louise Bourgeois ad esempio, hanno questo effetto su di me.
HK: Nei tuoi lavori, gli uomini e le donne subiscono una divisione, come per Vanessa.
Marina invece ha lavorato per molti anni insieme a Ulay. A un certo punto la collaborazione è finita e vi siete separati, nella vita e anche in arte. Puoi dirci qualcosa riguardo a questa esperienza?

MA: L’unica coppia capace di lavorare a lungo insieme è Gilbert e Gorge. La collaborazione all’interno di una coppia può funzionare, ma solo per un breve periodo; prima o poi fallisce. Il problema delle collaborazioni è che devi fondere il tuo ego con quello di un’altra persona e trasformarlo in quello che Ulay e io chiamavamo “that self”: due corpi che diventano un corpo solo.
Basta che uno dei due dica “questo è il mio lavoro” che l’intera collaborazione si sfascia. Ero molto entusiasta all’inizio perché pensavo che se avessi dato il meglio di me, e se anche l’altra persona avesse fatto lo stesso, avrei potuto fare di più di quanto avrei potuto da sola. Dopo 12 anni, la nostra collaborazione era finita, ma per tre anni ho cercato di nascondere il fatto che non riuscivamo più nemmeno a parlarci.
Quello è stato uno dei momenti più difficili della mia vita perché ho dovuto davvero ammettere di avere fallito.
HK: Shirin, hai incontrato tuo marito durante la produzione di uno dei tuoi lavori…
SN: Sì. In generale penso che tutto quello che ho fatto è stato sempre, in un modo o nell’altro, il frutto di una collaborazione con qualcuno o con un gruppo di persone. Sono d’accordo con Marina quando ammette che non è un processo facile, ma ho imparato che tutto si riduce a una negoziazione noiosa. Immagino la collaborazione come una danza. Se hai un partner, devi imparare a rispettarlo e a scoprire le sue forze e le sue debolezze. A volte sei tu a dirigere, altre è lui o lei a farlo. Trovo che le collaborazioni rendano gli artisti umili, dato che tutti possiamo soffrire per il nostro ego. Ma la sfida più grande in una collaborazione è ovviamente non scendere a compromessi nell’essenza della tua arte e comunicare idee mediocri.
HK: Vanessa, cosa ne pensi? Perché sicuramente hai un punto di vista diverso…
VB: Identifico inconsciamente il maschio con la società, la rigidità, le regole, il sistema o i militari. In Corea mi hanno detto che ho un’idea sciovinista del maschio, che nel mio lavoro l’uomo è il cattivo.
Nelle mie opere gli uomini sono il pubblico, l’abusatore, il violatore. Ho inevitabilmente messo da parte l’uomo per puntare la mia attenzione sulle donne, che guardano l’uomo.
HK: è più facile collaborare con uomini neri piuttosto che con uomini bianchi?
VB: Sì, perché appartengono a una classe non dominante, in cui mi identifico. Sono cresciuta in una famiglia matriarcale, senza uomini. Vorrei poter andare oltre questo limite, ma essere donna è il mio vantaggio ed il mio svantaggio.
HK: è un vantaggio e uno svantaggio al tempo stesso?
MA: Penso che il sesso non sia rilevante. è quello che produci che conta. Non importa se è stato fatto da un uomo o da una donna; sono convinta che l’arte non ha sesso.
Cosa ne pensi tu, Shirin?
SN: Sono del tutto d’accordo con Marina.
Nonostante ci si possa aspettare che l’arte prodotta da artiste donne sia influenzata dalla loro femminilità, non ci si dovrebbe limitare a un discorso di sessi. Ci stiamo occupando di argomenti che non riguardano solo soggetti femminili, ma spesso raccontiamo le nostre storie attraverso personaggi femminili.