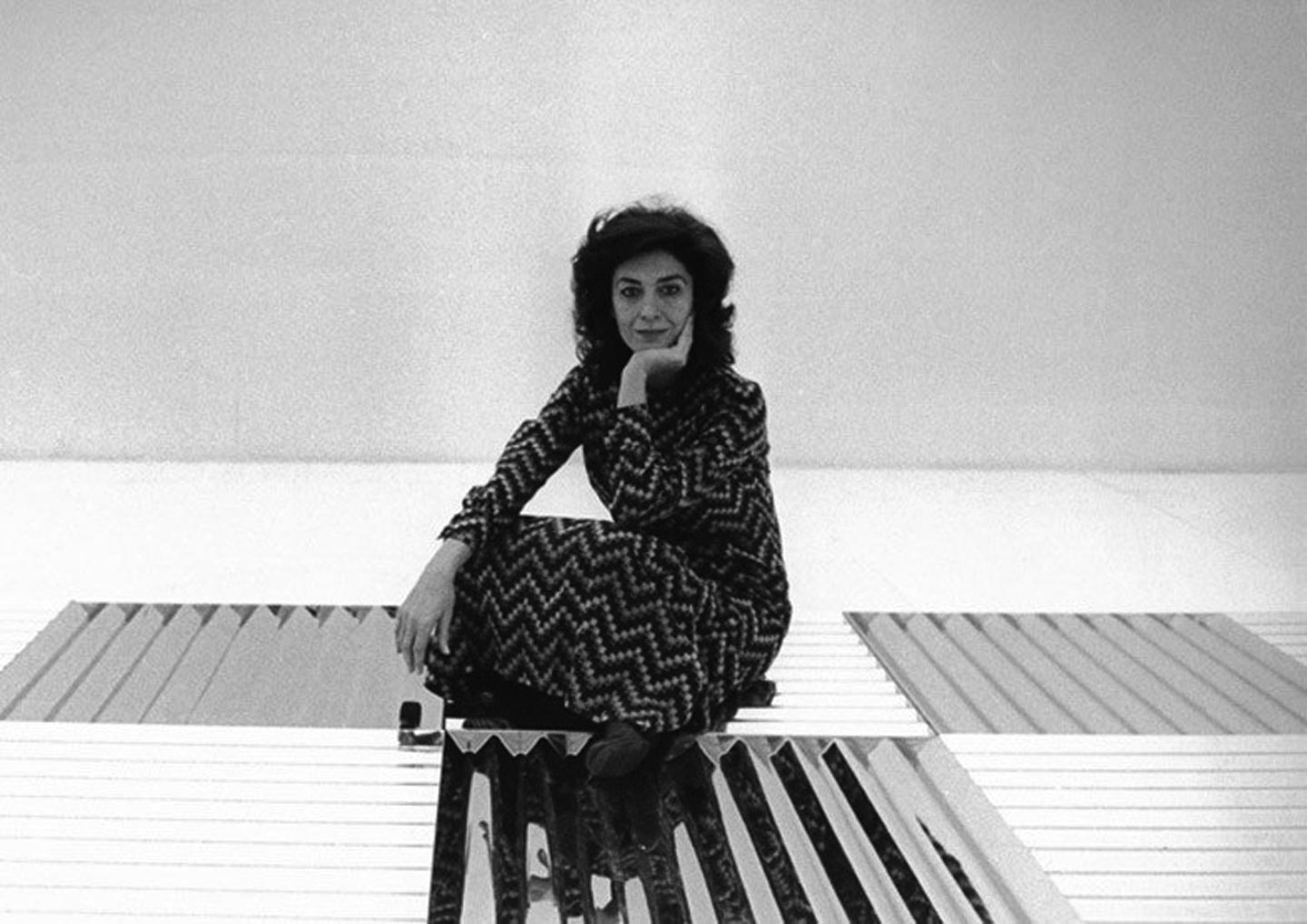Luca Panaro: Vorrei iniziare questa chiacchierata ricordando un tuo environment del 1969 realizzato alla galleria Il Diaframma di Milano, dove consentivi al pubblico di interagire con una moltitudine d’immagini fotografiche racchiuse all’interno di cilindri trasparenti. Già in quegli anni la tua posizione era eccentrica rispetto a quella di altri autori italiani che si esprimevano con la fotografia. In cosa ti distinguevi?
Mario Cresci: Nel 1968 ero a Roma, dove seguivo le mostre delle gallerie L’Attico di Fabio Sargentini e L’Arco d’Alibert di Mara Coccia. Riprendevo a modo mio con la fotografia i progetti e gli allestimenti di alcuni artisti come Pino Pascali, Eliseo Mattiacci, Jannis Kounellis, Gino De Dominicis e ricordo una mostra di particolare rilevanza: “Il percorso” del gruppo originario degli artisti dell’Arte Povera torinese che fotografai nella fase del suo allestimento il giorno prima dell’inaugurazione. In particolare ricordo quando Alighiero Boetti mi chiese di prendere il suo posto nella costruzione dei suoi “Totem” di carta, per un attimo io diventai l’artista e lui il fotografo, il fotografato diventava il fotografante e viceversa, un po’, se vuoi, come Alighiero e Boetti che si tengono per mano, in un apparente sdoppiamento visivo ma soprattutto di senso. Fu l’unico artista del gruppo che mi dedicò questa particolare attenzione e, anche per questa ragione, iniziai a pensare alla figura dell’artista in una società, quella di allora, che sembrava lasciare all’arte contemporanea poche speranze di sopravvivenza. Decisi allora di dedicarmi con più intensità all’idea di un “fotografico” che non fosse solo di natura retinica, ma anche sensoriale dove l’immagine è un fenomeno inscindibile dalla corporeità e soprattutto dalle sue basi senso-motorie proprio come nella tradizione fenomenologica che avevo studiato negli anni veneziani. In questo senso, la figura e il ruolo del fotografo e della fotografia non potevano prescindere da ciò che l’arte e gli artisti proponevano e rappresentavano soprattutto dopo la Biennale del 1964 e poi con l’avvento dell’Arte Povera e del concettualismo degli anni Settanta in Italia. Uscire, per esempio, dalla realtà bidimensionale dell’immagine era come affermare un visivo fotografico ancora tutto da scoprire e nel mio caso poteva diventare un momento di apertura e di provocazione all’interno di uno spazio espositivo dedicato proprio alla fotografia come la galleria Il Diaframma di Milano. Nacque così forse il primo environment nella storia della fotografia contemporanea e certamente uno dei tanti in quella dell’arte. Avevo comunque aperto uno spazio anche teorico tra le due parti e ciò naturalmente suscitò accese critiche tra i fotografi e un bonario e indifferente giudizio positivo tra gli artisti. I mille cilindri trasparenti sigillati contenevano altrettante immagini fotografiche anch’esse su pellicola trasparente raffiguranti frammenti di oggetti, cose e persone di un mondo di lusso che non apparteneva alla coscienza, alle idee della mia realtà economica e sociale e nemmeno a quella di molti dei miei compagni di viaggio di quel periodo. Avevo in mente la Merda d’artista di Piero Manzoni del 1961 e pensai che potevo ribaltare il senso della sua opera dal contenuto opaco e invisibile a oggetto trasparente e consumabile solo con la vista. Fu una provocazione che non lasciò alcun segno di riflessione tra gli addetti ai lavori e solo uno di loro, Luciano Inga Pin, si entusiasmò della mostra salvandomi dalla delusione. Pochi anni dopo mi invitò in una rassegna di artisti contemporanei: “Campo Dieci” nella sua Galleria Diagramma situata a pochi isolati di distanza dal Diaframma.

LP: Credo che il filo conduttore della tua produzione, passata e presente, sia l’interazione con la città e il suo territorio. Utilizzi il mezzo fotografico per fare continui riferimenti agli elementi culturali che hanno costruito l’aspetto identitario di molti luoghi. Fra i tanti un ruolo importante lo ricopre la città di Matera. Perché?
MC: Appartengo a una generazione che ha avuto la fortuna di vivere alcune stagioni del secolo scorso con la passione e il desiderio di conoscere e di relazionarsi con il mondo esterno, il tutto mediato da frequentazioni con artisti e persone non tutte assorbite dal pensiero dell’arte, ma anche da altri saperi che si incrociavano tra loro in un fantastico immaginario fatto di emozioni e di regole, di passaggi di senso, comparazioni, analogie, condivisioni, parallelismi di metodo, verifiche dei linguaggi espressivi e linguaggi tecnologici, aree di lavoro affini a tematiche comuni, ma quasi sempre utili per capire e conoscere meglio se stessi e gli altri. Gli studi sul design e le esperienze artistiche e professionali che avevo maturato a Venezia, Milano, Roma e Parigi, arrivando a Matera agli inizi degli anni Settanta, le ho condivise con realtà che non conoscevo. Relazionandomi con la memoria, i saperi e le culture materiali delle popolazioni che frequentavo, sono emerse tematiche e poetiche di studi e ricerche sulla città e il suo territorio che non avevo mai considerato di affrontare. E questo ha cambiato in gran parte il mio modus vivendi, di considerare me stesso in un contesto sociale ed economico molto lontano da città importanti per l’arte come Milano e Torino. Matera diventò un luogo d’affezione, in cui lavorare e condividere sogni, utopie e progetti con una società che nel dopoguerra aveva impressionato persone come Adriano Olivetti, Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi, letterati e poeti come Pablo Neruda, Fernando Arrabal, l’etnologo Ernesto De Martino e tanti altri che si erano fermati per brevi o lunghi periodi. Un’antica città, unica nel suo genere in cui ho trovato infinite opportunità di agire al suo interno, usando i mezzi e gli strumenti del lavoro artistico aperto agli altri, alle idee e alle utopie.
Ernesto De Martino scrisse che il Sud era sinonimo di magia e sud e magia erano tra loro inscindibili. Matera era per me la stessa cosa: un luogo magico costituto dalle cose che andavo fotografando e disegnando dove le immagini erano i segni della mia presenza.

LP: Un giorno mi hai detto che in ogni casa di Matera c’era una tua mostra…
MC: In realtà si trattava di Tricarico, un piccolo paese in provincia di Matera, dove iniziò nell’estate del 1967 la mia collaborazione con un gruppo di architetti e urbanisti che da Venezia si erano trasferiti a Tricarico per progettare il Piano Regolatore del paese. Avevo l’incarico di fotografare il paese e gli interni delle case e di avvicinarmi quindi alle storie di quelle famiglie e tra le tante un giorno mi raccontarono di un contadino emigrato per lavoro negli Stati Uniti che periodicamente riceveva dalla moglie una fotografia formato cartolina nella quale lei e i tre figli erano ripresi in posa frontale con uno spazio lasciato vuoto accanto alla donna. In quello spazio il marito, vestito a festa e in posizione analoga e proporzionata, incollava la sua fotografia al fianco di quella della moglie e rispediva la nuova immagine ai suoi cari. Questo rituale avveniva ogni due mesi circa e dava un enorme valore alla fotografia. Il modo e il senso dell’operazione mi colpirono profondamente. L’immagine era la parte conclusiva di un processo affettivo che nella sua essenzialità mi fece comprendere che il mistero più intrigante non sta nel luogo fotografato, ma nel rapporto che si stabilisce. Un rapporto tra quel che vedo di fronte a me e l’io che guarda. Il mistero è insomma in una soglia, in un’interfaccia, in un tra. La fotografia in se stessa era per me la parte visibile dell’umano, di quel profondo nascosto nel racconto della storia che mi interessava ancor più dell’immagine stessa. Dopo alcuni mesi nella canonica della chiesa madre, l’unico spazio allora disponibile, si inaugurò la mia prima mostra di fotografie realizzate nel paese e ricordo le persone e il divertimento collettivo quando, una volta entrate come in una sorta di processione, iniziavano a riconoscersi. Tutte le immagini furono poi distribuite alle famiglie di Tricarico che mi avevano accolto nelle loro case. Così prese vita una mostra permanente che si è forse consumata nel tempo ma che mi ha lasciato un ricordo indelebile.

LP: Oggi utilizzeremmo il termine site-specific per definire questo atteggiamento. A differenza di altri autori che usano la fotografia per compiere interventi di documentazione urbana, tu utilizzi questo linguaggio per misurarti con l’uomo, la storia, l’arte, la scienza e l’industria di un territorio.
MC: Site-specific è un termine in inglese che suona bene e che esprime un certo tipo di ricerca artistica soprattutto attraverso l’uso della fotografia. Se parli di un mio atteggiamento in riguardo, penso tu abbia ragione nel definire site-specific un modo di vedere non fuori ma dentro alle cose, non la forma esterna del mondo, quanto piuttosto quella del suo interno. In questo senso mi ha sempre interessato ciò che non si vede facilmente ed è un piacere fare questo perché non esistono limiti di scelta e puoi rendere visibile il “minimum” della realtà materiale. In questi ultimi anni di attività artistica penso che tutto il mio lavoro sia stato un site-specific spalmato su varie tematiche quasi sempre legate ai luoghi in cui vivevo con il desiderio e la curiosità di conoscerne la storia tra passato e presente, una specie di sonda nel reale, sempre sensibile al caso, agli imprevisti e alla trasgressione dell’appartenenza, spesso e volentieri fuori dal bisogno di farsi riconoscere, di mantenere l’immagine di un fotografico ripetuto e riconoscibile. Sentivo la necessità di avere sottomano una realtà fisica per inventarne altre possibili che non immaginavo a priori, ma che nascevano solo a contatto diretto con i luoghi, i contesti, le luci, gli umori, i comportamenti dei miei referenti. Mi piaceva pensare a un’arte che si avvicinasse anche al senso di una ricerca sul campo. Un percorso di conoscenza, così definito in ambito etno-antropologico che poteva condurre a ulteriori estensioni di senso del mio lavoro. In definitiva si trattava di un site-specific di una società complessa come per esempio quella di Matera in cui gli spazi della realtà urbana erano percepiti come il risultato formale di una serie di sedimentazioni storiche d’idee spesso sbagliate e omologate rispetto ai bisogni delle persone.

LP: Da “Matera, immagini e documenti” (1975), passando per “Martina Franca immaginaria” (1981), “Matera luoghi d’affezione” (1992), sino ai più recenti interventi realizzati specificatamente per la città di Bergamo (2009) e sulla collezione della Pinacoteca Nazionale di Bologna (2010). Com’è cambiata la tua ricerca in questi anni?
MC: Rispetto agli anni trascorsi è cambiata profondamente l’idea di avere un referente sociale come fonte primaria dell’agire e del fare con o senza la fotografia. È cambiato il territorio, la città, le persone, la scuola, il contesto artistico ed economico e i problemi di allora non sono quelli di adesso. Si è rafforzata la mia avversità verso una fotografia puramente retinica che ancora oggi penso sia una trappola mortale per la fotografia di ricerca e con essa l’idea di bellezza che si rispecchia attraverso la ripetizione e l’omologazione di se stessa, perché il mercato dell’arte ha bisogno di facile visibilità, ha poco tempo per studiare e approfondire per esempio i lavori dei giovani. È cambiato il mio ruolo un tempo maggiormente legato a una realtà sociale che sentivo vicina, ma che oggi è frammentata. Ora, quello che faccio è spesso fine a se stesso, citando Arthur Danto. Lavoro per me, ma conservo ancora due dimensioni vitali che sono l’insegnamento e il rapporto con i luoghi dell’arte intesi nella più estesa accezione del termine. In entrambi i casi ho la possibilità di conoscere e di partecipare, di vedere e rivedere per riconoscere o dimenticare le mie motivazioni sentendomi libero di sentire gli altri, i giovani, le opere, le architetture, le loro storie, il loro futuro e l’immaginario che da questi rapporti riesco a coltivare per il mio lavoro.

LP: Nella serie di opere realizzate a Bologna non hai utilizzato solamente il linguaggio fotografico, ma ti sei avvicinato alla video installazione, sperimentando anche le nuove possibilità espressive offerte da piattaforme multimediali come iPod e iPad. Cosa ti ha spinto a relazionarti all’arte del passato utilizzando i cosiddetti new media?
MC: Agli inizi degli anni Settanta avevo realizzato un lungometraggio dal titolo Cronistorie e nel 2003 una breve serie di video girati in Svezia ora nella collezione della GAM di Torino. Per l’intervento alla Pinacoteca di Bologna ho usato una semplice tecnica di animazione da computer che mi ha permesso, nella sua semplicità applicativa, di proiettare sequenze di segni-luce che in pochi minuti svelano le superfici delle opere d’arte sulla base di figure geometriche come il quadrato, il rettangolo, il cerchio e la croce. Sono immagini di luce che illuminano e definiscono un punto di attenzione dell’opera d’arte che ne è coinvolta. Ho voluto disegnare con la luce uno sguardo verso alcuni dipinti e affreschi conservati in Pinacoteca che avevo scelto di usare nel primo sopralluogo. Per il progetto site-specific di Bologna, uno dei temi centrali del mio intervento era quello della luce che rimandava alla specificità del linguaggio fotografico e con esso alle sue origini, in cui Talbot sperimentava le prime calotipie della storia attraverso il depositarsi della luce solare sulle superfici fotosensibili dei primi negativi di carta. Questa vicenda mi ha sempre interessato e ho pensato di riprenderla con il senso di oggi all’interno degli spazi espositivi della Pinacoteca di Bologna. È stata anche l’occasione per attivare una nuova collaborazione con tre giovani artisti del gruppo Cracovia che hanno realizzato le video proiezioni della mostra.
LP: In questi giorni all’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma esponi un nuovo progetto. Di cosa si tratta?
MC: La mostra di Roma è un progetto realizzato all’interno di un luogo storico che conserva il più vasto patrimonio di matrici calcografiche insieme con stampe, disegni e fotografie. È un’istituzione unica nel suo genere che consente di accedere direttamente alla consultazione di opere e documenti correlati tra di loro, condizione fondamentale per uno studio analitico e una ricostruzione della storia della grafica. Il progetto della mostra dal titolo “Attraverso la traccia” ha tenuto conto del contesto storico e anche di quello architettonico di Palazzo Poli che fa da sfondo scenografico alla Fontana di Trevi. È un luogo di straordinario interesse che mi ha permesso di vedere le lastre calcografiche originali di alcuni artisti come: Giovan Battista Piranesi, Giorgio Morandi, Salvator Rosa. Ho pensato a un percorso di riflessione sul senso del disegno usando la fotografia come mezzo di rivelazione della luce che le matrici e le lastre di rame consentono di vedere attraverso minimi spostamenti e quindi di essere fermati per un attimo nel tempo dalla visione fotografica. Qui la fotografia insieme a un ciclo di video in stop motion sulle “Carceri d’invenzione” di Piranesi e le nature morte di Morandi formano un percorso visivo che nasce dal forte avvicinamento ottico alla materia dei segni incisi e stampati su metallo e su carta che sono rivelati in movimento e nella fissità delle immagini fotografiche. I segni reali tracciati dalla mano dell’artista sulla lastra di rame sono quindi un punto di partenza, la fonte primaria e il pretesto per produrne altri di natura ottica senza supporto e senza materia.

LP: In quali altre città e musei hai già in programma di lavorare?
MC: Dopo Bologna e Roma, a giugno di quest’anno si concluderà a Matera il ciclo di interventi pensato dal curatore Luigi Ficacci e da Antonella Fusco, Francesca Bonetti e Marta Ragozzino. È previsto un catalogo generale che presenterà i contenuti delle tre mostre. Dopo si aprono alcune possibilità a Bari, Milano e Venezia, tutte da verificare, ma è molto importante per me avere avviato un lavoro artistico con le istituzioni culturali che in questo momento vivono momenti difficili che tutti conosciamo. Il mio contributo potrebbe costituire un momento di riflessione per continuare a valorizzare i luoghi dell’arte e dare ad altri artisti questa opportunità.