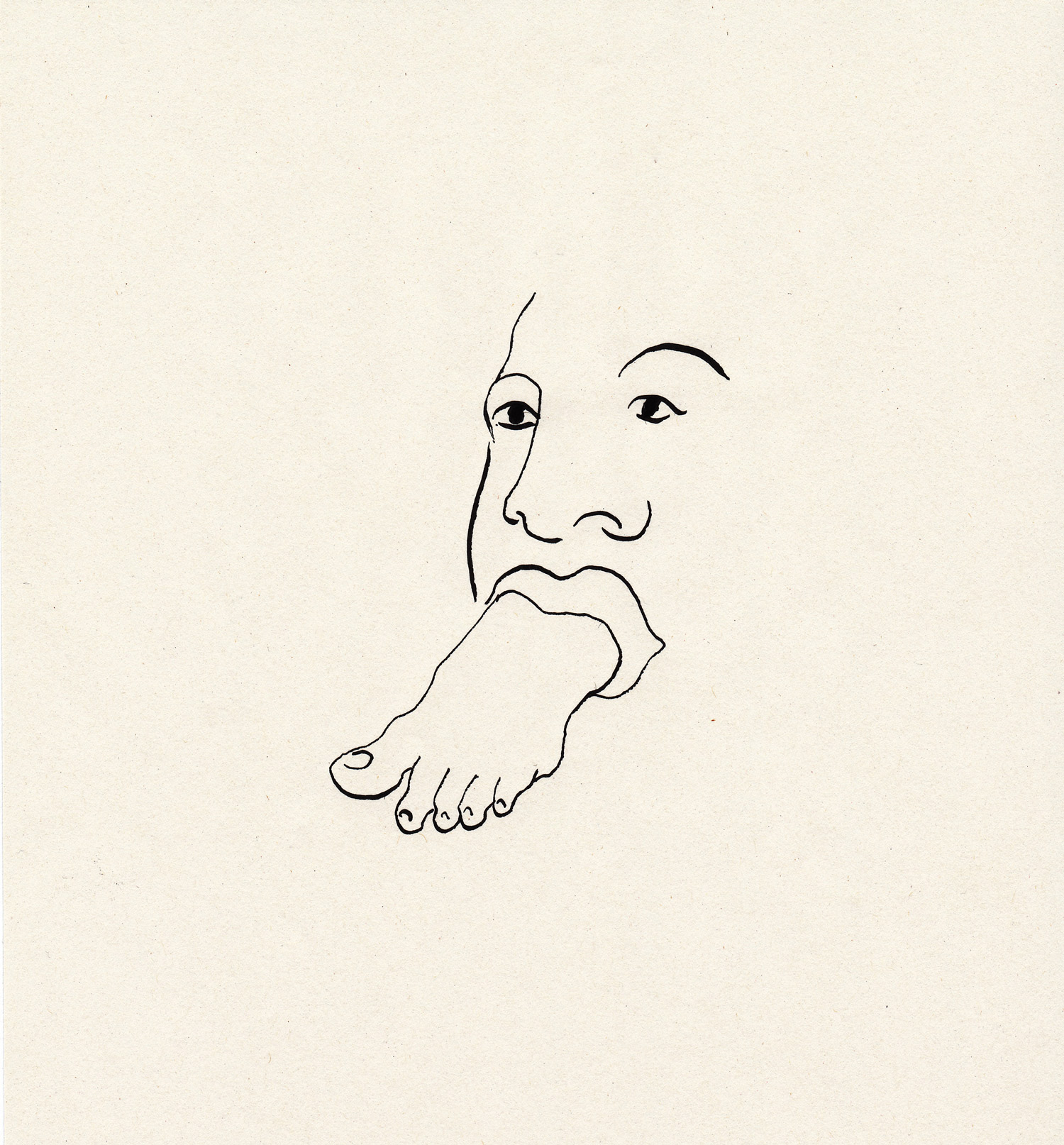Barbara Meneghel: Le tue opere si richiamano spesso a un mondo onirico e suggestivo, componendosi di oggetti rubati alla natura e al sogno. Anche le scelte cromatiche remano in direzione opposta al realismo, preferendo scenari fiabeschi e subconsci. Quali sono — se ci sono — le tue fonti di ispirazione?
Marta Pierobon: Traggo ispirazione da tutto ciò che vedo intorno a me, e che crea un ritmo o una vibrazione. Sono portata a far confluire nel mio lavoro molte delle forme esterne che mi colpiscono, e che poi mescolo tra loro. È come se diventassi un imbuto, un filtro tra ciò che sta fuori e ciò che voglio esprimere. Queste forme esistono in un qualunque momento della giornata. Nel tempo, poi, sono stata influenzata dalle filosofie orientali, dall’iconografia commerciale americana… Ma ogni tipo di espressione — linguistica, estetica o grafica — può diventare in qualunque momento una fonte preziosa. Nella realtà ci sono molti mondi fantastici, più di quanti si possa pensare.
BM: Il tuo lavoro si sviluppa su un doppio binario: bidimensionale con il disegno e la pittura, e tridimensionale con le installazioni. Che rapporto c’è tra le due forme? Cosa nasce prima?
MP: Il rapporto tra bidimensionalità e tridimensionalità è assolutamente inscindibile: il disegno influenza la scultura, la scultura l’installazione, l’installazione la pittura. Come una spirale colorata in cui non è chiaro dove inizi la reale sfumatura che poi porterà al colore successivo, o che proviene da quello precedente. Entrambe, sin dall’inizio, sono sempre esistite insieme, l’una accanto all’altra dentro la mia mente, e a un certo punto hanno iniziato a esistere insieme anche nella realtà.
BM: Le tue installazioni accolgono spesso numerosi oggetti-giocattoli, piccoli mondi che sembri scegliere per esplorare le potenzialità della materia. È così? Che importanza hanno per te colori e materiali?
MP: Tendo a utilizzare gli oggetti che mi circondano, e ciascuno mi appare in un primo momento senza una precisa codificazione. Quando guardo una tazza, per esempio, io vedo una forma. So che quella determinata forma si chiama tazza, so come usarla e a cosa serve, ma questa è una traduzione intellettuale della tazza, è il concetto che l’accompagna. Ciò che avviene prima di questo intellettualismo è la separazione dell’oggetto dalla sua stessa realtà: la tazza si distacca dalla propria definizione, esiste solo come forma, e come tale entra nel mio mondo. Magari non verranno mai tradotti quei precisi tratti per come sono entrati, perché si mischieranno con altre forme per poi risultare nel mio lavoro stravolti, ma presenti. Ciò che faccio è sostanzialmente raccogliere forme, manipolarle e renderle più mie di quanto non fossero nel momento in cui le ho scelte. Lo faccio per istinto, credo sia il mio modo di tradurre ciò che vedo in qualcosa di visibile anche agli altri.
BM: Trovo che l’estetica del tuo lavoro si collochi molto più vicino a un trend internazionale, statunitense in particolare, che non alla sensibilità nostrana, per certi versi più concettuale. Sei d’accordo? Quanto e in che modo hanno influito sul tuo lavoro i lunghi periodi trascorsi a New York?
MP: Aver vissuto all’estero ha certamente influito sulla mia espressione artistica, più che sulla mia percezione delle cose. Per quanto riguarda New York, è una realtà molto particolare. Ci sono idee, concetti, forme, espressioni e tutto in grande quantità e fermento. Il bacino da cui attingere diventa enorme, è come se trovassi tutto ciò che mi serve e che permette di estendermi sia mentalmente che formalmente: una specie di villaggio della creatività. Muovermi continuamente tra New York e l’Italia è estremamente stimolante, mi ritrovo in bilico tra questi mondi ed è su questa linea sottile che mi piace camminare.