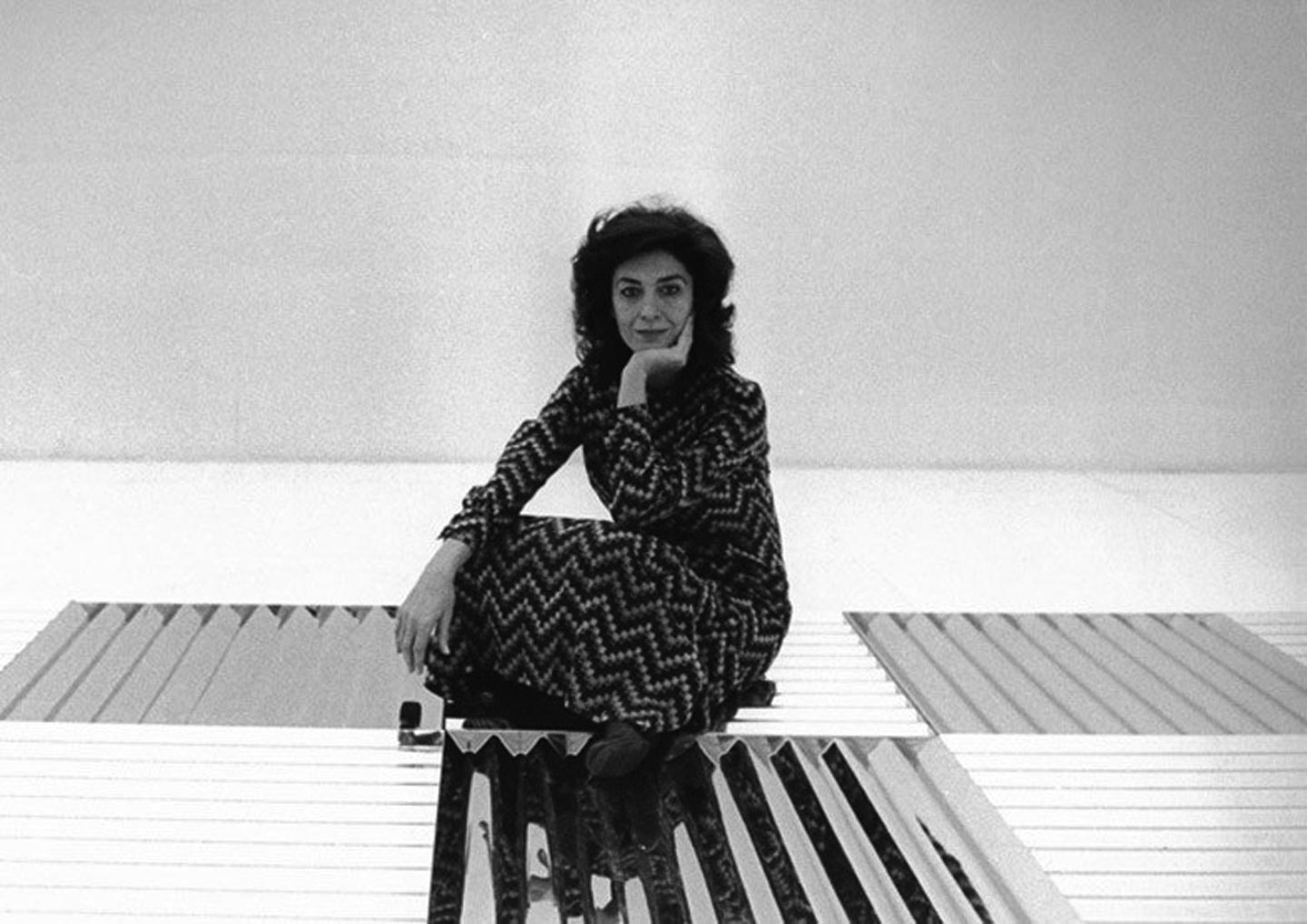Karen Wright: Parliamo dell’Italia. Sei nato vicino a Milano?
Massimiliano Gioni: Sono nato a Busto Arsizio, non lontano dall’areoporto della Malpensa.
KW: L’hai definita una città provinciale, nonostante sia poco lontana da Milano.
MG: Era una città di 100,000 abitanti. Adesso è diventata più piccola credo, perché, come molte altre città, si sta restringendo.
KW: Raccontami qualcosa della tua famiglia.
MG: Mia madre è un’insegnante in pensione e mio padre lavorava in una fabbrica che produceva inchiostro. Quando è andato in pensione, era dirigente dello stabilimento. Ho un fratello e una sorella: vivono, come il resto della famiglia, ancora a Busto Arsizio. Io me ne sono andato molto presto. Sono partito per il Canada quando avevo 15 anni dopo aver vinto una borsa di studio che mi ha permesso di frequentare una scuola internazionale canadese. Poi sono ritornato a Bologna dove ho studiato storia dell’arte e filosofia.
KW: Seguivi le lezioni di Umberto Eco?
MG: Lui era a capo del dipartimento di Comunicazione, ma non seguivo le sue lezioni direttamente, anche se ho frequentato alcuni suoi seminari. Durante l’università ero indeciso tra la specializzazione in arte antica o contemporanea, ma l’arte contemporanea è stata uno dei miei interessi principali da quando avevo 15 anni più o meno.
KW: Come mai?
MG: In realtà non è che sapessi esattamente che mi interessava l’arte contemporanea, ma sono incappato presto nei manifesti futuristi, dadaisti e surrealisti. Erano tutti molto affascinanti perché così poco chiari (ride). Erano oscuri, incomprensibili, eppure diretti. E poi mi ricordo che nella biblioteca di Busto Arsizio ho trovato il libro di Lucy Lippard sulla Pop Art, mentre facevo una ricerca sulla guerra in Vietnam. Ricordo quel momento molto chiaramente. Dovevo essere poco più giovane dei quindici anni, forse ne avevo quattordici, e fu un grande shock. Ricordo che sulla copertina c’era il dipinto Odol di Stuart Davis.
KW: È una bella immagine.
MG: Credo che in fondo l’interesse per l’arte sia nato proprio dalla sensazione che fosse una scoperta mia, un territorio che mi appartenesse personalmente. L’arte contemporanea non la insegnavano a scuola e in casa non se ne parlava, quindi era una cosa mia, qualcosa da apprendere da solo.

KW: È interessante che tu abbia citato Stuart Davis, perché credo che l’uso dell’arte commerciale e pubblicitaria sia stato un filo conduttore nel tuo lavoro.
MG: In realtà all’epoca ero attratto semplicemente da immagini, oggetti, libri. In Canada poi ho visto l’altro libro di Lucy Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object, e anche quella è stata una rivelazione.
KW: Un bellissimo libro.
MG: Ricordo che non lo lessi nemmeno, ma una volta alla settimana lo sfogliavo pensando: “Cos’è questa cosa? Non è un libro e non è una storia dell’arte.” L’ambiguità di quel libro e in generale l’ambiguità dell’arte contemporanea può essere molto eccitante, perché ti obbliga a cercare di capire qualcosa che in fondo deve restare incomprensibile. Dopo il Canada, sono partito per Bologna, e mentre frequentavo l’università, ho fondato la rivista online TRAX con alcuni amici — un nome un po’ stupido forse… Sarà stato il 1995? Ci sembrava che sul web ci fosse una carenza di contenuti.
KW: C’è ancora adesso!
MG: Grazie a questa rivista online, Flash Art sentì parlare di me e mi propose di lavorare come redattore.
KW: Vivevi ancora in Italia?
MG: Dopo Bologna sono andato a Milano per lavorare nella redazione di Flash Art. Alla fine del 1999, se non sbaglio, mi sono spostato a New York dove ho iniziato a lavorare come redattore di Flash Art International.
KW: Come è avvenuto l’incontro con Maurizio Cattelan?
MG: Ci siamo conosciuti a Milano. Prima di arrivare a Flash Art, l’idea di curare mostre non mi aveva mai sfiorato. A quell’epoca, essere scrittori e critici era la massima aspirazione all’interno del mondo dell’arte. Non esisteva la figura del curatore. Credo che Cream (volume pubblicato da Phaidon nel 1998) sia stato il libro che ha imposto l’attività curatoriale come una professione, tanto da renderla più importante della critica. A quei tempi per me era più importante essere un critico d’arte, anche se organizzavo già eventi con artisti e amici. Ho incontrato Maurizio perché stavo lavorando a un articolo su di lui per Flash Art Italia, e lui non concedeva interviste… Invece di rispondere alle domande, aveva sul computer un file gigantesco in cui raccoglieva risposte e citazioni da diversi personaggi — ogni volta che leggeva qualcosa che gli piaceva, la copiava e la inseriva in questo documento Word. C’erano frammenti di interviste di Andy Warhol, frasi di Francesco Clemente, Alighiero Boetti o di chiunque gli piacesse, chiunque avesse detto qualcosa che lo interessasse. Perciò durante l’intervista, gli facevi una domanda e lui rispondeva “Un attimo,” e iniziava a sfogliare il documento finché non trovava una frase che funzionasse da risposta. La nostra intervista si è svolta in questo modo. Fu un processo abbastanza doloroso, infinito, ma molto interessante. Credo fosse una specie di meccanismo di difesa, anche per supplire a una certa timidezza, ma era anche una strategia per rendere le cose più complicate, per aggiungere alla mitologia dell’artista ladro. Leggendo quelle interviste, si aveva la sensazione strana di…
KW: …di averle lette prima altrove.
MG: Esatto. Le risposte non combaciavano con le domande. Praticamente lo stesso giorno di quella prima intervista — ed era un momento molto speciale perché la sua carriera stava decollando, stava preparando il pezzo al MoMA con la maschera di Picasso — ecco quel giorno, Maurizio mi disse: “Devo fare un’intervista con Radio RAI. Vuoi farla tu?”, “Certo” ho detto, anche se non sapevo esattamente come avrei finto di essere lui. È stato divertente. Avevo 24 o 25 anni. Ho fatto l’intervista in diretta. Parlavo facendo finta di essere lui, ma l’idea era che anche le mie risposte sembrassero in qualche modo distaccate, strane, riciclate. A mia volta avevo saccheggiato un sacco di frasi da Carmelo Bene, Gino De Dominicis, Umberto Eco e Nanni Balestrini.
KW: …un po’ come parlare con Jeff Koons…
MG: No, non credo, perché la cosa piu inquietante di Jeff Koons è che lui non sta recitando: lui è proprio così. Non è un attore! È proprio sincero (ride). Poi per qualche anno mi sono occupato delle interviste di Maurizio. Per diversi anni tutto ciò che è stato pubblicato, scritto o trasmesso in televisione a nome di Maurizio erano in realtà parole mie. Era un modo diverso di essere un critico d’arte. Per molti versi era quello che avevo sempre pensato fosse la vera critica d’arte. Non mi era mai piaciuta l’idea che un critico potesse stroncare l’artista e la sua opera. Per me un critico doveva essere un compagno dell’artista. Forse leggere André Breton e Tristan Tzara in gioventù mi ha influenzato. Leggendoli pensavo: “Wow, questi scrittori sono i portavoce dell’artista.” In un certo senso per qualche tempo sono stato letteralmente il portavoce di Maurizio, il suo megafono. Mi piaceva anche l’aspetto diciamo più scomodo di questa collaborazione: significava perdere l’oggettività tipica del critico, diventare davvero critico militante, al punto da scomparire dietro l’artista o da diverntarne la sua voce. E mi divertiva anche osservare che effetto facesse sulle persone, sia sui giornalisti quando magari scoprivano che avevano parlato con me e non con Maurizio e in generale sugli altri critici, curatori e artisti. C’era un aspetto perverso, di confusione, che mi interessava. E poi, osservandolo dall’interno, credo che si impari molto sulla comunicazione.

KW: Quando sei partito per New York?
MG: Mi pare nell’inverno del 1999, lavoravo a Flash Art. A New York il rapporto con Maurizio si è rafforzato. Inizialmente mi occupavo delle interviste, ma poi ho fatto anche il responsabile della comunicazione della sesta Biennale dei Caraibi.
KW: Non c’era bisogno di un vero e proprio curatore, essendo una biennale senza arte giusto?
MG: Maurizio aveva bisogno di un curatore per simulare l’idea di una istituzione. Jens Hoffmann era coinvolto dall’inizio come co-curatore — tutto era iniziato per gioco in seguito all’affermazione di Jens: “Dovremmo aprire un Guggenheim a Brooklyn,” perché il Guggenheim stava aprendo ovunque, a Bilbao e San Paolo… Dal Guggengheim Brooklyn si arrivò alla Biennale dei Caraibi. A New York iniziammo a occuparci di cose diverse. Vedevo Maurizio tutti i giorni, parlavamo d’arte, andavamo alle mostre, e così iniziammo una rivista intitolata Charley, che viene pubblicata tutt’ora, ogni volta che abbiamo un’idea, insieme ad Ali Subotnick. Intorno al 2002 o 2003, Maurizio, Ali e io abbiamo fondato la nostra galleria, la Wrong Gallery. Poi, nell’estate del 2002, Beatrice Trussardi mi ha contattato perché cercava un nuovo direttore per la sua Fondazione e, dopo molte conversazioni e colloqui, mi ha chiamato a dirigere la Fondazione Nicola Trussardi.

KW: Hai lavorato alla Fondazione sin dagli inizi?
MG: No, la Fondazione è stata creata da suo padre nel 1996. Ma Beatrice sin da subito ha deciso che sarebbe stata una delle sue attività di ricerca più importanti. È andata a studiare alla New York University proprio per prepararsi a guidare la Fondazione. È tornata a Milano dopo la scomparsa del padre e ne è diventata presidente e direttrice sin da allora. Nel 2002 mi ha assunto come curatore e da allora abbiamo deciso di cambiare la Fondazione radicalmente. Abbiamo lasciato lo spazio espositivo in Piazza Scala in favore di un museo di carattere nomade: era un modo per utilizzare l’intera città come un museo, e un modo per ottenere molto con poco. Infatti i nostri budget sono di tutto rispetto, ma in confronto ad altre fondazioni della moda lavoriamo con risorse diverse: siamo più piccoli ma molto più flessibili e in un certo senso più aggressivi. A Milano prima di noi non esistevano istituzioni dedicate all’arte pubblica e a progetti artistici per ridisegnare la città. La nostra ispirazione erano Art Angel e Public Art Fund.
KW: Milano è bizzarra, vero?
MG: Per molti versi è una città strana. Per quanto riguarda artisti, gallerie e collezionisti è la capitale italiana, ma allo stesso tempo manca il sostegno da parte delle istituzioni. Non c’è mai stato un museo d’arte contemporanea. La mancanza di istituzioni ha concesso ai privati di dominare la scena, quindi personaggi come Trussardi, Prada, o anche Pomodoro, hanno dato vita a fondazioni che ricoprono il ruolo che le istituzioni non hanno. Quando ho iniziato a lavorare con Beatrice, l’unica competizione diretta era Prada, o almeno era con loro che ci confrontavamo idealmente. Prada ha un’immagine e un’identità fortissima e sia la moda sia l’arte sono tutte concentrate nei loro bellissimi spazi. Con Trussardi abbiamo fatto la scelta opposta: portare l’arte in strada o comunque in giro per la città. Beatrice e io avevamo la sensazione che a Milano esistesse un pubblico potenzialmente appassionato all’arte, ma che doveva incontrare l’arte nella vita di tutti giorni: pensavamo che fosse l’arte a dover cercare il pubblico, e non viceversa. E poi, uscendo dai contenitori tradizionali delle gallerie e dei musei, ci sembrava fosse più facile attirare l’attenzione del pubblico e della critica: significava imporre l’arte nel dibattito quotidiano. Questo atteggiamento ci sembrava più contemporaneo e più originale. L’essenza della Fondazione non stava nel logo o in un luogo, ma nella strategia e nelle idee. Nessuna fondazione lavorava in questo modo e quindi rappresentava per noi un’opportunità importante.
KW: Hai riproposto la stessa idea alla Biennale di Berlino.
MG: Sì, l’idea è partita proprio da Milano, e il concetto si basa sulla ricerca di luoghi che normalmente non hanno a che fare con l’arte; non c’è bisogno di modificarli; vengono usati così come sono, come una capsula temporale in cui si colloca l’esposizione. La mostra qui alla Stazione Leopolda di Firenze (“8 ½”, dal 13 gennaio al 6 febbraio 2011, ndr) non ha nulla a che fare con le esposizioni che organizziamo a Milano, perché a Milano ogni esposizione avviene in uno spazio particolare ed è studiata appositamente per quello spazio. L’idea del museo itinerante e nomade è stata anche una critica più o meno velata al ruolo delle istituzioni cittadine. Era come dire “Non abbiamo bisogno di un museo, perché i musei esistono già: abbiamo questi bellissimi posti, usiamoli. Abbiamo bisogno delle opere d’arte, degli artisti e delle idee, non degli edifici.” Io dico sempre che investiamo nel software piuttosto che nell’hardware. Beatrice ha adottato questo modo di lavorare perché le sembrava più contemporaneo. In un certo senso il lavoro di Maurizio ha influenzato il mio metodo lavorativo. Come lui, ho sempre creduto che un’opera d’arte esiste all’incrocio di un network di informazioni, esperienze, miti, leggende e pettegolezzi: l’opera esiste solo laddove si intersecano diversi sistemi informativi.
KW: Questo ci riporta alla Wrong Gallery. Mi piace la descrizione che Anton Kern fa della galleria e delle sue esposizioni , dicendo che si tratta di una “galleria parassita”. In un certo senso questa visione si può attribuire anche alla Fondazione Trussardi.
MG: È vero, in italiano è interessante che la parola “ospite” si riferisca sia a chi dà l’ospitalità sia a chi l’ospitalità la usa. Come si chiama quella creatura che occupa le conchiglie di altre creature? Il paguro: ecco la Fondazione Trussardi lavora in modo simile. Però più che di parassitismo credo si possa parlare di simbiosi. All’inizio con la Fondazione Trussardi organizzavamo esposizioni che erano più simili a eventi e incursioni. Quando lanci una mostra e parli di un nuovo edificio, un nuovo artista, due o tre sorprese, i mass media rispondono con entusiasmo, perché ci sono molti elementi di novità. Le prime mostre erano gesti anche di rottura. Esporre un’opera come Short Cut di Elmgreen & Dragset a Milano ha richiesto molta pianificazione, diplomazia, l’influenza di Beatrice, il dialogo con i politici. Si trattava di un lavoro costituito da una macchina e una roulotte posizionati su un passaggio pedonale nel centro di Milano. All’inaugurazione della mostra, ci hanno messo una multa da 700 euro per parcheggio in sosta vietata. Non sto scherzando. Avevamo tutti i permessi per allestire l’esposizione durante la notte, perché ci è sempre piaciuto fare un’entrata a sorpresa. Così abbiamo finito l’allestimento alle sei del mattino. E nonostante il sindaco e i membri della commissione fossero stati informati, la polizia ci diede la multa. Li abbiamo chiamati per spiegare che avevamo le carte in regola. Non credo che una cosa simile sia successa a James Lingwood ad Artangel. La seconda mostra era una personale di Darren Almond a Palazzo della Ragione. Questa volta quindi si trattava di una mostra più intimista, al chiuso. Ci piaceva l’idea di alternare opere più frontali con altre piu introspettive. Noi diciamo sempre che rendiamo l’arte pubblica, non facciamo arte pubblica. Noi portiamo l’arte al pubblico, organizziamo presentazioni gratuite e accessibili dieci ore al giorno, cercando di localizzarle nei punti critici del sistema nervoso della città.

KW: Quindi le commissioni diventano parte della collezione?
MG: Non necessariamente. Nella maggior parte dei casi commissioniamo e produciamo le opere perché esponiamo in luoghi cosi speciali che non basta prendere a prestito opere esistenti. Con il passare del tempo diventa sempre piu difficile trovare nuovi spazi espositivi. Milano non è così grande, quindi cerchiamo gli spazi in base agli artisti che abbiamo in mente, e una volta trovato lo spazio contattiamo l’artista. Per esempio, da sempre volevamo collaborare con Paul McCarthy; nel frattempo stavamo lavorando su Palazzo Citterio da molti anni; quando abbiamo ottenuto lo spazio, abbiamo detto a Paul: “Avremmo un edificio a disposizione e sappiamo che stai lavorando a un pezzo intitolato Pig Island (2010), vorremmo esporlo in questo spazio incredibile.”
Di solito commissioniamo e produciamo almeno una o più opere nuove. All’inizio, Beatrice ha sottolineato molto chiaramente che con la Fondazione non le interessava creare una collezione e che la figura della collezionista social e mondana non le interessava affatto. Ho capito che le interessava un modello diverso, ovvero quello che mette a disposizione degli artisti le risorse di cui necessitano per creare opere ambiziose e uniche, opere che possano girare il mondo e essere conosciute perché assolutamente inusuali. Tutte le nostre esposizioni sono state prodotte per luoghi specifici, ma la cosa davvero appagante è che le opere hanno poi girato il mondo, in esposizioni, musei, biennali. Per certi versi è bello lavorare a Milano, perché gli artisti sono più aperti alla sperimentazione: provano cose che poi possono portare altrove. E al pubblico sembra piacere questa idea dell’uso temporaneo di luoghi inusuali. Le nostre mostre sono come collage in cui l’edificio rappresenta una storia sulla quale si innesta l’arte, e arte e storia possono essere in dialogo o scontrarsi, producendo nuove energie.
KW: L’esposizione qui alla stazione Leopolda è un po’ diversa, vero?
MG: Effettivamente sì e forse tanti lavori insieme hanno un effetto un po’ eccessivo, molto carnevalesco. È un approccio molto diverso dal nostro usuale. Quando organizziamo una mostra a Milano, viene data molta attenzione alla coreografia e a come l’artista e l’istituzione collaborano, al fine di creare un’esperienza unica. Scherzo sempre con gli artisti dicendo che con la Fondazione Trussardi non facciamo retrospettive ma introspettive. La mostra introspettiva ha una serie di aspetti e caratteristiche ben precise: non sono organizzate cronologicamente ma per consonanze visive o tematiche. La coreografia dell’intera mostra è decisa insieme all’artista, così che la mostra stessa diventa una sorta di grande opera che incorpora anche l’ambiente. E poi cerchiamo di far sì che la mostra sia una sorta di discesa nella testa dell’artista: l’ingresso e l’uscita della mostra per esempio di solito non coincidono, così hai l’impressione di lasciarti la realtà alle spalle e di sprofondare nel mondo dell’artista.
KW: A questo punto volevo chiederti qualcosa sulla combinazione Tino Sehgal e Paola Pivi nella mostra a Firenze.
MG: Abbiamo dedicato a Tino una grande mostra a Villa Reale a Milano, una villa settecentesca che adesso è diventata la Galleria d’Arte Moderna, dove tutto è così melodrammatico. L’arte del Settecento faceva da sfondo, e l’artista era sia un parassita sia il protagonista dell’evento. La mostra era immersa in questa sensazione di melodramma, con le guardie del museo che danzavano… A Firenze quando hai visto la mostra stavamo ancora sperimentando sulla collocazione finale dell’opera di Tino.
KW: Mentre cercavo qualche informazione su di te, ho trovato una tua curiosa dichiarazione che riguardava il capitalismo che interferisce con l’arte.
MG: No no, parlavo di Realismo Capitalista… Sì, ci ho pensato molto.

KW: Che cos’è per te il Realismo Capitalista?
MG: L’appellativo deriva da Gerhard Richter e Sigmar Polke; era il titolo di una esposizione che organizzarono negli anni Sessanta. Uso questa espressione quando penso a come certe opere d’arte odierne — mi riferisco a Damien Hirst, soprattutto, o a quel tipo di arte che è ormai una forma di alta finanza — siano diventate l’equivalente di quello che un tempo erano le opere del Realismo Socialista. Da spettatori occidentali, siamo portati a denigrare il Realismo Socialista perché lo riteniamo troppo illustrativo e propagandistico, ma io penso che non ne siamo poi così lontani, perché un certo tipo di arte contemporanea racchiude in sé e proietta i valori del capitalismo estremo con la stessa ingenuità e con lo stesso tono illustrativo con cui un’immagine di un contadino che miete i campi nell’Unione Sovietica inneggiava alla politica di Stalin. È una questione molto problematica. Non sto dicendo che il capitalismo ha rovinato il mondo dell’arte, tutt’altro. Questo non lo credo affatto. Dopotutto ci troviamo a Firenze, dove il denaro ha prodotto alcune tra le più grandi opere d’arte al mondo…
KW: Ci sono sempre stati mecenati nell’arte. Michelangelo fu un grande artista anche grazie al supporto di un mecenate…
MG: Forse l’artista contemporaneo ha più libertà che mai. Conosci il libro di Michael Baxandall su Firenze, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento? Baxandall racconta che il mecenate del Quattrocento aveva un rapporto più stretto con l’arte rispetto a oggi, al punto che poteva dire all’artista esattamente cosa fare. Quindi non dico che il capitalismo sia un fenomeno che rovina il mondo dell’arte, ma ritengo che dobbiamo essere consapevoli di come l’opera viene usata e come essa entra a far parte di un valore. È interessante pensare a quanto questo può influenzare la produzione dell’arte contemporanea. La Fondazione Trussardi è questo: vogliamo proporre arte in spazi pubblici, e proporre un’arte che a sua volta crea spazi pubblici, ma cerchiamo di farlo senza essere per forza confortanti e consolatori o concilianti. L’arte deve rimanere se stessa e deve rimanere anche frustrante e irritante. Questa è la responsabilità dell’arte.
KW: A proposito di un altro tuo progetto, “Younger Than Jesus” (2009) al New Museum, ho avuto qualche perplessità, soprattutto per quanto riguarda l’edificio.
MG: L’edificio del New Museum non è certo colpa mia (ride), In realtà al New Museum cerchiamo di fare vari tipi di mostre. Ci sono, per esempio, le mostre personali in cui l’artista ha il controllo di quasi tutto lo spazio, un modello nato dal lavoro svolto a Milano. Mi incuriosisce vedere cosa capita quando un artista è responsabile della coreografia di un intero spazio espositivo. La recente mostra dedicata a Philippe Parreno alla Serpentine ne è un grande esempio. Poi ci sono le mostre collettive: “After Nature”, la collettiva che ho curato nel 2009 al New Museum, cercava di trasformare la mostra in una finzione, interrogandosi anche sul ruolo che i musei hanno nella costruzione della realtà.
E, infine, c’è la mostra come occasione di informazione, come ricognizione, per fare il punto su una nuova scena o su un nuovo stile. “Younger Than Jesus” è il tipo di mostra che i musei dovrebbero proporre, e non lo fanno, perché è piu facile raccogliere fondi per mostre personali di nomi celebri.
KW: È un processo molto costoso.
MG: Sì, è difficile finanziare le mostre se gli sponsor non conoscono i nomi degli artisti. Per questo “Younger Than Jesus” fu anche una sfida. Ma in realtà la mostra era nata dalla paura suscitatami dalle opere di Ryan Trecartin. Il suo è un lavoro di fronte al quale ho avvertito con precisione la presenza di un gap generazionale. I suoi personaggi parlano una lingua che non riesco più a comprendere, perché sono diversi, più giovani, cresciuti in un mondo lontano dal mio. “Younger Than Jesus” non era una mostra basata sul concetto di giovinezza, ma piuttosto sull’idea di una frattura generazionale.
KW: Dal punto di vista delle scoperte è stata una grande mostra.
MG: Siamo stati molto fortunati nel riuscire a lavorare con grandi artisti come Kerstin Brätsch, Elad Lassry, Cyprien Gaillard, Ryan Gander e Jakub Julian Ziolkowski. Fu una specie di mostra “paesaggio”, in cui volevamo catturare l’impressione di un momento storico, l’energia di un momento di passaggio.
KW: La stessa cosa è successa a Gwangju per la Biennale “10,000 Lives”.
MG: In realtà credo che Gwangju fosse l’opposto: era una biennale costruita come un museo, quindi interessata alla storia. Includeva opere che datavano dal 1901 a oggi. Era una mostra enciclopedica. O forse un’enciclopedia personale.