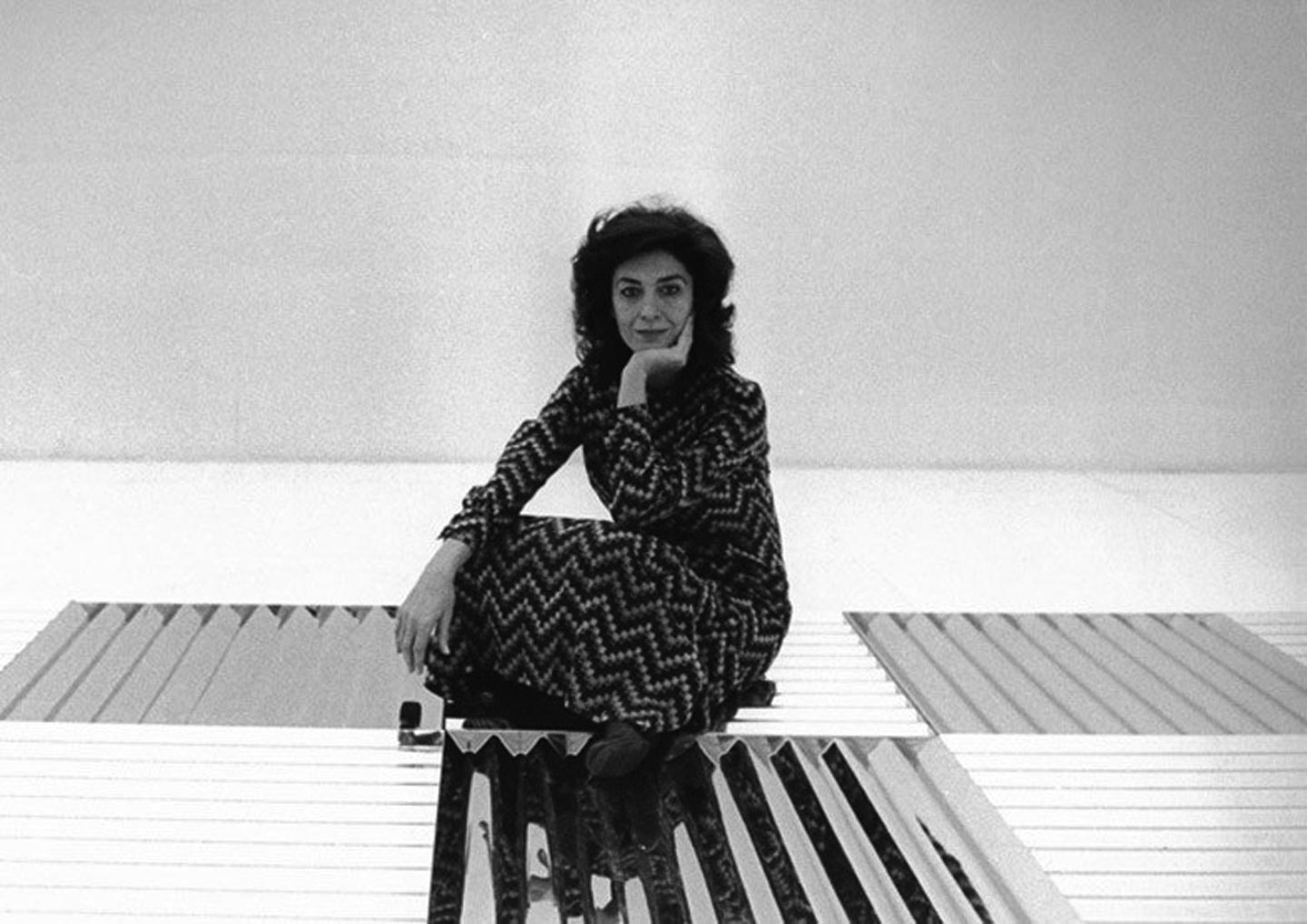Originariamente pubblicato in Flash Art no. 292, Aprile 2011.

Giancarlo Politi: Caro Mimmo, trent’anni di successi e trent’anni ai vertici del sistema dell’arte, con mostre in gallerie prestigiose in Italia e nel mondo, istituzioni, musei. Come ti senti dopo trent’anni? Come è cambiato il mondo e il sistema dell’arte ai tuoi occhi?
Mimmo Paladino: Onestamente, non me lo sono mai chiesto. Ognuno di noi vive il mondo dell’arte in maniera differente. È inevitabile che ci siano delle mutazioni macroscopiche nel mondo e nel sistema dell’arte. Una di queste è l’interruzione del rapporto artista-gallerista-critico, che forse oggi si coagula in un unicum un po’ strano e mutevole: queste figure stranamente si mescolano in una sorta di comunicazione un po’ confusa. In passato, quello che arrivava prima di tutti alla comprensione di un artista era il mercante, oggi è il critico. Forse perché non ci sono più mercanti lungimiranti come prima!
GP: Come definiresti il tuo rapporto con le gallerie e i galleristi?
MP: Ho conosciuto figure di galleristi come Lucio Amelio ed Emilio Mazzoli, persone estremamente veloci a carpire i mutamenti dell’arte e a intraprendere un contatto diretto con gli artisti. Mi sembra che invece oggi la figura del gallerista sia diventata parte di un meccanismo economico planetario. La prima scultura, per esempio, l’ho realizzata perché Mazzoli mi disse “vai in fonderia e fai una scultura”. Io non avevo mai pensato prima di fare scultura! Le intuizioni dei galleristi, in conclusione, sono fondamentali per gli artisti.
GP: Mi sembra che oggi lavori più con le istituzioni pubbliche che non con le gallerie. In che modo avvengono queste commissioni?
MP: Molte amministrazioni scelgono di commissionare delle opere agli artisti piuttosto che mettere in piazza la pubblicità di qualcosa, come per esempio è accaduto a Modena, una città molto sensibile all’arte. La stessa cosa è avvenuta per Napoli e ora a Milano, con la Montagna del Sale. Un’opera che svanirà dopo essere stata in mostra, proprio come accadde nella città partenopea quindici anni fa.
GP: Parlami del tuo lavoro, dal mitico e programmatico Silenzioso, mi ritiro a dipingere un quadro, del 1977, a oggi. Come è cambiata o si è trasformata la tua pittura?
MP: Non posso parlare di mutazioni o evoluzioni di uno stile, ma di trasformazioni che derivano dai cambiamenti della Storia. La mia prima opera non poteva non nascere in quell’anno: più di un’opera si tratta di un titolo, nato per esprimere la volontà di rottura rispetto a tutto quello che c’era stato prima. Silenzioso, mi ritiro a dipingere un quadro fu esposta in una galleria d’avanguardia insieme con alcuni disegni, come se fosse un’installazione. Quella prima opera era legata a un determinato momento storico, quindi è ovvio che in seguito ci siano state altre cose. Se oggi ripenso a quell’opera, la vedo come parte di un percorso e, pur facendo parte di un insieme, appare comunque strettamente legata a quel momento specifico. Ogni singola opera appartiene al proprio tempo, anche se è peculiarità dell’arte “andare oltre”.
GP:Il tuo lavoro è sempre stato caratterizzato da una componente postmoderna. Straordinaria e originale iconografia con frequenti blitz nella storia o nella letteratura. Non ti ha mai tentato l’idea e l’ambizione di raccontare il nostro tempo, in una sorta di commedia umana?
MP: Io cerco sempre, quando lavoro, di essere nel mio tempo, ma penso comunque che l’arte debba andare oltre. Il mio primo dipinto, per esempio, è estremamente legato a quel particolare momento, perché è in chiave anti-concettuale; è la coda di un concettualismo che si esprime attraverso il mezzo pittorico. Se guardo all’arte di Caravaggio penso alla sua forza evocativa, non al momento storico. Se guardo Guernica di Picasso, ovviamente penso all’avvenimento storico, ma non è solo questo che mi colpisce dell’opera, che va oltre, per una potenza pittorica intrinseca. Credo che l’arte abbia sempre conservato questo valore, tranne in alcuni momenti in cui c’era una precisa attenzione verso una forma ideologica o concettuale per cui questo ne determina un condizionamento che non riesce a farla andare al di là del proprio tempo. Ma questo ovviamente dipende dall’artista. Mi viene in mente Duchamp, che pur essendo estremamente legato a un’epoca riesce comunque ad avere una grande forza evocativa.

GP:Viviamo in un’epoca, oltre ai nostri guai italiani, a dir poco nebulosa. Forse stiamo vivendo un momento di cambiamenti epocali. Ritieni che il tuo lavoro partecipi di queste ansie e di queste paure?
MP: Assolutamente no. Ho realizzato delle opere, come per esempio Porta di Lampedusa – Porta d’Europa, che è stata concepita per i migranti, per ricordare le persone morte in mare: è chiaro dunque che essa ha una valenza simbolica molto precisa, in quanto è stata realizzata con un determinato scopo. Oltre a questo però ha un valore evocativo e simbolico che va oltre. L’opera comunque è nata in circostanze casuali: qualcuno mi ha chiesto “perché non realizzi un monumento in piazza per le persone morte in mare?” e io ho accettato, ma non ho voluto collocare l’opera in piazza, bensì nel posto più lontano dal centro, in un luogo molto vicino all’acqua. Volevo che l’opera si caricasse di significati, che raccontasse questa tragedia, ma che evocasse anche la luce, il vento, la forza del mare: per questo è stata posta nel punto più estremo dell’isola: mi piaceva il fatto che fosse la porta dell’Europa. È un’opera strettamente legata ai nostri tempi.
GP: Montagna del Sale che porterai a Milano vuole essere un monito per Milano, l’Italia e l’Europa?
MP: Al contrario. L’opera è nata per il teatro (l’opera fu usata per la prima volta nel 1990 a Gibellina, come quinta dello spettacolo teatrale La sposa di Messina, ndr), doveva essere collocata accanto al cretto di Burri. Poi pensai di portarla a Napoli, nel 1995, in un momento di grande euforia per la città, quando si parlava, in quegli anni addirittura di “Rinascimento napoletano”. È un’opera che viveva di questo ritrovato entusiasmo per cui i napoletani accolsero questa forma piramidale come un elemento di grande positività e io credo che questo debba rappresentare ancora oggi. Il sale è una sostanza carica di significati esoterici, è sempre stato qualcosa di estremamente prezioso e il fatto che viaggi da sud a nord è importante, soprattutto se si pensa che l’opera sarà inaugurata in concomitanza con i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Gli artisti sono creature apolidi, ma sono convinto che in questo momento sia importante puntare l’attenzione sul concetto di unità. È necessario che ci sia un’unità del paese a livello culturale e, soprattutto, che ci siamo degli uomini pensanti, da nord a sud.

GP: Segui la scena artistica internazionale? Cosa percepisci di quello che sta accadendo intorno a te, nel mondo dell’arte?
MP: Io sono uno che si guarda molto intorno e osservo quello che accade con interesse. Credo che nell’arte ci siano dei momenti di attesa: ecco, questo è un momento di attesa e preparazione per il futuro. Le circostanze storiche hanno sempre una grande influenza sul mondo dell’arte. Il fatto, per esempio che i paesi arabi si siano improvvisamente ribellati ai regimi è una cosa che nessuno aveva previsto. Credo che in questo momento bisogna guardare ai paesi arabi, più vicini a noi sia geograficamente che come spirito culturale, che non alla Cina, assai lontana.
GP: In questi ultimi anni la pittura è stata un po’ ghettizzata, è stata relegata in un angolo dalle Biennali, dalle grandi mostre ed emarginata anche dai curatori più giovani. Ciononostante, ha registrato grandi successi sul piano commerciale. Come ti spieghi questa cosa?
MP: Se io fossi un curatore non farei di queste differenze: sul piano dei contenuti tutti i linguaggi sono importanti. Credo che sia ridicolo ghettizzare una forma d’arte. Esiste una forma di consumo rapido e veloce della creatività, una superficialità nel guardare all’arte per cui basta che un’opera sia clamorosa perché riscuota successo. Penso al linguaggio televisivo, che è po’ lo specchio dei nostri tempi, caratterizzato da un’estrema velocità e immediatezza. L’artista invece accumula, contempla e poi trasforma. Oggi siamo di fronte a un appiattimento dei linguaggi perché la figura del curatore è subentrata in maniera prepotente. La pittura ha bisogno di meditazione, di cultura e di contemplazione. Altre espressioni artistiche appaiono invece più immediate per cui è anche più semplice leggerle e identificarle. La pubblicità per esempio è più diretta e più riconoscibile; al contrario un dipinto presenta molteplici chiavi di lettura. La lettura di un quadro è infatti più impegnativa e profonda. Con questo non voglio dire che la pittura è superiore ad altri linguaggi, ma che necessita di una lettura più approfondita.
GP: Molti artisti, te compreso, sono passati dall’arte al cinema. Anche tu hai avuto un’esperienza cinematografica con il film Quijote (2006). Cosa ha significato per te questa incursione nel cinema?
MP: Questa fuga nel cinema era un desiderio che coltivavo da anni. Mi ha sempre affascinato molto la coralità del mezzo cinematografico e il fatto che puoi costruire una storia a partire dai “frammenti” che hai girato e poi comporli in fase di montaggio, proprio come se stessi realizzando un quadro. Fare cinema è come costruire un grande affresco insieme con i tuoi assistenti di bottega. Per me il cinema ha rappresentato un passo in avanti verso il pubblico: mostrare non solo immagini, ma anche una storia, il suono, i dialoghi è per chi guarda più coinvolgente che osservare un quadro, almeno su un piano “popolare”. Insomma, il cinema è più avvincente per il grande pubblico e riesce a cogliere una sensibilità che forse con la pittura fai fatica a cogliere.
GP: Cosa ti ha dato l’esperienza cinematografica? Ha influenzato la tua pittura?
MP: Dopo il film, dovevo fare una mostra e ho realizzato quaranta piccoli quadri, come dei fotogrammi. Mi è apparso comunque riduttivo rispetto al lavoro cinematografico. Quando fai il primo film, tutti si aspettano il secondo, sopratutto se il primo è andato bene: ho cominciato già a pensarci, ci sono un po’ di idee.

GP: Quest’anno la Transavanguardia compie trentadue anni. Cosa pensi sia stata? Un movimento, un’etichetta o una strategia di marketing che ha funzionato nella promozione dell’arte?
MP: Alla fine degli anni Settanta, cinque artisti cominciarono a utilizzare degli strumenti che apparivano allora assolutamente desueti e lo fecero in modo assolutamente innovativo e funambolico, passando attraverso il linguaggio delle avanguardie storiche, la figurazione novecentesca, l’astrazione, con un atteggiamento scanzonato e ironico che in quel momento brillò più di altri. Poi in seguito ci furono esperienze simili anche in altri paesi europei. Gli italiani usavano la pittura con poca seriosità. La Transavanguardia, in poche parole, è l’attraversamento delle avanguardie. Con la Transavanguardia ci fu inoltre un’attenzione straordinaria a livello internazionale, che forse in Italia c’era stata solo per l’Arte Povera.
GP: Ma adesso, dopo trentadue anni, ti ritrovi ancora in questa definizione?
MP: Per quanto mi riguarda, il mio spirito è rimasto invariato e ogni giorno cerco di divertirmi a “ritrovare” certe forme. Dopo il concettualismo che aveva azzerato tutto, bisognava ripartire da qualcosa, era un’urgenza.
GP: Credi che il tuo percorso sarebbe stato lo stesso anche senza la Transavanguardia?
MP: Quando io e gli altri artisti fummo invitati da Jean Christophe Ammann a fare una mostra alla Kunsthalle di Basilea, non era stata ancora coniata la definizione “Transavanguardia”. Prima ancora c’era stata “Artecifra” da Paul Maenz. Insomma, prima della nascita del termine Transavanguardia c’era già un’attenzione da parte dei galleristi europei verso alcuni artisti italiani. Il clima era fertile, ma fu comunque importante la presenza di una lettura critica e una “definizione” da parte dei critici. Proprio come era avvenuto con Germano Celant e l’Arte Povera.
GP: Conoscevi da tempo gli altri artisti della Transavanguardia oppure vi siete conosciuti in seguito?
MP: No, a parte De Maria, che ogni tanto veniva a Milano non conoscevo nessuno. Ci siamo conosciuti per le mostre. Chia e Cucchi erano quelli più in contatto tra loro, ma vivevamo tutti in città diverse per cui era difficile frequentarsi.
GP: La tua prodigiosa facilità esecutiva, la mano che riesce a star dietro al pensiero veloce, mi fa pensare a Picasso.
MP: Picasso è sicuramente il genio del Novecento ed è ovvio che io mi riconosca nella sua grande curiosità. E anche per tanti altri aspetti, come l’attenzione per la grafica d’arte, il desiderio di modificare il senso delle forme senza preoccuparmi di ciò che è stato fatto prima. Un atteggiamento del genere lo si ritrova anche in Rauschenberg. Alla base c’è comunque un atteggiamento onnivoro, la capacità di passare dalla pittura alla scultura alla ceramica, la volontà di indagare continuamente sulla capacità di un segno, che può essere cinematografico, grafico, ecc. L’arte è un unicum. Personalmente mi interrogo di continuo sulla capacità di questi segni e cerco sempre di apportare delle novità al mio lavoro. È emozionante quando ti rendi conto che stai realizzando qualcosa che ha un significato più alto rispetto a quello che hai fatto in precedenza.
GP: Sei critico nei confronti del tuo lavoro?
MP: Sì, molto. Spesso quello che “cancelli” e che non utilizzi può fornire spunti per quello che farai dopo. Altre cose invece devono nascere con un’idea molto chiara e questo non permette errori. È come camminare in un sentiero e scoprire delle cose. La progettualità è invece necessaria a rallentare quando lavori senza un ordine ben preciso.
GP: Ti è mai capitato di cominciare un’opera e poi accantonarla per un po’?
MP: Certo. Poi dopo qualche anno la tiri fuori e riprendi a lavorare.
GP: Hai mai desiderato vivere in un’epoca storica diversa da quella presente? Dove ti saresti collocato?
MP: Sicuramente tra gli artisti dell’Antichità. Vivo in questa epoca, certo, ma non è detto che per certi aspetti non possa sentirmi più vicino a un’artista del Cinquecento.

GP: Un eroe in cui ti riconosci? Don Chisciotte?
MP: Don Chisciotte l’ho incontrato per caso e poi è diventato il soggetto del mio film. Il Don Chisciotte è una metafora dell’artista, perché vede ciò che non esiste, proprio come l’artista. L’immaginazione, la fantasia sono certamente prerogative dell’arte. L’incontro con questo personaggio è diventato poi un crogiuolo di letture: ci puoi ritrovare Borges, Joyce, insomma, tutto il vasto panorama figurativo e letterario dell’umanità. Il grande dramma del Don Chisciotte è proprio questo: legge troppo e si ritrova perso in tutto questo universo di segni e di letture. Io credo che l’arte sia tutto questo: un modo pieno di segni, ma comunque un unicum. Mi sento vicino a Picasso, come ti dicevo, ma anche vicino a Mozart.
GP: Oltre alla pittura e all’arte, cosa c’è nella tua vita?
MP: La mia famiglia, i miei affetti. E ovviamente, l’arte. Non c’è una scala di valori, sono tutti ugualmente importanti.
GP: Segui dei giovani artisti? Vengono da te a chiederti dei consigli?
MP: Non lo faccio molto spesso, ma solo per pigrizia. Amo più guardare che parlare. La mia vera scuola è stata il guardare, più che parlare e leggere. Quando sono stato per la prima volta alla Biennale di Venezia e ho visto Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Jesper Johns, ho scoperto che era quella la mia scuola, la mia “Cappella Sistina”. A quindici anni non ero di certo un artista e l’esperienza della Biennale è stata molto significativa, anche perché venivo da un piccolo paese del Sud e vedere le opere degli americani è stato per me un grande shock visivo.
GP: Hai avuto una carriera artistica di grandi soddisfazioni, affermandoti nel panorama dell’arte molto presto, a 29 anni. Grandi musei, grandi gallerie, importanti pubblicazioni. Cosa chiedi ancora oggi al tuo lavoro?
MP: Mi auguro di affrontare sempre nuovi progetti, con la stessa capacità di chiedermi cosa succederà in futuro. Insomma, senza fare troppo affidamento sull’esperienza. L’esperienza può venirti in aiuto, certo, ma io mi auguro sempre di avere un atteggiamento di stupore rispetto a quello che faccio. Il successo c’è stato, è vero, ma non così incombente come lo è stato per tanti altri artisti tedeschi o americani. Gli artisti italiani riescono sempre a mantenere una certa freschezza. Penso a Jannis Kounellis, il cui lavoro, per la sua originalità, ancora oggi ci appare quasi come quello di un giovane artista. Oppure Mario Merz, che manteneva intatta la sua originalità e inventiva. Pochi artisti italiani si sono “assopiti” sui loro successi. Se guardo indietro nel tempo, penso a Tiziano, che è riuscito a essere estremamente innovativo per tutta la sua lunga attività artistica.

GP: Insomma, sei riuscito a superare la routine, sempre in agguato. Pochi riescono.
MP: Cito ancora Picasso, il quale diceva, all’apice del successo, che stava ancora cercando di imparare a disegnare come un bambino. Anche Mirò, oppure Calder, continuavano a stupirsi di quello che facevano. Artisti che riuscivano a non apparire mai noiosi e sempre innovativi. Molti altri, pur realizzando opere di grande qualità, appaiono comunque scontati.
GP: Ti reputi un uomo felice?
MP: Esiste la felicità? Non credo. Esiste invece la quotidianità, che forse è ancora più importante.
GP: C’è stata un’opera che ti è piaciuta a tal punto da affermare che avresti voluto farla tu?
MP: Mi succede spesso, sia per artisti del passato che per contemporanei. Di fronte ad alcuni artisti, specialmente quelli del passato, si resta spiazzati. Se penso a Kounellis, penso alla sua inventiva e capacità di creare forme sempre nuove a partire da pochi e sempre uguali elementi. La coerenza linguistica è molto stimolante, è quasi una spinta agonistica.
GP: Come è nata l’idea di fare una mostra a Milano?
MP: Da circa venti anni si parla di una mia mostra a Milano. Il curatore stava già lavorando al progetto, così gli ho chiesto di curare la mostra. La nostra intenzione era di fare un’antologica non noiosa; lo spazio non era enorme, per cui le opere esposte non sono molte, ma si tratta di lavori importanti. I testi in catalogo sono due: uno di Germano Celant l’altro di Arthur Danto, inedito, più un’intervista del curatore, Flavio Arensi. Danto ha scritto puntando l’attenzione sulla scultura, mentre Celant ha scritto un testo di “analisi”, partendo dai primi anni, ovvero dal 1970-75 per poi arrivare agli anni Ottanta. Si tratta quindi di due letture non consuete del mio lavoro.