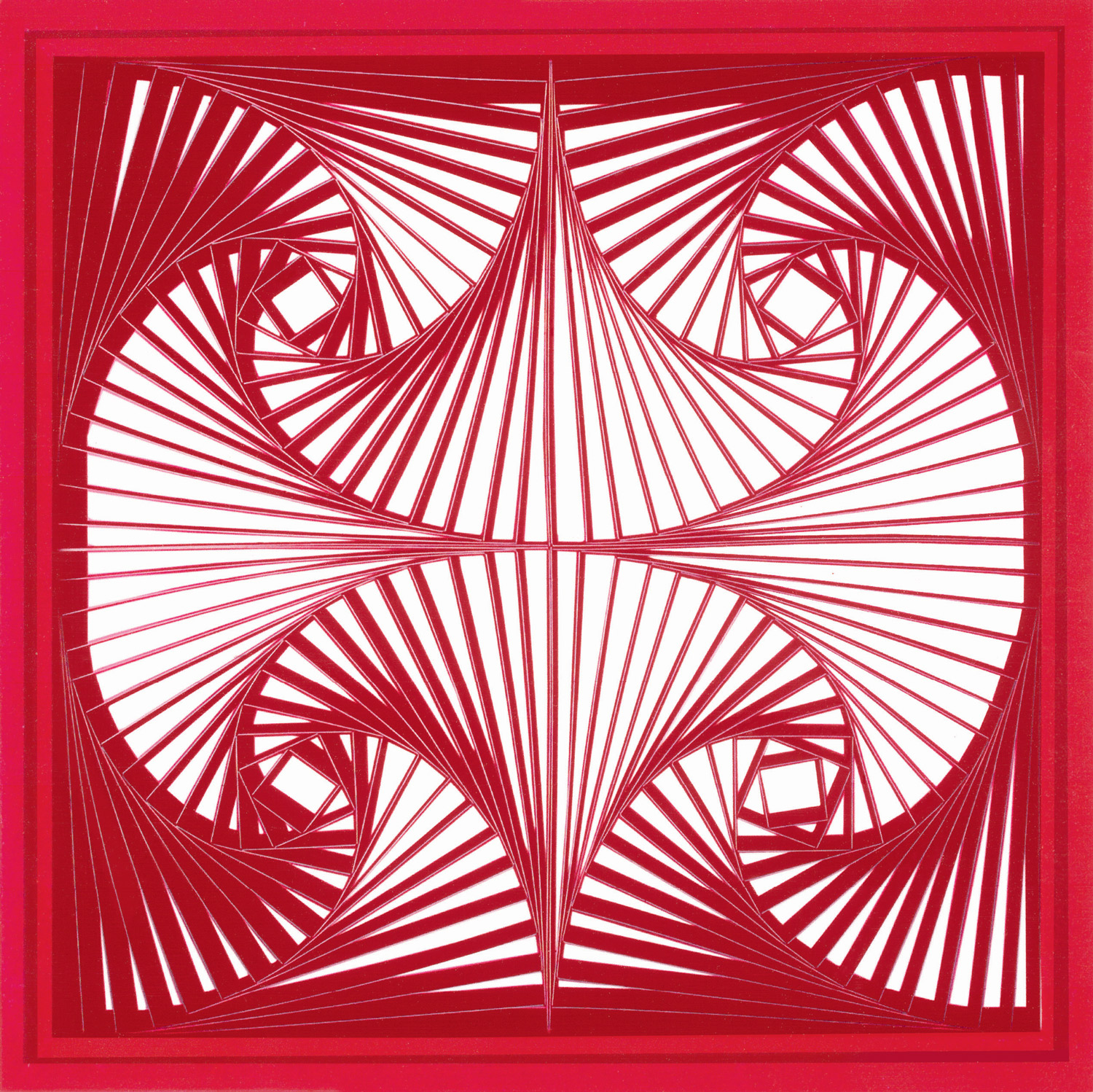Mohammedkarlpolpot nasce a Parigi il 10 ottobre 1999. Scaturito dalla fantasia di Adel Abdessemed, Mohammedkarlpolpot è un personaggio immaginario che concentra nel proprio nome alcune delle ideologie che hanno agitato il mondo occidentale e non: il profeta Mohammed, il filosofo Karl Marx e il dittatore cambogiano Polpot. Mohammedkarlpolpot è una sorta di Uber-father, una figura paterna che incarna “diverse epitomi del potere, una trinità condensata in una parola”, come la descrive l’artista. Forse Mohammedkarlpolpot è anche un esorcismo, un modo per nominare e quindi scongiurare il male. Di certo, è un segno dei tempi se oggi un artista, invece di inventarsi un alter ego gioioso e sensuale come Rrose Selavy o sdoppiarsi come un Alighiero e Boetti, è costretto a partorire un mostro come Mohammedkarlpolpot. Abdessemed stesso non è nuovo alla re-invenzione della sua identità. Anche se giovanissimo, ha già vissuto molte vite e ha conosciuto da vicino la mostruosità dell’ideologia. Nato in Algeria nel 1971 da una famiglia di origini berbere, Abdessemed cresce a Batna, la capitale della provincia degli Aures. La storia di Batna è legata profondamente alla colonizzazione e alle lotte di liberazione dell’Algeria, ma anche ai recenti attentati di Al Qaeda. Proprio per sfuggire all’escalation di violenza esplosa in Algeria dopo l’assassinio del presidente Boudiaf, nel 1994 Abdessemed fugge da Algeri, dove si era trasferito a studiare arte, e arriva a Lione dove gli viene concesso l’asilo politico e si iscrive all’accademia per non dover vivere in clandestinità. Dopo cinque anni trascorsi a Lione, Abdessemed si trasferisce a Parigi e da lì inizia una serie di pellegrinaggi nelle capitali del mondo, da New York a Berlino, poi di nuovo Parigi e ancora New York. A raccontarla così, la vita di Abdessemed e di sua moglie Julie sembra seguire il copione stereotipato e ormai un po’ sgualcito a cui ci ha abituato la retorica della globalizzazione anni Novanta. A differenza di molti artisti di quella decade, però, Abdessemed pratica l’esilio non per scelta ma per forza: la clandestinità non è una comoda metafora, ma è dura realtà. La geografia per lui non è uno spazio di infinite possibilità, quanto piuttosto una serie di confini, di ostacoli.
D’altra parte, tra gli anni Novanta e questa prima decade del 2000 si è consumata una frattura insanabile tra gli artisti che credevano nella possibilità di un’integrazione pacifica, da United Colors of Benetton, e chi ora invece pensa al mondo come un territorio di conflitti e di scontri. Abdessemed ovviamente appartiene a questa seconda compagine: “Oggi — sostiene Abdessemed — non c’è più un atlante (…) siamo tutti coinvolti in un ciclone”. Ed è davvero come se tutta la sua opera vorticasse su se stessa, nervosa, irrequieta, mossa da sussulti frenetici e popolata da personaggi agitati da spasmi isterici. I suoi video sono brevi, concisi, lacerati anziché montati, ripetitivi e ossessivi, spesso durano solamente pochi secondi. Le sculture, le fotografie e i video ritraggono scheletri, bestie feroci o animali domestici morti ammazzati, rottami di aerei e auto bruciate. Nei lavori di Abdessemed non c’è alcun paradiso possibile. Non c’è alcuna nostalgia e nessun desiderio di un ritorno alle origini: come egli stesso afferma, non “sono un artista post-coloniale” poiché “non lavoro sulle cicatrici, non cerco di riparare nulla”. Abdessemed potrebbe sentire la mancanza di sua madre, ma non del suo Paese. In effetti, nell’opera di Abdessemed, il senso di appartenenza a una certa nazione — che secondo l’artista equivale a una forma di ideologia — è spesso rappresentato non dall’immagine della madre, quanto piuttosto da una figura paterna, da un personaggio maschile che incarna anche goffamente tutto il peso dell’autorità, e che Abdessemed cerca di erodere sottoponendolo a trasformazioni tanto semplici quanto radicali. Nel video Joueur de flute (1996) — una delle prime opere dell’artista — l’Imam della moschea di Lione suona il flauto posando nudo contro un fondale neutro. La costruzione dell’immagine ricorda la presunta oggettività di un film antropologico dedicato a qualche rituale primitivo. Abdessemed si appropria dello sguardo dell’etnografo e lo rovescia, giocando con gli stereotipi e i pregiudizi culturali. La nudità del protagonista, infatti, è una violazione drammatica dell’autorità dell’Iman: l’immagine non è un’allegoria di comunione con la natura e con se stesso — non è il mito del bon savage che vive libero e nudo in qualche prosperosa e lontana terra straniera. Si tratta invece di un’icona molto più complessa e contorta, che si basa su una complicata negoziazione e si risolve in una trasgressione di convinzioni personali e religiose. In maniera analoga, il video Trust Me (2007) mette in scena una conflagrazione di nazionalismo, fanatismo religioso e schizofrenia che è al contempo comica e profondamente inquietante. Un personaggio dotato di affilati canini da vampiro recita una litania composta da frammenti di vari inni nazionali. L’attore, David Moss, si lancia in uno spericolato sproloquio che ricorda le parole in libertà di un paziente affetto da un acuto episodio di glossolalia. In Trust Me il nazionalismo appare come una forma di patologia, un’isterica esplosione linguistica senza senso.

In Hot Blood (2008) — un’opera recente, attualmente esposta nella personale di Abdessemed presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino e nella sua mostra di debutto presso la galleria David Zwirner a New York — David Moss, stavolta nascosto dietro un naso rosso da clown, urla: “Sono un terrorista. Tu sei un terrorista. Sono un terrorista? Sei un terrorista?”, la sua voce rotta da improvvise risate e spasmi frenetici. Si tratta ancora una volta di una sorta di comportamento patologico, stavolta mascherato da irriverenza carnevalesca, che svela le nostre paure in tutta la loro cupa, incomprensibile assurdità. Hot Blood, per altro, mette in scena un’altra caratteristica tipica dell’opera di Abdessemed: la sua tendenza ad affrontare argomenti di scomoda attualità, quali il terrorismo, il fondamentalismo, la violenza, la repressione, a proposito dei quali però la posizione etica dell’artista non è immediatamente chiara. Abdessemed non è un moralista, non è interessato a distinguere il bene dal male. Il che non si traduce certo in una forma di equidistanza o di distacco. Al contrario, tutta l’opera di Abdessemed si basa su una “presa di posizione, perché nel mio cuore detesto la neutralità”. E le posizioni di Abdessemed sono a volte scomode, difficilmente condivisibili: sono ideali romantici, spesso irrazionali. “Mi tuffo nell’oscurità”, ha detto l’artista. “Utilizzo passione e rabbia”. Abdessemed condivide questa forma di pubblica indignazione con altri artisti emersi in questi ultimi anni e che stanno riscoprendo una certa estetica rude alla quale far corrispondere una complessa dimensione spirituale e una nuova forma di umanesimo. Artisti assai diversi quali Pawel Althamer, Phil Collins, Sharon Hayes, Klara Liden, Arthur Zmiejwski e per certi versi anche Thomas Hirschhorn hanno riscoperto nell’uso di materiali scarni la possibilità di parlare dei grandi drammi della nostra storia. Ciascuno a proprio modo, questi artisti potrebbero sottoscrivere le parole di Abdessemed che si dichiara “un artista di azioni, non un artista concettuale” e con lui potrebbero condividere un “folle, profondo amore per la nostra umanità”.
Con loro Abdessemed condivide anche una complessa relazione con la pratica della performance: l’opera di Abdessemed spesso nasce da un gesto, da un evento che viene poi preservato in video o in fotografia. L’artista preferisce non usare la parola performance perché troppo collegata all’economia, ai risultati della borsa valori. Preferisce invece parlare di “atti”. Le opere di Abdessemed hanno la velocità e la destrezza di un atto criminale, e come tali spesso avvengono in strada. Nella fotografia Kamel (2005) l’artista si ritrae mentre viene derubato da un altro nord africano, mentre nella serie intitolata “L’Atelier”, Abdessemed mette in scena un peculiare teatro di strada, popolando i marciapiedi di Parigi con creature esotiche o addirittura aliene. In Mes Amis (2005) la moglie dell’artista passeggia abbracciata a uno scheletro; in Sept Freres (2006) un branco di cinghiali selvatici scorrazza tra le auto parcheggiate; in altre immagini un asino sobbalza e scalcia, e un serpente viene schiacciato dall’artista. Nella fotografia senza dubbio più spaventosa della serie, Separation (2006), l’artista si avvicina lentamente alle spalle di un leone lasciato libero per le strade di Parigi. Eseguite tutte rigorosamente senza permessi e in maniera illegale, le immagini di questa serie possono essere lette come allegorie della condizione di ospite sgradito, di immigrante scomodo, nella quale si identifica l’artista. Ma esse partecipano anche a una tradizione tutta interna alla storia dell’arte contemporanea, tradizione che immagina la città come luogo di incontri magici e rivelazioni improvvise, una tradizione che parte dal surrealismo, passa per il situazionismo e arriva fino alle passeggiate di David Hammons, con il quale l’opera di Abdessemed sembra condividere una sintonia spontanea. Mentre Hammons prende a calci un secchio nelle strade di New York, Abdessemed pesta il tallone sul marciapiede, rompendo lattine di Coca Cola e microfoni. Il gesto di schiacciare con il tallone è una figura ricorrente nell’opera di Abdessemed: è un gesto di primaria violenza, il piede nudo contro l’asfalto, quasi che volesse sfondare il marciapiede. “Sotto l’asfalto la sabbia”, amavano scrivere sui muri gli studenti del Sessantotto parigino. Abdessemed, invece, pare volerci ricordare che ormai sotto l’asfalto striscia una violenza insidiosa come un serpente e imprevedibile come una bestia feroce. Dietro gli angoli delle strade di Parigi, a mala pena nascosta, ormai c’è l’Africa, e non quella addomesticata e psichedelica di Raymond Roussell, ma quella brutale, violenta, di Joseph Conrad. Anzi, non è neanche un’Africa da romanzo quella di Abdessemed, ma da nuova guerriglia urbana: è l’Africa dei miserabili delle periferie. I calchi delle sculture di argilla dalla serie “Practice Zero Tollerance” provengono direttamente da vere auto vandalizzate a Perpignan, durante quella stessa stagione all’inferno che avrebbe incendiato Parigi a una velocità di più di 1500 veicoli distrutti ogni notte. I mezzi di trasporto vengono spesso fatti a pezzi nell’opera di Abdessemed. In Bourek (2005) un aeroplano è accartocciato su se stesso come un vecchio rottame piovuto dal cielo. In Queen Mary (2007) il famoso transatlantico inglese è ridotto a una bagnarola di latta. Se l’arte degli anni Novanta celebrava il nomadismo, l’opera di Abdessemed ci parla dell’impossibilità del viaggio o del viaggio che finisce in tragedia e carcassa di lamiera. In una delle sue sculture più famose, l’artista crea una similitudine sconcertante tra volo e morte: uno scheletro gigantesco distende le braccia e le gambe, e spicca il volo spinto da un propulsore a reazione. “Partire è un po’ come morire”, dicono i Francesi, e oggi, quando si sale su un aereo, queste parole suonano ancora più spaventose.

“Il gatto mangia il topo” — niente di più semplice. Abdessemed vuole che le sue immagini siano brutali, crude, come in Birth of Love (2006), dove un felino divora un ratto. Il lavoro di Abdessemed si basa su una bellezza convulsa: i suoi video sono agitati dalla ripetizione e da suoni ipnotici che pulsano a un ritmo sincopato che è assolutamente personale e davvero infernale. Sentendo il ronzio dei video di Abdessemed ti chiedi spesso se questo sia il suono dell’odio. In “Don’t Trust Me” (2008) — una serie di 8 video in cui alcuni animali muoiono sotto i colpi di un martello — il suono diventa quasi insopportabile, ancora più difficile da reggere delle stesse immagini. E ancora, i rumori penetranti prodotti dagli animali in lotta in Usine (2009) sono ancora più inquietanti delle scene in cui diverse specie di creature predatrici vivono fianco a fianco. I bestiari di Abdessemed hanno generato forti reazioni e proteste nel passato. E viene davvero spontaneo chiedersi come mai la nostra indignazione non sia altrettanto accesa davanti alle immagini di autobombe in Iraq o di missili su Gaza. La domanda non è retorica, ma ci aiuta a capire una caratteristica fondamentale dell’opera di Abdessemed: come per molti altri artisti della sua generazione, la sua arte è tutta sbilanciata sul polo del crudo; rifiuta, cioè, le buone maniere e le raffinatezze del cotto. Dopo anni di immagini prodotte in alta qualità e post-prodotte, dopo decadi di speculazione sulla società dello spettacolo e di studi sui media, una nuova generazione di artisti si affida a una immediatezza che ci pare insostenibile perché è priva di filtri, brutale, sincera. L’arte di Abdessemed e di molti suoi compagni di strada è un’arte che volta le spalle al valore della produzione di alto livello e alla tecnologia avanzata che ha dominato gli ultimi decenni: questa non è estetica relazionale, è realismo asimmetrico.
C’è anche una tensione spirituale nella scelta di lavorare con gli animali, una sorta di panteismo che, ancora una volta, sembra essere un’attitudine che Abdessemed condivide con artisti come Pawel Althamer. L’artista è apertamente critico nei confronti delle principali religioni monoteiste, ma nel momento in cui rifiuta queste posizioni è come se spontaneamente ritornasse ad abbracciare una religiosità pagana, forse ancora viva nelle sue origini berbere. Nei rituali sacrificali e nella forza emblematica che Abdessemed attribuisce agli animali si può scorgere una spiritualità quasi totemica. Certo poi Abdessemed non vuole tornare a una dimensione magica: anzi è convinto che i totem, come i taboo, debbano essere distrutti, perché l’arte è innanzitutto “un mezzo di liberazione da se stessi”. Dalle fontane di vino realizzate quasi dieci anni fa, passando per i danzatori nudi di Passé Simple e Joueur de flûte, fino alle sculture di cannabis, il tema dell’ebrezza e della perdita di controllo attraversa l’intera opera di Abdessemed, come un fiotto di sangue caldo. È l’estasi il fine ultimo dell’arte di Abdessemed — una fuga dal proprio corpo, un modo d’essere oltre se stessi, che può essere raggiunto attraverso il sesso — come nel video Real Time (2003), in cui coppie di sconosciuti si intrecciano in una scena di amore di gruppo — o penzolando da un elicottero, appesi alle ali di Dio, come recita il titolo dell’ultimo suo video. E che un ateo debba parlarci di Dio è solo un paradosso apparente, assai meno imbarazzante di chi, in nome di Dio, uccide.