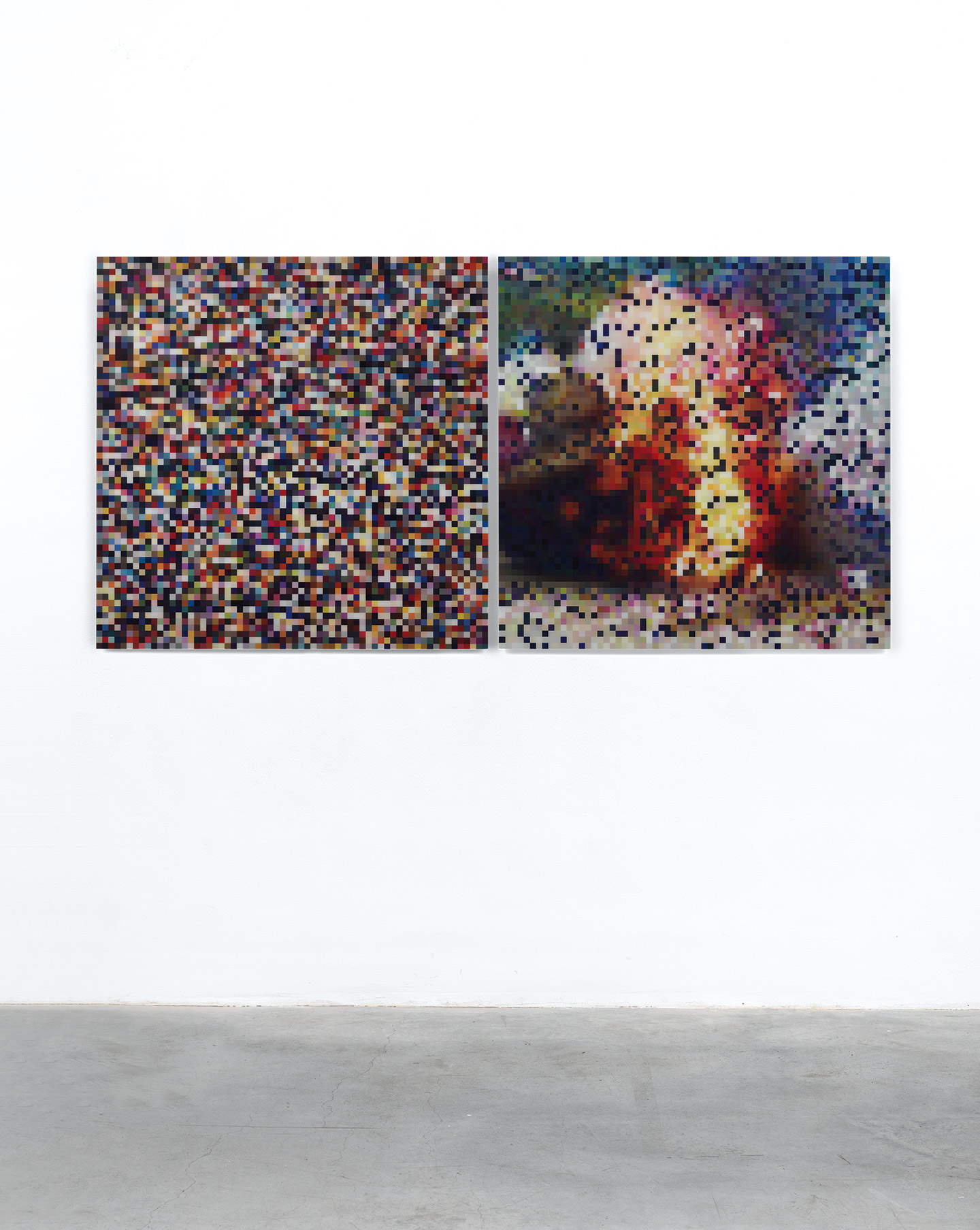Un venerdì di dicembre parto da Milano per andare a trovare Pier Paolo Calzolari. Non ho mai incontrato Pier Paolo; e non conosco Fossombrone, il paese in cui vive, nelle Marche, vicino a Urbino. Durante il viaggio penso a come sarà il nostro incontro, alla sua barba color del ghiaccio. Penso: “Gli regalerò una rosa, appena lo vedrò”. Nello studio di Pier Paolo iniziamo a sfogliare insieme il suo grande, bellissimo libro Day after Day, pubblicato in occasione della mostra curata da Catherine David al Jeu de Paume di Parigi, nel 1994. Il libro è costellato di fotografie in bianco e nero di documentazione delle performance, combinate a disegni e foto di famiglia. Guardandole inizio a fare alcune domande a Pier Paolo. Gli do del “lei”, chiamandolo “maestro”, ma lui mi blocca subito, dicendo che tra artisti bisogna assolutamente darsi del “tu”.
Marcello Maloberti: Pier Paolo, mi piacciono molto le fotografie di documentazione delle tue performance: le prime sono sempre in bianco e nero, immagini senza tempo, magiche. Sembrano opere autosufficienti; e al tempo stesso assomigliano a frammenti fortuiti, come se fossero state ritrovate in modo misterioso…
Pier Paolo Calzolari: Tutto è stato conservato in maniera non accurata. Le mie fotografie le trascinavo come le mie opere, senza casse, tra Bologna, Berlino, Parigi e New York. Solo recentemente ho affidato ogni cosa all’Archivio di Stato di Venezia. Ciò che trovi affascinante non si deve alla mia perizia; anzi, le immagini sono una conferma oggettiva del mio essere trasandato. C’è stato un periodo in cui dovetti ridurre la mia attività artistica in base agli strumenti di cui economicamente potevo disporre, alle fotografie del mio quotidiano. Quelle immagini non sono casuali, ma sono frutto della volontà di testimoniare la completezza della mia vita.
MM: Pier Paolo, da piccolo che carattere avevi? Eri già un visionario?
PPC: Dovrei chiedere in giro, ma non ho molte testimonianze. Ero molto solo, questo sì. Non frequentavo le scuole, inizialmente studiavo a casa con un precettore, sia per le scuole elementari, che per le medie e il liceo. Poi la situazione economica della mia famiglia cambiò. Ad ogni modo, non ho mai avuto compagni di classe.
MM: Pensavi già da piccolo che il tuo destino sarebbe stato quello dell’arte?
PPC: In effetti — se ci penso mi viene da sorridere — io desideravo fare il violinista. Mi sono fermato quando ho capito che per mezzi, non economici, ma potenziali e strutturali, nel senso che conta molto la postura fisica, non avrei mai avuto la possibilità di diventare violinista. Dopo anni mi sono ritrovato, non so come, a fare l’artista.
MM: In effetti, Pier Paolo, hai un fisico massiccio… C’è un pensiero di Pasolini che mi piace ricordare: Pasolini sosteneva che le prime cose che ascoltiamo, vediamo, viviamo formano il nostro sapere; poi a quelle si aggiunge altro, ma le prime ci segnano indelebilmente. Quali sono le tue prime immagini? Qual è l’origine del tuo immaginario?
PPC: Non sempre sono d’accordo con Pasolini: non con il suo cinema, né con la seconda poesia post friulana, né con il suo status politico; ma in questo caso lo sono totalmente. Ti dico: certamente Venezia. Tutta la mia infanzia è a Venezia. E anche da giovane uomo Venezia mi ha segnato profondamente. Da ragazzo, la solitudine significava camminare con la testa per aria o a testa bassa. Trovavo compagnia nelle cose. Adoravo vagolare per i ponti, toccandone i marmi e i piombi, in un susseguirsi di architetture anomale.
MM: Pier Paolo, i luoghi delle tue performance sono scenari in cui i corpi si confrontano in modo corale, come piace fare anche a me nel mio lavoro. Tu compari in alcune performance, ma mai assumendo il ruolo di assoluto protagonista. Vogliamo parlare di Canto sospeso (Bologna, 1972)?
PPC: Nella performance compaiono cinque persone: due coppie e un bambino, mio figlio Francesco Piero.
MM: Ho sempre pensato si trattasse di Olmo, il tuo secondo figlio. Amo il nome Olmo. È così bello che si fa immagine, apre un mondo.
PPC: Hai ragione… Olmo è un nome anarchico-padano, ma non del periodo fascista, ma di quello dell’invasione piemontese. Adoro gli olmi: sono alberi magnifici, enormi. Sono molto rari perché una malattia li ha colpiti e uccisi in tutta Europa. Tornando a Canto sospeso, a turno, tre persone bendate guardano verso un angolo; mentre il bambino suona un organetto, cercando di modulare i nomi dei quattro adulti. Le persone non si vedono quasi mai perché sono bendate o perché sono nascoste allo sguardo degli altri. Si muovono per un fatto di coscienza psicologica degli altri, o di sincronia, o di amore animale, diciamo, senza però che ci sia un vero protagonista. Ognuno se ne va per i fatti suoi. È un coro cieco.

MM: È un’opera che trovo molto attuale. Alcune immagini di Canto sospeso sono veramente un delirio contemporaneo. Mi è anche rimasta molto impressa la presenza di tuo figlio Francesco Piero… Mi piace molto il fatto che includi i tuoi familiari nelle opere.
PPC: Non l’ho più fatto, ma era un dettaglio determinante. Il mio lavoro performativo è molto legato a Ginestra, la mia prima moglie che è poetessa, e a cui devo tantissimo. Era una presenza illuminante. Sulla questione della “contemporaneità” non ti so dire, non mi hanno mai interessato le idee di moderno e di antico. Non so se hai mai letto il mio testo del 1968, che è stato erroneamente titolato nei cataloghi “La casa dell’arte povera”, ma in realtà si intitola “La casa ideale”…
MM: Sì, l’ho letto, me ne parli? Mi sembra uno scritto molto energico.
PPC: Quella casa, a differenza di quanto si possa credere, non c’entra niente con l’Arte Povera. Il testo fu scritto nel ’68, quando l’Arte Povera ancora era agli inizi. Si parla di orizzontalità e di verticalità. Non mi sono mai mosso nel solco dell’avanguardia; l’avanguardia, si sa, è un movimento verticale, che emerge sulla negazione del passato. Io ho sempre preferito muovermi in una specie di amalgama orizzontale. Sono molto legato ad alcuni teorici di fine ’500, inizio ’600. Leonardo da Vinci portava come atto finale della sua arte non l’architettura militare o la pittura, ma qualcosa che veniva chiamata “Festa grande”. Allora l’artista realizzava una manifestazione scenografica dove animali veri e persone si relazionavano in strutture dinamiche insieme ad animali meccanici. Passato e futuro cedevano il passo a un “momento altro”.
MM: Cosa ne pensi, Pier Paolo, della parola performance? Preferisci la parola situazione? O non dovremmo usare alcuna parola? A volte dire “performance” mi fa sorridere…
PPC: Anche se spesso dobbiamo servircene, “performance” è un termine che non mi piace, perché vuol dire tutto e niente, si può usare in diversi contesti. Nel mio caso preferisco parlare di scultura, definirmi uno scultore. Quando utilizzo la parola performance intendo descrivere lo spazio come un tempio, in cui ogni pietra, ogni colonna, ogni elemento porta l’odore, il ricordo, l’energia, la traccia dei passaggi. Questo spazio è dunque solcato da migliaia di linee di forza psicologiche. Il tempio è il luogo d’incontro, di raccoglimento delle persone, un posto di curiosità o di rifugio. Il porsi nello spazio è il momento della scultura in cui si oggettivizza il tempo. A me interessa l’insieme, e la scultura è un dettaglio otticizzato dell’insieme, non so se riesco a spiegarmi. Questo è il contesto primario del mio lavoro.
MM: Gli oggetti delle tue installazioni non sono mai veramente fermi. Penso a Canna fumante (1968, Firenze) o a Un volume da riempire in mezz’ora (1968, Galleria La tartaruga, Teatro delle mostre).
PPC: Sei preparatissimo! Anche se poi hai i tuoi furori di evasione…

MM: Ho studiato un casino… Le brine, i vapori freddi, il sale, l’acqua, il piombo, il tabacco, il neon, il ghiaccio, gli animali… Sono tutti dispositivi in movimento, performativi. Quello che io vedo è che anche negli oggetti la fissità non ti appartiene molto.
PPC: La fissità non mi appartiene, assolutamente. È bene evidenziare questo passaggio.
MM: Pier Paolo, hai una voce molto profonda, mi fai venire in mente Tom Waits. Potremmo cantare un pezzo io e te…
PPC: Sono totalmente stonato. Ho una voce tombale. Nella registrazione mancherebbero completamente i toni bassi!
MM: Bologna è stata importante per te. Mi parli del tuo rapporto con la città? A Bologna, nel 1966, hai realizzato un lavoro fondamentale come Benvenuto all’angelo…
PPC: Bologna è un luogo cruciale della mia vita, ci sono nato per caso, durante la guerra, nel 1943. In realtà è un posto che io non amo molto, anzi non amo affatto… Non amo lo status culturale di Bologna: la città ha una sensibilità foderata di mortadella. Ciò nonostante, a Bologna ho avuto lo studio per qualche anno, uno studio enorme in cui proiettai il mio spazio. In quel periodo da Bologna passavano Allen Ginsberg, William Burroughs. Il Living Theatre veniva in città spessissimo. Sono stati tutti molte volte in studio da me.
MM: Ti hanno influenzato?
PPC: Sicuramente sì.
MM: La performance Senza titolo (Malina) del 1968, dedicata all’attrice del Living Theatre Judith Malina, ha un significato molto raffinato. Come mai la dedichi a lei? È un omaggio?
PPC: Gli attore del Living Theatre erano degli angeli: Beck era un angelo, Rufus era un angelo; ma Malina no, lei era un sergente. Nel senso che accettava i fatti in maniera diligente. Mi interessava questo. Nella performance appare il mio cane, che avevo appunto chiamato Malina. Aveva gli occhi rossi. Adesso questi cani li sopprimono quando nascono. In questo lavoro gli occhi hanno un significato. Non rappresentano direttamente una lesione della retina, ma una lesione del tempo, della retina e poi del cervello. C’è sempre un rapporto di usura temporale, dove il tempo lavora di usura sulle cellule di un albino. Per quello usai blocchi di ghiaccio rosa, parallelepipedi. Poi li ho sostituiti, ho capito che erano meglio bianchi…
MM: Pesci gatto, cani albini, colombe bianche, pulcini, pavoni, anguille — perdonami, ma amo elencare — il tuo lavoro è costellato di animali…
PPC: Non posso parlarti direttamente dell’animalità. Posso solo dirti che sono in ascolto degli animali, delle cose, della stufa, del fuoco. Se non fosse così, il mio diventerebbe un lavoro barocco.
MM: L’elemento del bianco si ripete spesso: è legato al ghiaccio, agli animali albini…
PPC: L’animale albino è un fantasma: è sempre interessante, a livello di presenza spaziale, dell’imposizione psicologica a cui sottomette lo spettatore. Costituisce un’anomalia.
MM: Trovo molto affascinante nel tuo lavoro anche l’immagine del ghiaccio. Quando ti è venuta in mente l’immagine delle strutture che si ghiacciano?
PPC: La prima volta nel 1966. Insistevo in maniera un po’ ottusa a cercare di dipingere il marmo, cioè la luce che si rifletteva sul marmo bianco della chiesa di Riva degli Schiavoni. E nonostante insistessi, mi accorgevo che questa pittura era qualcosa di già superato dalla luce stessa. Mi sono posto dei problemi sul bianco, per anni, fino a quando ho visto a Venezia la galaverna: tutto gela, tutto brina, gli alberi sono saturati dal freddo. Le superfici della Giudecca, di solito rosse, sono ricoperte di acqua e di ghiaccio e con la luna diventano d’argento. Ho pensato che la brina fosse la testimonianza maggiore sul camuffamento e sullo svolgimento, se così si può dire, alchemico del bianco.
MM: Non percepisco fatica nel tuo creare, ma un senso classico. Non fai fare alla rosa quello che la rosa non vuole fare.
PPC: Hai detto una cosa fondamentale. A Pescara, nel 1965, alla Galleria Lucrezia de Domizio, mancava la luna; allora ho fatto una pozzanghera e ho messo un faro nella strada buia in modo che si riflettesse e diventasse la luna. Mi pongo in parità d’ascolto e di disponibilità nei confronti di tutte le entità. La rosa non può essere toccata perché va ascoltata.
MM: Il tuo lavoro è come un distillato di un immaginario molto complesso che si sedimenta lentamente. So che ami la letteratura russa e la poesia. Ti influenzano molto?
PPC: La tua è una lettura raffinata. Da cinque anni leggo pochissimo, però ho letto molto nel corso della mia vita. Leggo soprattutto quello che traduce la mia ultima moglie: poesie post belliche giapponesi. Ma non ricavo il mio lavoro leggendo un libro, o leggendo una poesia. La poesia però mi segue. Può essere interessante quando quello che leggi ti usura, ti insegue e magari dopo anni ti raggiunge. Un distillato c’è in questo senso.
MM: I titoli dei tuoi lavori sembrano poesie. “Quando un sognatore muore che ne è del sogno” è una frase tua o presa da una poesia?
PPC: Te lo dico in tutta onestà: io la considero mia. Però se dovessi essere sincero è probabile che sia arrivata a me distillata.
MM: Sei sonnambulo, Pier Paolo?
PPC: Sì, sono sonnambulo, non dormo tanto, non mi ricordo i sogni. Sicuramente sono pieno di sogni, ma non me li ricordo. Cambiano il mio modo di essere durante il giorno. Probabilmente non è una cosa scientifica, ma puramente empirica. Forse a tutti succede così. A volte cado.
MM: E di Documenta V e di “When Attitudes Become Form” curate da Harald Szeemann cosa mi puoi raccontare? Tu hai partecipato a quattro/cinque eventi fondamentali tra cui anche “Teatro delle Mostre”…
PPC: “When Attitudes Become Form” è una mostra molto importante. Sembrava più un suk. Era molto legata al contesto, al suo tempo. Per la distribuzione delle opere è stata una mostra tribale…
Alla parola “tribale” la registrazione si interrompe. Avrei potuto proseguire la conversazione per tutta la giornata… A Fossombrone non ci sono brine, ma sul torrente a strapiombo si riflette un tramonto, atmosferico come il lavoro di Pier Paolo.