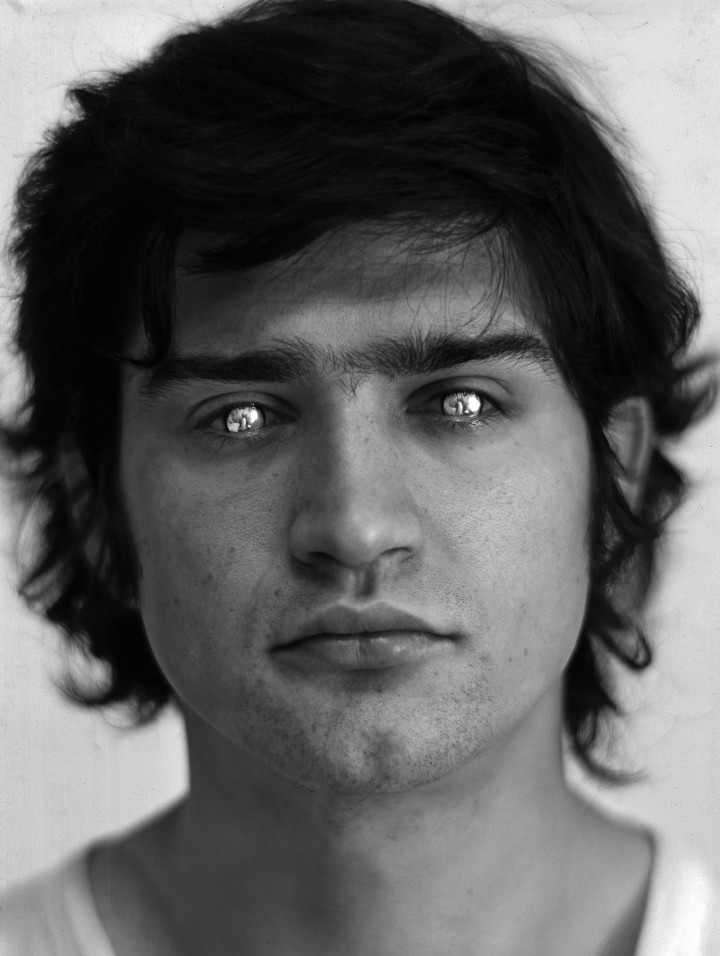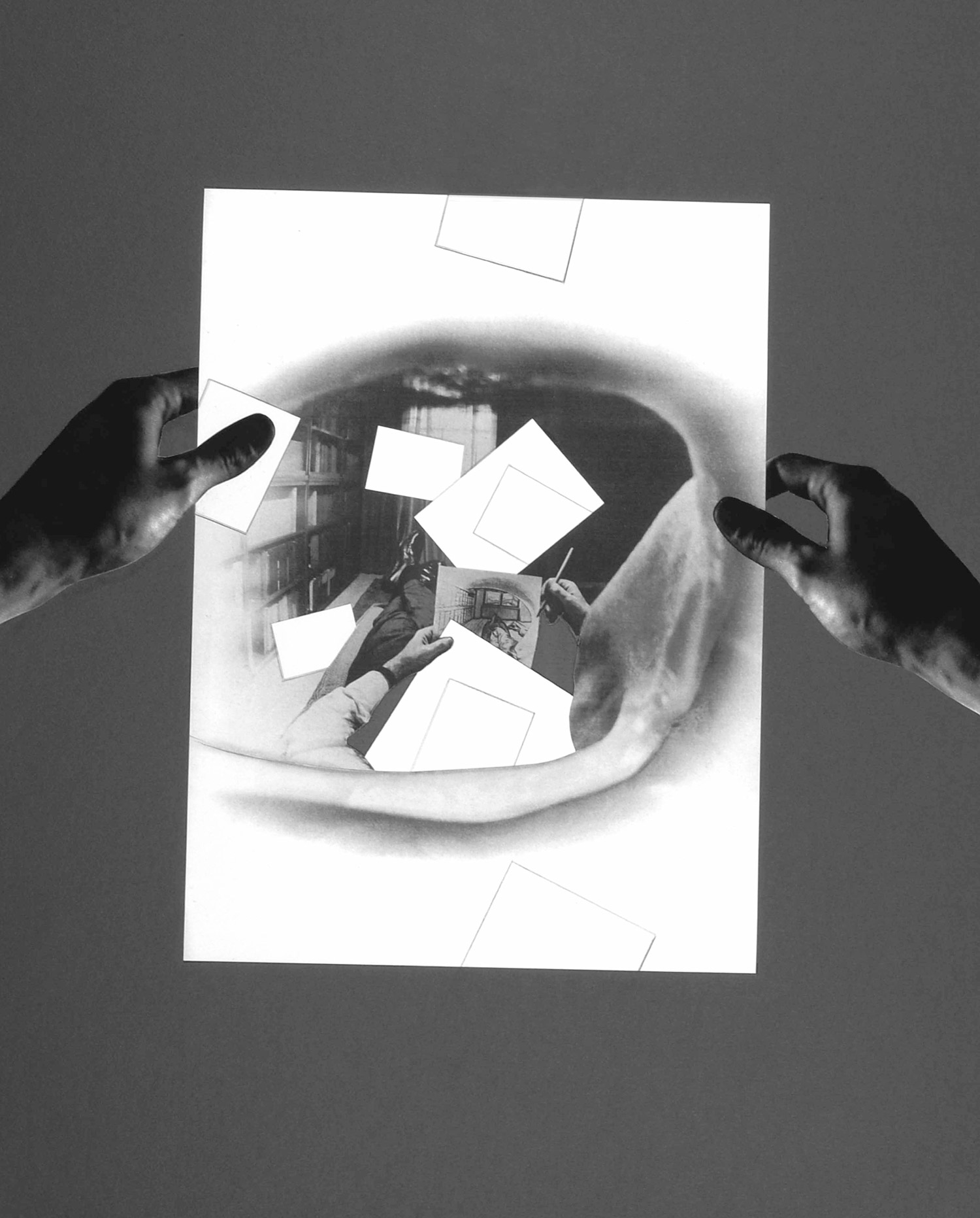Per quanto la constatazione appaia paradossale, il movimento artistico italiano più importante degli ultimi quarant’anni risulta anche il meno sistematicamente studiato nel nostro Paese. Non che ovviamente siano mancate le occasioni — mostre, cataloghi, libri ecc. — per mettere a fuoco personalità, temi, poetiche, e rileggere nel complesso la vicenda dell’Arte Povera. Numerose mostre (le retrospettive di Fabro nel 2007 e quella di Boetti, inauguratasi lo scorso febbraio al MADRE di Napoli, di Paolini alla Fondazione Prada nel 2003 e di Merz a Rivoli nel 2005, sono solo alcuni degli esempi recenti), hanno testimoniato la qualità e diversità di opere da tempo entrate stabilmente nel canone, certo non solo “italiano”, dell’arte del secondo Novecento.
Non si può tuttavia dar torto a Claire Gilman quando nota, introducendo un numero della rivista October dedicato all’arte italiana del dopoguerra, a che punto la ricezione dell’Arte Povera in Italia sia ancora in sostanza dominata dalle idee e dai testi di Germano Celant (i suoi più recenti, in particolare) e dalle posizioni ormai cristallizzate dei protagonisti di quella stagione. E quanto l’assenza di una rinnovata cognizione storica per esperienze tanto eterogenee quanto innovative come quelle del gruppo “poverista” determini non solo uno schiacciamento sul già noto, una ripetizione di luoghi obbligati e cliché sempre più inerti, ma anche, aggiungerei, una specie di assideramento, di distacco preventivo che impedisce l’attivazione di prospettive di senso diverse, di un rinnovato “valore d’uso”, come accade per esempio negli esercizi di ammirazione di Tacita Dean e Jonathan Monk nei confronti rispettivamente di Mario Merz e Alighiero Boetti. Così, se le letture dominanti in Italia hanno finito per consegnarci troppo spesso dell’Arte Povera un’immagine celebrativa e consolatoria — conformata di volta in volta su un’indeterminata “italianità”, su una idealizzante sensibilità archetipica, su una supposta intraducibilità metaforica —, anche solo per uno sguardo d’insieme alla vicenda del gruppo la risorsa obbligata resta il volume (in inglese) curato dieci anni fa da Carolyn Christov-Bakargiev per Phaidon, mentre per trovare nuove aperture, investigazioni o riflessioni originali bisogna rivolgersi decisamente al paesaggio oltre i confini italiani, per esempio alle ricerche di Stephen Bann, Nicholas Cullinan, Georges Didi-Huberman, Dieter Schwarz.

La mancata storicizzazione dell’Arte Povera in Italia è tuttavia di per sé un sintomo significativo, non causato solo da indolenza o dalla volontà, pure evidente, degli artisti di mantenere il controllo sulle vicende di cui sono stati protagonisti (fattore che ostacola, tra l’altro, la possibilità di valutare con maggiore imparzialità l’evoluzione dei loro percorsi). Essa è soprattutto la conseguenza della sostanziale rimozione delle originarie posizioni del gruppo nel panorama culturale degli anni Sessanta, del suo essere al tempo stesso profondamente radicato nella vicenda della modernità italiana — dal Futurismo al Neorealismo alle neoavanguardie — e di costituirne il punto di crisi irreversibile, di apertura e confluenza in un orizzonte ormai pienamente postmoderno. Lo sfondo rimosso dell’Arte Povera è in effetti quello delle città e del paesaggio in rapida trasformazione tra anni Cinquanta e Sessanta, l’epoca del boom, della crescita urbana, dell’industrializzazione, delle lotte che culmineranno nel ’68 studentesco e nell’“autunno caldo” operaio. Problematiche fondamentali della cultura italiana ed europea del tempo — il conflitto tra libertà individuali e collettive, tra tempo lungo della storia e immediatezza imposta dai meccanismi del consumo, tra spinta sovversiva ed evasione nella dimensione spettacolare — hanno nutrito lo straordinario sforzo di mobilitazione poetica poverista, la cui valenza politica spingeva agli inizi Celant stesso a parlare, nei toni infiammati tipici dell’epoca, di una strategia di “guerriglia” espressamente concepita per collocare il lavoro artistico dentro un più ampio processo di trasformazione del mondo reale e dei suoi rapporti di forza. Solo più tardi, negli anni Settanta, in concomitanza con la generale crisi dei movimenti libertari e l’involuzione terrorista degli anni di piombo, e più avanti ancora, a partire dalla mostra newyorkese “The Knot” del 1985, il critico diluirà e normalizzerà questa visione nei termini di quella riappropriazione elegiaca del passato, di quella sensibilità di volta in volta archeologica, malinconica, spiritualista, che ha largamente influenzato la lettura dell’Arte Povera sino ai nostri giorni.
Opere memorabili come le “Italie” di Luciano Fabro, la “motocicletta fantasma” di Accelerazione = sogno esposta da Mario Merz a documenta 5, o i cavalli di Jannis Kounellis all’Attico di Roma, la Palla di giornali di Michelangelo Pistoletto, le Torsioni di Giovanni Anselmo, Odio di Gilberto Zorio, raccontano in effetti una storia differente. Sottolineando la dialettica tra componenti materiali e immateriali, tra memoria e istantaneità, tra tempo ed entropia, rivendicando una relazione diversa tra ambiente e corpo, tra il pensiero concettuale e lo strato emotivo, tra spazio e temporalità, questi artisti respingevano l’idea modernista di purezza estetica in nome di una caparbia compromissione col mondo, di una povertà che muovendo dalle concezioni di Jerzy Grotowski acquistava la forza di una rivendicazione radicale. L’Arte Povera appare in questo senso interprete militante di una tradizione italiana, anzi più propriamente antitaliana (un’antitalianità vista qui come componente ineliminabile dell’italianità stessa), vale a dire l’eredità francescana, quell’aspirazione a uno sguardo radicalmente diverso, a una potente inversione di valori (viene in mente Rovesciare i propri occhi di Giuseppe Penone) in cui la povertà — come essenzialità, rigore, condivisione, mescolanza, rifiuto delle gerarchie, critica permanente del potere — rilegge la storia umana secondo l’asse di una rivoluzionaria esigenza di libertà e verità.

L’immersione nel mondo e nei suoi conflitti, in un presente in cui si condensano durata e memoria, diventa così il nutrimento essenziale della “potenza di ira” di esperienze artistiche che del va-e-vieni tra concentrazione e dispendio di energia — un processo in cui si riaffaccia l’idea di Bataille di dépense, come ha giustamente notato Rosalind Krauss — fanno il cardine di una strategia di sistematico rifiuto del compromesso con il corso “normale” delle cose. E non c’è forse esempio più significativo di questa aspirazione dell’opera di Alighiero Boetti, un artista che della perpetua dialettica tra ordine e disordine, tra caso e necessità, tra singolarità e moltitudine, ha fatto la dimensione specifica della sua esperienza. Permutare una cifra, percorrere una quadrettatura o il profilo di un continente, diventano così altrettanti modi di coniugare ironicamente vita e arte, gioco e immortalità: e forse in questo senso non c’è una sua opera più “terribile” dei telegrammi riuniti sotto il titolo interminabile Serie di merli disposti a intervalli regolari lungo gli spalti di una muraglia, un work in progress fondato sulla ripetizione ossessiva di una data da cui ci si allontana progressivamente (2, 4, 8, 16, 32… giorni fa), fino all’ultimo spazio, rimasto vuoto: infallibile profezia di morte e imperfetto, troppo umano baluardo posto di fronte al nulla.
Rivoltandosi contro il dispotico feticismo delle merci, intensificando la relazione con la durata e la profondità temporale radicata nei materiali e nei processi, esplorando simultaneamente gli estremi della crescita infinita e del repentino annullamento, l’Arte Povera ha insieme dato un contributo fondamentale alla ridefinizione dello spazio di libertà soggettiva dell’arte dopo il modernismo e ha offerto una possibilità di rileggere a partire dal presente l’eredità storica e culturale italiana, riassegnandole quella capacità di profezia, di rivelazione attuale, necessaria a rimanere vitale. Restituire al lavoro degli artisti la sua originaria politicità e forza conflittuale è un passaggio indispensabile per ritrovare il valore di una vicenda che, lungi dal rimanere confinata in decenni ormai lontani, non smette di interrogarci con la sua intransigente differenza.