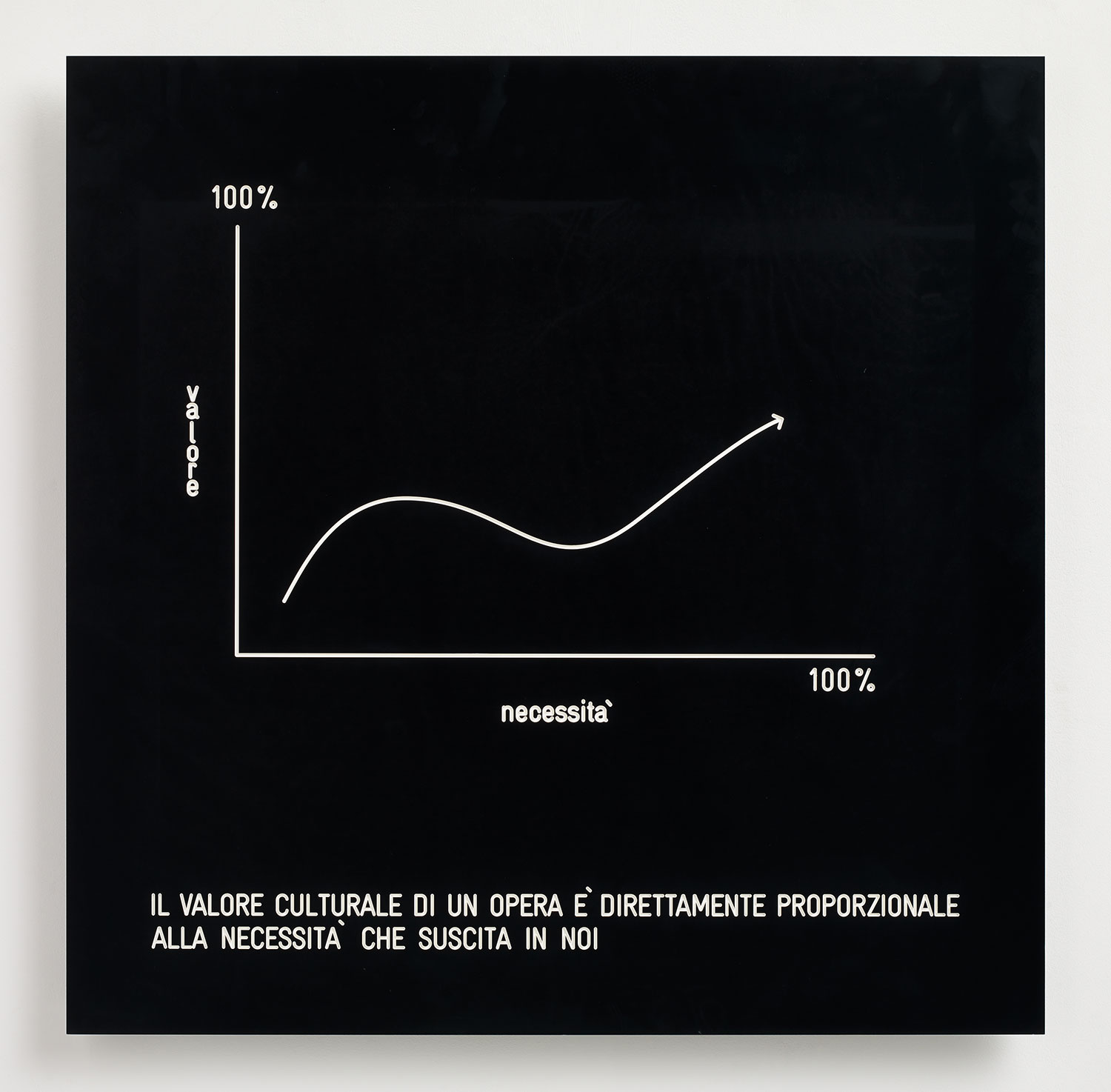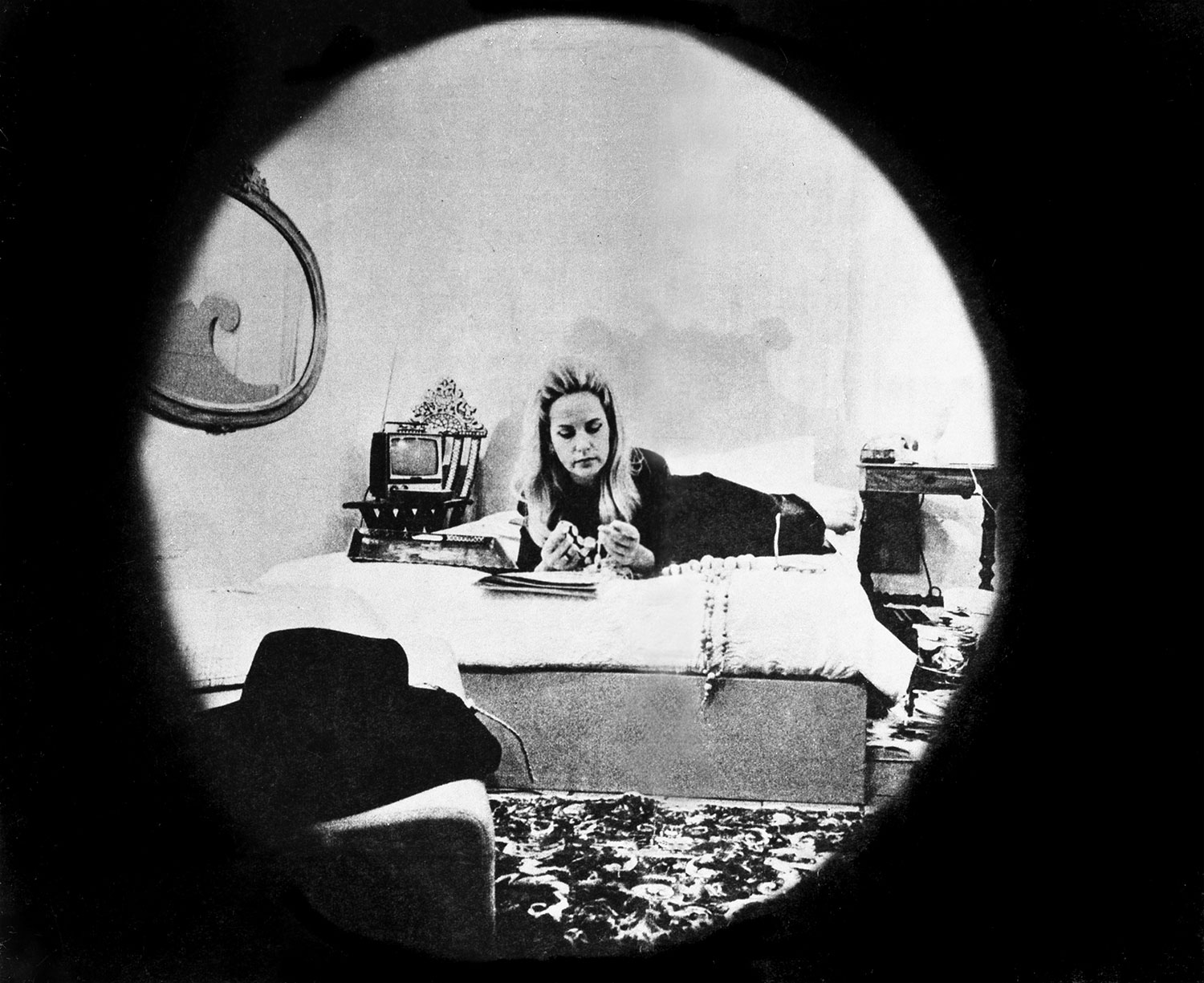Roberto Cuoghi (Modena, 1973) non è un artista autodidatta e la sua formazione non è il frutto di un percorso solitario. Ha infatti conseguito il diploma dell’Accademia di Belle Arti di Brera nel 2001, benché lui stesso ci ricordi di aver avuto una carriera scolastica tormentata, segnata da diffidenze, opposizioni, e battute d’arresto[1]. Tuttavia l’autodidattismo, vale a dire “l’azione di apprendere senza un maestro”, sembra essere la chiave essenziale per comprendere la sua opera. Quel che colpisce in questi vent’anni di lavoro trascorsi dal suo passaggio in una scuola d’arte, è l’ostinazione con cui Cuoghi ha sviluppato tutti i suoi progetti, quasi come un grande salto nell’ignoto. In realtà, che siano Il coccodeista (1997), The Goodgriefies (2000), le Mappe e i Quadri Neri (a partire dal 2002), o la serie delle opere sonore Mbube (2005), Mei Gui (2006) e Šuillakku (2008-10), o magari le sculture più recenti della serie dei Pazuzu, è sorprendente constatare come ciascun progetto abbia richiesto all’artista lunghe e minuziose ricerche, e l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze che il più delle volte oltrepassavano la propria cultura e il proprio vissuto. Nel corso della nostra riflessione, viene quindi da chiedersi: che cosa spinge Cuoghi a mettere in gioco la sua esperienza e i suoi saperi in un processo creativo che vede rinnovare costantemente metodologie e motivazioni?
Se la figura dell’autodidatta ha per lungo tempo suscitato riserve e nutrito il mito dell’individuo isolato, in lotta con il sistema, oggi è invece oggetto di studi specifici nel campo delle scienze dell’educazione e delle scienze cognitive. Sorretto dalla ricerca identitaria e dalla realizzazione di sé, l’autodidattismo – che rimanda al concetto generale di apprendimento autonomo – è ormai considerato una risorsa preziosa. Gli si riconosce una dimensione emancipativa, una capacità di adattamento alle trasformazioni del nostro ambiente (nella quotidianità o in circostanze difficili), e una funzione creativa allorché il discente si avventura in una terra incognita[2]. In quanto modalità di apprendimento che si attua attraverso la pratica e l’esperienza, l’autodidattismo non è mai stato oggetto di uno studio approfondito nel campo dell’arte[3] – un autentico paradosso se pensiamo che da un artista contemporaneo in genere ci si attende un gesto di rottura con la tradizione, o quantomeno una ricerca personalissima delle risorse necessarie al rinnovamento del linguaggio dell’arte. Qualunque approccio innovativo sembrerebbe quindi costituito da momenti e da gesti autodidattici. Nel caso di Cuoghi, possiamo affermare con decisione che l’autodidattismo non è soltanto un elemento costitutivo del suo processo creativo, ma ne è anche il motore e la ragione d’essere.
Prima di addentrarci in un’analisi più approfondita di questo processo creativo, è bene osservare come l’artista non si è mai riferito esplicitamente all’autodidattismo e non l’ha mai posto come scopo del suo lavoro. Analogamente, egli non condivide la tendenza comune a molti artisti contemporanei di atteggiarsi ad amatore, dilettante, o a pittore della domenica. Il suo approccio si potrebbe collocare sul versante della pura ricerca, ovvero nell’intraprendere ogni sorta di sperimentazione con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze su fenomeni o fatti osservabili, senza per questo dover prevedere una qualche particolare applicazione. Ciò risulta particolarmente evidente nel suo primo progetto, Il coccodeista. Sappiamo che l’artista ha voluto indossare degli occhiali con dei prismi in vetro (usati abitualmente per i telescopi) al fine di testare la capacità di adattamento e di risposta del suo cervello a una visione invertita – dall’alto in basso, da sinistra a destra – e al restringimento drastico del campo visivo che queste lenti comportavano. Nonostante quest’esperienza sia stata per l’artista un fallimento e una dolorosa prova sensoriale e fisica durata parecchi giorni, ne risulta un certo numero di disegni e di testi. Questa sperimentazione, ci dice Cuoghi, non è stata concepita con l’intenzione di produrre artefatti o come performance in sé. L’artista, provato dalla privazione sensoriale, assegnava a quei disegni e a quei testi che ne costituiscono le tracce, una funzione terapeutica: la loro realizzazione rappresentava “il momento più tranquillo della giornata”[4]. La “lentezza insolita” dell’esecuzione e il sintetismo che li contraddistinguono conferiscono loro una “qualità speciale” che l’ha convinto, a posteriori, a conservarli. La serie delle Mappe deriva da questa stessa logica esperienziale: disegnare il planisfero “senza riferimenti e andando a memoria”. I tracciati eseguiti sulle diverse lastre di vetro sovrapposte permettono all’artista di correggere gli errori e al contempo di far apparire le diverse fasi di realizzazione del processo. Le sostanze utilizzate sono anch’esse oggetto di sperimentazione: pigmenti neri mescolati con alcol e sali al fine di ottenere diversi effetti ottici dovuti alle differenti modalità di cristallizzazione ed evaporazione, e che sono poi amplificati dalla sovrapposizione di uno o più strati di vetro.
Queste sperimentazioni pratiche e materiali si ritrovano nella maggior parte delle opere di Cuoghi: eseguire un cartone animato senza alcuna conoscenza di tecniche di animazione (The Goodgriefies); comporre canti senza alcun bagaglio musicale (Mbube; Mei Gui; Šuillakku); realizzare sculture con una stampante 3D (la serie Putiferio). Altri artisti avrebbero avuto il riflesso condizionato di delegare la produzione a degli artigiani o a dei tecnici specializzati. Cuoghi, al contrario, si ostina a imparare da solo i vari procedimenti[5]. Una modalità di lavoro che richiede di fatto moltissimi mesi, se non anni di intenso apprendimento. Si ritrova in questo approccio un eroismo che ricorda quello dei bricoleur più appassionati, il loro sforzo di venire a capo delle difficoltà, malgrado ogni sorta di ostacoli. Ma si tratta anche e soprattutto di affermare un’autonomia totale nel processo creativo. Basterebbe visitare una volta il suo atelier ubicato in un vecchio magazzino alimentare alla periferia di Milano per rendersene conto[6]. Tutto è stato pensato in modo da portare a termine qualunque tipo di compito senza dover ricorrere ad alcun aiuto esterno. Ci sono due spazi per la fase di lavorazione e modellatura, parecchi forni da cottura di grandi dimensioni, un laboratorio chimico, uno studio multimediale, una cucina, e un magazzino, il tutto messo su dall’artista nel corso degli anni con l’aiuto di Alessandra Sofia e Nicoletta Di Rosa, sue collaboratrici e compagne di vita. Insieme, i tre formano una piccola comunità fusionale che si distingue per la sua autosufficenza, senza peraltro fare di questo una bandiera. Alessandra e Nicoletta partecipano pienamente al processo lavorativo eseguendo ricerche teoriche e pratiche. Alcuni compiti invece sono delegati e ripartiti con precisione: l’una è incaricata di occuparsi di diverse operazioni tecniche, l’altra gestisce tutta la parte della comunicazione con il mondo esterno e con l’ambiente artistico professionale.

Il desiderio di Cuoghi di darsi regole e modalità di funzionamento proprie si ritrova anche nella scelta deliberata di non avvalersi di strumenti abituali o scontati. Non possedendo un computer, si trova costretto per la realizzazione del cartone animato The Goodgriefies, ad acquistarne uno, come pure una tavoletta grafica. Inaspettatamente, sceglie di imparare a utilizzare il programma Flash, che in seguito si rivelerà poco adatto all’animazione, i cui limiti però lo attraggono perché gli permettono di mettersi continuamente alla prova nel tentativo di superarli. Sulla stessa scia ha modificato, per le sue ultime produzioni, il sistema di utilizzo di una stampante 3D sostituendo con dell’argilla il materiale plastico necessario alla tecnica di modellazione per deposizione fusa (Fused Deposition Modeling). Dopo vari tentativi alla cieca, riesce a fabbricare con questa macchina degli oggetti in ceramica aggiungendo ai meccanismi una serie di strumenti che normalmente vengono impiegati in ambito medico (siringhe, nebulizzatori). Questo utilizzo, che potremmo definire improprio, non si limita ad agire su di un piano materiale. Lo ritroviamo infatti anche nella scelta dei temi e nel modo di rappresentarli. La produzione di The Goodgriefies, ad esempio, è motivata dal desiderio di trasformare i personaggi iconici dei cartoni animati nel loro assurdo opposto: vecchi invalidi costretti a letto, o con deformità fisiche indicibili[7]. Quando Cuoghi decide di accostarsi alla musica, lo fa scegliendo canti originari di altre zone ed epoche culturali, in particolare del Sudafrica Zulu degli anni Quaranta (Mbube), della Shanghai prima della rivoluzione maoista (Mei Gui), con caratteristiche melodiche, strumentali, e vocali ben precise. Le sue rivisitazioni sono composte con strumenti scelti per le loro somiglianze acustiche, quando non del tutto inventati dall’artista. Per i canti, invece, imita le parole senza capirne il senso, impegnandosi nell’esercizio di modulazione della sua stessa tessitura vocale. A prima vista l’impresa parrebbe quella di un amatore che si diletta a rifare le sue arie preferite, ma in realtà la differenza sta nei mezzi e nei risultati: siamo di fronte a oggetti sonori che non somigliano a niente di conosciuto.
Cuoghi descrive il suo procedimento di composizione sonora come “un’improvvisazione dilatata nel tempo”. E aggiunge: “Io utilizzo una competenza che non ho, non so fare nulla di quello che faccio, e quindi mi vedo costretto a ripeterlo centinaia di volte. Quando sono sul punto di aver imparato, allora, il mio lavoro è finito. È una forma di privilegio non avere un’educazione specifica, è un metodo che obbliga a immaginare tutto”[8]. Molti aspetti di questa dichiarazione fanno luce sul processo di lavoro dell’artista e confermano fino a che punto l’autodidattismo costituisca la spina dorsale della sua praxis. Si ritrovano alcune delle sue caratteristiche più emblematiche: la volontà di imparare da soli; la messa in atto di gesti di apprendimento elementari (alla ripetizione, qui menzionata, va aggiunto il metodo empirico per tentativi ed errori, o ancora l’imitazione di modelli preesistenti – operazioni volutamente percettibili nelle opere di Cuoghi); il carattere poco rigoroso e razionale del metodo; la necessità di innovare e di attivare l’immaginazione quando ci si misura con l’ignoto.
Per lungo tempo agli autodidatti è stato rimproverato “l’eclettismo” del loro sapere, che verrebbe così svalutato rispetto a quello degli esperti[9]. E in effetti, l’estrema diversità dei temi toccati dall’artista, la volontà di rompere con i suoi stessi saperi acquisiti, le appropriazioni di elementi esogeni alla propria cultura, il fatto di metterli in relazione in modo quantomeno eterodosso, gli usi impropri ecc., farebbero venire il capogiro a qualunque specialista. Tutto ciò ben chiarisce la serie di operazioni pragmatiche e mentali che l’autodidatta materializza nel suo processo di creazione. Lo stesso dicasi del ragionamento per analogia che sembrerebbe avere un posto preminente nel lavoro di Cuoghi. Secondo Emmanuel Sander, autore di molti saggi sul funzionamento del pensiero analogico, questo consisterebbe nell’utilizzo di “conoscenze acquisite su determinati fenomeni o situazioni per poi applicarle ad altri fenomeni al fine di comprenderli, o ad altre situazioni per agire su di esse, sulla base di percezioni similari ma senza avere la certezza che appartengano alla stessa categoria e siano quindi pertinenti”[10]. È per analogia che l’artista inventa strumenti per riprodurre i suoni dei canti che intende imitare, o si mette in testa di realizzare con una stampante 3D delle sculture in ceramica stabilendo un parallelo azzardato tra il modo di concrezione della plastica e quello dell’argilla. A lungo criticato, questo modo di pensare, implicito e intuitivo, conosce oggi i favori delle scienze cognitive che ne riconoscono la centralità nei processi di costruzione cognitiva e di espressione di sé, e ne celebrano il ruolo nella produzione di innovazioni e di scoperte scientifiche maggiori[11]. In Cuoghi, le “improvvisazioni” e gli utilizzi impropri dovuti alle associazioni per analogia, costituiscono le basi di un protocollo informale che gli permettono di contravvenire alle normali regole d’uso e di stabilire un contesto esperienziale del tutto nuovo. I progressi tortuosi e i ritrovamenti inediti generati dalle analogie sono connessi all’obiettivo di “scoperta”, allo “spirito di avventura”. L’artista prosegue: “Quando il risultato coincide con l’idea iniziale, allora è la morte”. Per evitare un tale disappunto, egli ha bisogno di “fare qualcosa in modo smisurato, […] per non vedere più le cose alla loro giusta distanza, [per] perdere il senso delle proporzioni e abbandonare la strada”. Il suo apprendimento senza maestro né istruzioni è una scelta riflessiva volta a rimettere in questione i “modelli” e le “norme” stabilite. Giacché solo abbandonando la strada degli usi, delle tradizioni, dei riflessi condizionati, egli può nutrire la speranza di creare un “nuovo standard”, un “cambiamento dei canoni”.

Le appropriazioni sono il secondo aspetto fondamentale della pratica da autodidatta di Cuoghi. Queste assimilazioni, numerose e ardite, di temi e competenze che non appartengono né alla sua cultura né al suo vissuto, sono particolarmente evidenti nelle sue ultime opere legate alle ricerche sulla civiltà assira. Nel lungo colloquio con Andrea Viliani, in cui descrive minuziosamente il processo titanico per la realizzazione di Šuillakku, creazione ex novo di una lamentazione (con coro e orchestra) del popolo assiro afflitto per la distruzione della capitale Ninive, Cuoghi ritorna sulla legittimità di creare canti e rituali di una civiltà scomparsa a partire da esigui reperti storici, archeologici e linguistici: “L’idea di una lamentazione è sorta dall’impossibilità di avere un riferimento, e se anche fosse esistito un canto funebre per la rovina di Ninive, non ne sarebbe comunque rimasta traccia, dal momento che fu un assoluto genocidio”[12]. Con l’intento di scrivere ed eseguire lui stesso gli elementi rituali e la partitura musicale della lamentazione, Cuoghi va alla ricerca di tutte le rare tracce ed evocazioni della musica di quell’epoca. Riprende così alcune formule incantatorie della raccolta contro i demoni Utukkū Lemnūtu; compone espressamente una melodia sulla suggestione di letture della musica microtonale assira e delle melodie a intervallo unico di stampo ebraico; ricostruisce strumenti (corni d’antilope e di montone, trombe, flauti di canna, lire) visti sui bassorilievi o trovati nelle tombe, e si ispira per la struttura esecutiva alla sequenza di strumenti elencati nel Libro di Daniele dell’Antico Testamento. Quando scarseggia di informazioni, abbandona il metodo dell’archeologo sperimentale e inventa allora la pronuncia per la recitazione nelle lingue (morte) accadica e sumera, ispirandosi alle convenzioni dell’ebraico e dell’arabo antico; e ricorre a strumenti appartenenti ad altre culture (Etiopia, Tibet, Estremo Oriente) aggiungendone di più contemporanei o di sua invenzione (piano sintetizzatore per le modulazioni, nacchere e sonagli fatti di conchiglie o di foglie). Infine per la strutturazione tematica, sceglie di seguire le diverse fasi di elaborazione psicologica dell’esperienza della morte descritte nei manuali di assistenza ai malati terminali.
La libertà e l’impertinenza con cui Cuoghi raccoglie e trasforma fonti e riferimenti di ogni genere nella sua opera, ci permette di precisare meglio ciò che intendiamo per “appropriazione”. Non si tratta, qui, di una pratica di copia o di citazione – strategie spesso utilizzate nell’arte contemporanea. I prestiti di Cuoghi sembrerebbero più prossimi alle logiche di ibridazione e di sincretismo che informano le pratiche culturali globalizzate. Nel suo plebiscito per una definizione dell’appropriazione culturale quale procedimento ermeneutico individuale, l’antropologo Anrd Schneider sottolinea fino a che punto l’“appropriazione” (dall’etimologia “fare proprio”, derivante dal tardo latino proprius, “proprio, personale”) di elementi culturali estranei, implica un processo specifico di conoscenza e di costruzione del sé, che va in senso opposto alle rappresentazioni teoriche abituali che attribuiscono all’appropriazione il marchio dell’usurpazione e dell’inautenticità. Basando la sua riflessione sul pensiero del filosofo Paul Ricoeur, egli sottolinea come l’appropriazione di ciò che ci è estraneo sarebbe una “pratica e un’esperienza di apprendimento” le cui proprietà trasformative implicherebbero “uno spossessamento del proprio ego narcisistico per poter generare non soltanto un’affinità con l’altro ma una nuova comprensione del sé”[13]. Questa dimensione trasformativa non riguarda soltanto il senso degli elementi culturali assimilati, ma è anche un procedimento ermeneutico che modifica lo stesso ethos di colui che se ne appropria. Roberto Cuoghi non è diventato semplicemente uno specialista autodidatta ed eccentrico della cultura mesopotamica, passione che sfocia ancora nella più recente produzione di sculture della figura di Pazuzu, il demone dell’antica Mesopotamia. La sua esperienza megalomane ed eterodossa di composizione ed esecuzione, vissuta in prima persona e per parecchi anni, di quel che sarebbe il canto del cigno di un’intera civiltà, ci sembra motivata dalla volontà di provare intimamente, se così si può dire, la finitudine e l’oblio che incombe su qualunque impresa umana[14]. I rifacimenti dei canti zulu e cinesi derivano dalla stessa motivazione: quella di “rendere giustizia” alle “cose dimenticate, svilite, […] di farne qualcosa di sproporzionato e notevole”. L’appropriazione in questo caso prende le mosse da un’etica che si esprime nel modo dell’assimilazione – un processo di ricerca lungo e intenso di dati storici – e in un’identificazione tanto morale quanto fisica[15].
Come uno Zelig contemporaneo[16], l’identità di Cuoghi muta ad ogni nuovo progetto. Oltre all’eclettismo dei saperi, all’autodidatta viene rimproverata anche l’identità composita[17]. Lo “spossessamento” citato prima da Schneider, che Paul Ricoeur associa a un gesto di “rinuncia”, “momento fondamentale dell’appropriazione, che la distingue da ogni altra forma di ‘presa di possesso’”[18], ne costituisce il punto culminante e il passaggio obbligato sulla via della conoscenza degli altri e di sé. Al fine di rendere giustizia, l’artista non si accontenta di citare o prendere in prestito, piuttosto tributa il suo omaggio mediante la trasformazione e l’eccesso. L’ascolto delle sue composizioni sonore atipiche, che egli ha cura di diffondere in vari luoghi per spazializzare le voci e i suoni in ambienti espositivi assolutamente privi di qualunque riferimento visivo, costituisce l’apice di un’esperienza intensa e sconcertante di straniamento, che l’artista ci invita a provare, e che non sarà possibile dimenticare.