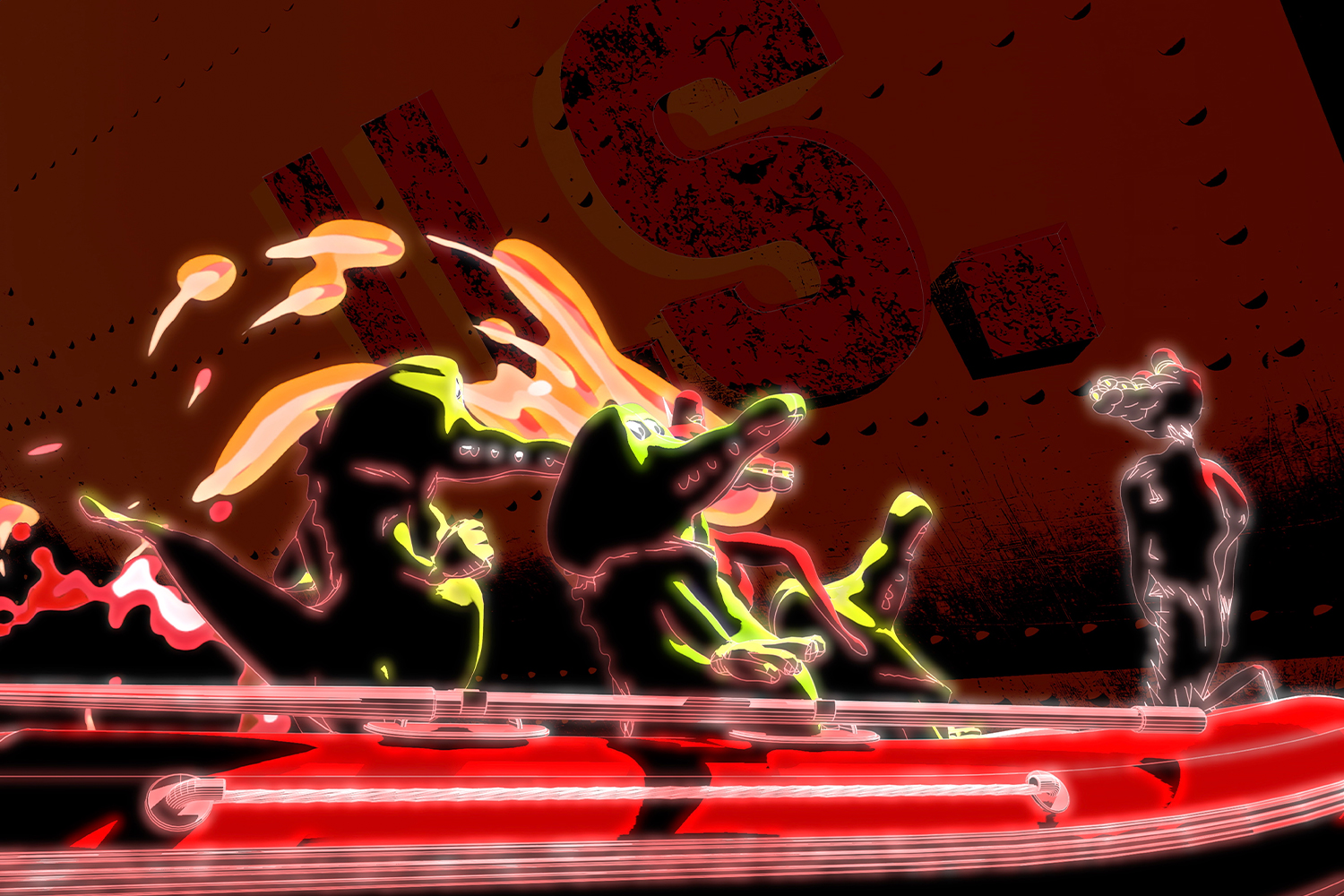Il percorso espositivo della collettiva “Role Play” negli spazi di Osservatorio Fondazione Prada, sembra riecheggiare il sistema neuronale di una silente creatura acquatica, un grande polpo occhiuto i cui centri cognitivi, disseminati a miliardi lungo le membra tentacolari, brillano ad intermittenza nel buio, diramando segnali elettronici. Varcando la soglia espositiva si ha l’impressione di sostare in un anomalo acquario colonizzato da immagini, nel senso più ampio del termine. Sugli interni della cupola mengoniana, solitamente luminosi, cala una luce bluastra omogenea che si incolla al visitatore come una pece computazionale, alterandone la percezione – orientarsi nei fondali degli oceani percorsi dalle serpentine che trasportano miliardi di immagini digitali, non sembra costituire un’esperienza tanto dissimile. Invece “Role Play”, che sulla costruzione metamorfica, disorientante e sovversiva dell’identità istituisce il proprio lemma – non solo teoretico, bensì propriamente spaziale – fornisce così il primo indizio per carpirne il funzionamento. Il display espositivo, progettato da Random Studio rappresenta una simulazione, un avatar architettonico che l’Osservatorio veste come una maschera, indossando un esoscheletro formato da pannelli oscuranti, proiettori ed elementi separatori. La luce bluastra diffusa impregna lo spazio circostante, rendendo l’intero percorso un ecosistema palpitante, un network ipermediale in cui immagini si manifestano, agiscono e poi retrocedono. Tuttavia, il respiro lento, ritmico e per certi versi rassicurante dell’eco-mostra ci avverte che la creatura che ci osserva, lungi dall’essere zoomorfa, è un pervasivo apparato tecnologico. Brancoliamo tra gli ingranaggi del dispositivo, in un turbinare di pixel e bit. L’emissione di luce nella banda blu assolve in realtà a una funzione tecnica piuttosto precisa: quello di rendere ai nostri occhi le immagini il più nitide possibile. E qui veniamo alla seconda questione che la mostra pare affrontare.
In linea con le ricerche condotte da Osservatorio, “Role Play” insistente fortemente, anzitutto sul piano teorico, sulla temporalità complessa del linguaggio fotografico. Dinnanzi a una sua presunta democratizzazione, ibridazione e quasi nullificazione nell’imagosfera contemporanea, il tema delle origini tecniche della fotografia si impone con forza. Una dialettica che sembrerebbe costituire il comune denominatore di un progetto labirintico, che stordisce per il flusso di personalità con cui il visitatore è chiamato a interagire. Ovvero la condizione spettrale della fotografia, il suo partecipare ai meccanismi della messe in scena, a una indessicalità fittizia mossa dal desiderio di re-immaginare l’identità che il medium fotografico aveva estesamente sperimentato sin dalla sua invenzione ottocentesca. Adottando strategie eterogenee gli spettri-avatar degli undici artisti selezionati dalla curatrice Melissa Harris partecipano a un agognato tentativo di risveglio.
I cosplayers filmici di Cao Fei invadono violentemente il reale nel tentativo di resistergli; la critica di una pratica sociale si attualizza nella sperimentazione ossessiva di una posa e di un’inquadratura avviata da Tomoko Sawada, che reinventa di continuo la propria esteriorità; lo scontro tra immagine stereotipata e immagine del sé ritma il montaggio alternato Typecast Porject (2019) di Haruka Sakaguchi e Griselda San Martin che espone le profonde contraddizioni razziali del cinema hollywoodiano. Ad un ordine differente partecipano gli screen-shot di Darius Mikšys che indagano la manipolazione dei comportamenti in ambiente videoludico, mentre le voci artificiali della simulazione tecnologica di Bogosi Sekhukhuni interrogano potentemente il funzionamento dell’empatia nella comunicazione virtuale. L’auto-rappresentazione detiene nel contesto espositivo un ruolo nevralgico. In una dimensione seducentemente distopica si pongono le emanazioni di Juno Calypso, la cui impeccabile tecnica fotografica riecheggia la veste criogenica del bunker-boudoir di Las Vegas che l’artista occupa temporaneamente. Il modulo della griglia di Instagram si spazializza in una matrice espositiva in cui la performer Amalia Ulman negozia la trasformazione dell’immagine corporea, dissimulandola, all’azione delle sfere estetiche del social network. Bassa definizione, subcultura e animazione dell’inanimato implodono in Guided Tour of a Spill (CAPS Interlude) (2021), installazione video di Meriem Bennani, mentre Katie Fox, doppelgänger di Beatrice Marchi, scopre il senso di colpa nell’inseguimento agonistico con un carapace parlante. Dall’universo personale, che deborda e goccia in una costellazione di figure, la fotografia invade lo spazio pubblico, diviene occhio in movimento della flâneuse Narcissister che conquista una propria cartografia, mostrando i seni di un corpo femminile fattosi collettivo ed insieme sovversivamente identitario grazie a maschera e parrucca. Il coro di voci in Rape of Europe (2021), cantate da Mary Reid Kelley, rivendica una e polifonica e ditirambica storia femminile. Il brusco risveglio, verrebbe da dire, è appena iniziato. Il quieto polpo neuronale ci restituisce lo sguardo e noi ci specchiamo nel suo ventre lucido: fantasma tra spettri, il selfie negli schermi del display.