Pubblicato originariamente su Flash Art Italia 307 Dicembre-Gennaio 2023
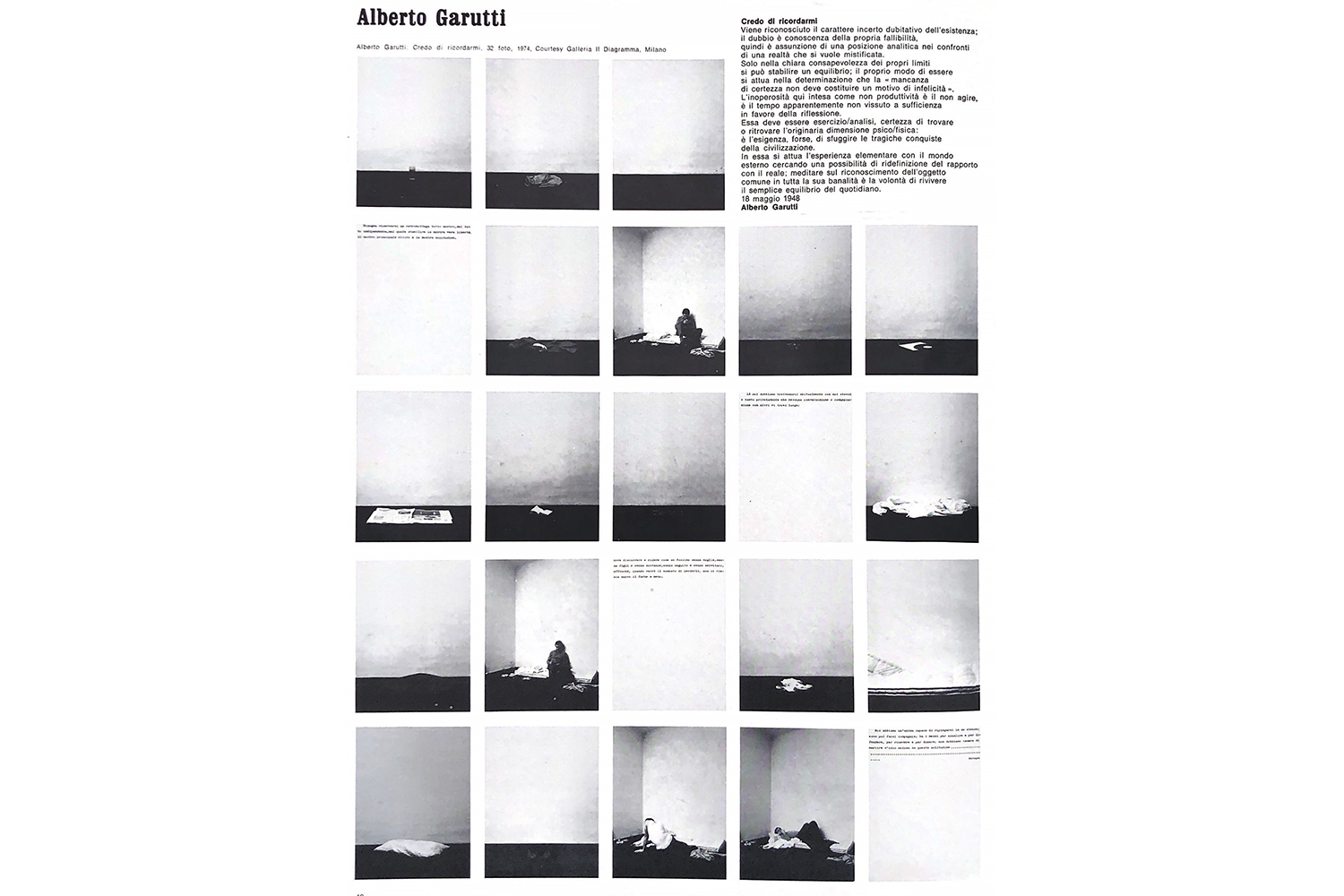
Maurizio Cattelan: Ti ricordi di me come tuo allievo?
Alberto Garutti: Maurizio, ma non sei stato mio allievo! In ogni caso, anche se lo fossi stato, me ne sarei dimenticato. Perché la figura di “allievo” non mi piace, tendo a rigettarla… E tanto meno mi piace la figura del docente. A me interessa che le persone si incontrino sul terreno comune dell’opera, con tutte le problematiche che quella posizione implica. Nei miei corsi tento di fare tutto ciò che generalmente si fa fuori dall’aula, nel sistema dell’arte, dove si guarda alle opere come a cose concrete. Ovviamente, sento la responsabilità insita nel carattere istituzionale del mio ruolo. Ma la mia posizione critica nei confronti della dinamica docente/allievo crea delle differenze… Penso infatti che l’arte sia “ininsegnabile”. È piuttosto una questione di metodo: lavoro sull’emotività, tentando di rimuovere le incrostazioni culturali e attivare un senso critico dell’opera.
MC: Spettatore, spettatrice: qual è il sesso di chi guarda?
AG: Potremmo affermare che l’occhio dello spettatore non ha sesso, ma sarebbe troppo semplicistico. C’è invece una differenza tra lo sguardo maschile e quello femminile, che tuttavia non so spiegare; sento però che le donne sanno qualcosa che noi uomini non sappiamo. Questa bellissima domanda mi confonde e mi fa pensare che ci sono anche spettatori che non sono esseri umani. Mi torna alla memoria uno scritto di Jorge Luis Borges, in cui l’autore racconta come l’occhio enigmatico di un cavallo dia senso a un angolo di rudere ricoperto di sterpaglie; mi ha sempre incuriosito sapere cosa guardi un animale vedendo una cosa che anch’io vedo…
MC: Che cosa speri che le persone imparino dai tuoi lavori?
AG: È un problema questo che non mi pongo, perché quando faccio un’opera sono piuttosto proteso a “capire”. Realizzare un’opera è per me un’esperienza conoscitiva, come immagino sia il proprio lavoro per uno scienziato o un ingegnere. A me interessa che le persone si accoppino! Che nascano storie d’amore! Può sembrare che voglia cavarmela con una battuta, ma non è così… Credo che tutto ciò che facciamo abbia a che fare con la conservazione della specie, con questo processo fondamentalmente inspiegabile, misterioso. Credo infatti che l’arte, così come la politica e l’economia, abbia molto a che fare con la biologia.
MC: Perché non hai mai fatto una rivista?
AG: Non ho mai fatto un libro, figuriamoci una rivista…
MC: L’arte ha delle responsabilità?
AG: Se penso all’arte, tralasciando il fatto che essa è “tautologicamente” ciò che noi consideriamo tale, rispondo che non ha responsabilità. Anzi: l’arte è sempre un progetto positivo, perché produce con le sue qualità estetiche delle spinte etiche rigeneranti — come è rigenerante la natura. Del resto non ho mai pensato che un albero avesse delle responsabilità! Semmai, la domanda è se ad avere delle responsabilità devono essere gli artisti e coloro che gestiscono il loro lavoro e lo comunicano. In questo caso risponderei che l’arte non ha delle responsabilità ma forse gli artisti sì… Anche se percepisco come un disagio l’eventualità che all’artista venga tolta la libertà di non essere considerato tale.
MC: Descrivi il tuo guardaroba?
AG: Abiti di mio padre, suocero, vecchio signore, che indossavo già trent’anni fa. Li conservo tutti. Nel soffitto di casa, potrei metterci un mese per descriverteli.
MC: Con quale oggetto non potresti vivere senza?
AG: Potrei fantasticare risposte sorprendenti, ma per non farla troppo lunga ti direi che un oggetto a cui non potrei rinunciare è il mio smartphone.
MC: Che cosa ti fa paura della pensione?
AG: Come faccio ad andare in pensione se non ho mai lavorato? Fare l’artista non è esattamente un lavoro. Mi sono appassionato a quello che faccio senza mai pensare che fosse un’occupazione vera e propria. Oltretutto, sappiamo che gran parte del lavoro è demandato ad altri e che quindi si tratta di un processo di regia, di un’operazione collettiva nella quale diversi attori sono incaricati di realizzare ciò che noi chiamiamo opera. Poi, se penso al mio incarico di docente, so con certezza che mi dispiacerà rinunciare all’incontro con i più giovani…
MC: Che rapporto hai con il tuo studio?
AG: È lo stesso rapporto che ho con la mia casa in campagna: raccogliere la legna, riparare la recinzione, dar da mangiare agli asini, potare gli alberi, tagliare il prato… Lo studio è il luogo ameno, dove faccio cose pratiche.
Il vero studio però è l’automobile: qui nascono le idee delle opere, qui mi concentro davvero. Quando guido non sono in un luogo, e questo forse facilita la libertà del pensiero. Se fossi un pittore tradizionale starei in un posto a dipingere. Ma il mio lavoro si dilata nello spazio. Penso sempre ai lavori che devo fare e alla loro programmazione, la notte soprattutto. Durante il giorno mi attivo per mettermi in relazione con tutte le persone che collaborano alla realizzazione dell’opera, come un regista insomma. In studio alla fine non ci sto mai.
MC: Perché Milano?
AG: I miei mi hanno portato qui quando ero bambino. Città che a me piace molto, unica dal punto di vista dell’organizzazione urbanistica, forse la sola città in Italia monocentrica, a struttura radiale, dove tutte le strade principali portano al centro. E poi c’è questo impianto neoclassico bellissimo. Di Milano mi interessa anche la natura spesso occultata. Milano è una città della natura e l’opera PAC, 2012 (la pianta di ficus disposta al PAC) è un lavoro che parte da questo rapporto con la natura, tra spazi interni e domestici e spazi esterni, istituzionali, pubblici. A quest’opera è affidata l’immagine della mostra, che concorre con gli altri lavori alla costruzione di un paesaggio urbano che entra ed esce dallo spazio deputato all’arte contemporanea. Milano vive di queste dinamiche contraddizioni: e nel dinamismo crea complessità. Milano è l’attesa. Anche di qualcosa che non sai. E poi è “la città che sale”, dove trovo ancora lo spazio per dire come Savinio “ascolto il tuo cuore città”. Tu giri in bici e io guardo fuori dalla finestra. Sono due forme di attesa, credo…
MC: In tutta la storia dell’arte scegli due opere, quali?
AG: Ah, che domanda difficile, Vaso blu di Cézanne, 1889, è un opera che copiavo spesso da una riproduzione che possedeva mio padre nel suo studio. Da bambino l’ho copiata molte volte. Ora mi viene in mente un viaggio in nave da Genova a Barcellona, c’era un mare agitato, il vento profumava di pino a 80 miglia dalla costa. Ho chiesto a un marinaio: “Come mai?” mi ha risposto “Dalla Provenza arriva vento fortissimo”. Un giorno dal giardino di casa di Cézanne, ho visto la montagna di Saint-Victoire da lui spesso dipinta, luminosa e bianca, è ancora più luminosa per la luce cristallina, che creava frammentazioni di luce e ombra… e ho capito che il vento è stato complice di Cézanne. Un’altra opera è l’Assunzione della Vergine di Tiziano nella Chiesa dei Frari. Mi piace immaginare lo stato d’animo di Tiziano, sono convinto che fosse innervosito, perché ha dovuto confrontarsi con una situazione nella quale nessun pittore si vorrebbe trovare: cioè dipingere un grande quadro, in controluce tra due grandi finestre addossate alla parete su cui avrebbe dovuto dipingere. Sono certo che questa situazione di difficoltà sia stata determinante per la costruzione dell’opera nel suo impianto generale. Per risolvere questo problema, ha messo delle figure in controluce, ha quindi creato una grande nuvola, per fare in modo che alcuni personaggi fossero in ombra. In sostanza la nuvola divide il quadro in due: sotto i personaggi in ombra in un paesaggio terreno con gli alberi e il cielo azzurro, sopra un paesaggio dorato e paradisiaco. L’opera è stata risolta, condizionata dallo spazio architettonico in cui era inserita. Nella Pala Pesaro che sta in una navata della stessa chiesa, Tiziano ci offre la prova della capacità di relazionarsi con lo spazio architettonico: tra i tanti personaggi che guardano la Vergine c’è il ritratto di un giovanetto che guarda verso lo spettatore, che è lì in quel luogo, come se il giovanetto avesse sentito la nostra presenza. Tiziano dipinge una scena nella quale noi spettatori entriamo: non c’è confine tra l’architettura reale e lo spazio inventato nel quadro. Due opere indimenticabili!
MC: Ti sei mai sentito solo?
AG: No, sono sempre stato in contatto con le persone, non mi posso immaginare solo. Mi piace stare solo, ma sapendo che ci sono gli altri.
MC: Consideri il tuo lavoro “semplice”?
AG: Considero il mio lavoro semplicissimo, Certo, alla semplicità si arriva necessariamente passando attraverso la complessità…
MC: Quali erano i tuoi incubi da bambino?
AG: Non ho mai avuto alcun incubo! Solo vortici che si rincorrevano, lenzuola bianche, quando avevo la febbre. Lo ricordo ancora oggi…
MC: Di chi ti fidi?
AG: Di chi amo.




