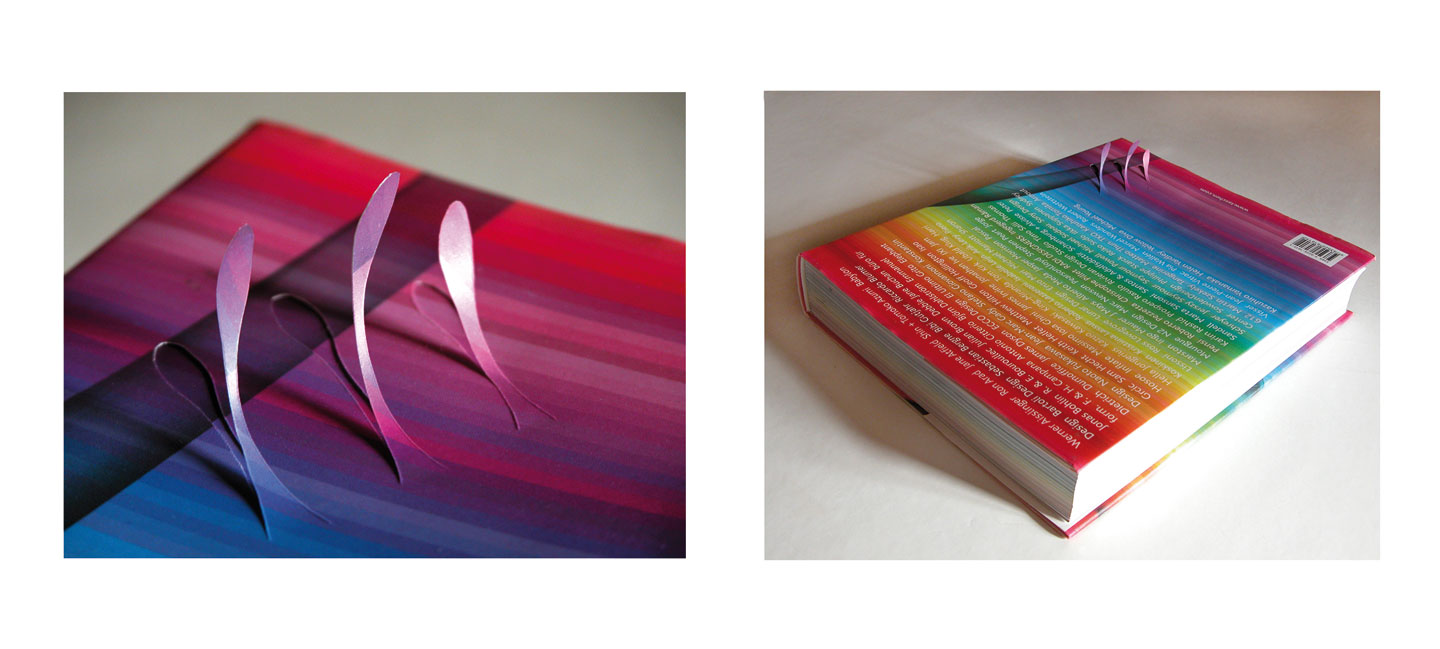Courtesy Glasgow International Festival of Visual Art. Foto: Eoghan McTigue.
Doveva succedere, e alla fine, inevitabilmente è successo: il Concettuale — la matrice di dispositivi di senso alternativa e anti-istituzionale per eccellenza — alla fine è diventato il mainstream, e quindi le nuove pratiche artistiche che si pongono in antitesi con lo status quo per esplorare nuovi spazi e per rimettere in discussione le convenzioni di significato esistenti non possono che metterlo in discussione. E questo avviene in particolare in un momento in cui una nuova, potente ondata di innovazione tecnologica rimette in discussione in primo luogo la separatezza logica tra produttore e ricettore di contenuti creativi, dando vita a un ecosistema culturale nel quale la partecipazione al processo di creazione e circolazione del significato diventa semplicemente l’altra faccia del concetto stesso di cittadinanza attiva. Ce n’è più che abbastanza per rimettere in discussione tanti (troppi?) punti fermi del sistema-dell’arte-come-lo-conosciamo. Ci sono in particolare alcuni elementi di questo mondo sociale e culturale che fino a qualche tempo fa parevano del tutto naturali e accettabili e che invece, alla luce del nuovo stato di cose, pongono interrogativi e problemi crescenti, e sono probabilmente destinati a finire sulla linea di fuoco delle neo-avanguardie, delle quali abbiamo dato un primo, possibile esempio nella puntata precedente discutendo le posizioni di Michael Paraskos con il suo ritorno a una fisicità né nostalgica né consolatoria del fare arte, ma che in realtà, come avremo modo di vedere, stanno dando vita a un quadro per ora disorganico, confuso, a volte ingenuo, ma non per questo meno intrigante e vitale.
Il primo elemento che sta assumendo un carattere rapidamente e fortemente critico è l’autoreferenzialità crescente del sistema dell’arte, tanto più evidente quanto più si ammanta di un’apparente pretesa di universalità e di interdisciplinarità, e che viene ulteriormente amplificata dall’applicazione sistematica dei dispositivi concettualisti. È vero, mai come oggi gli artisti collaborano con ogni genere di interlocutori: scienziati, filosofi, cuochi, attivisti politici, leader religiosi, e chi più ne ha più ne metta; sconfinano negli ambiti più vari, dalla fisica delle alte energie alla paleografia bizantina; coinvolgono nelle loro pratiche ogni sorta di minoranze etniche, politiche, culturali. Per cui, mai come oggi dovremmo trovarci di fronte a un sistema aperto in cui la pratica artistica diviene sempre più parte di un patrimonio comune, condiviso, inclusivo. La realtà, però, è diversa: questi “attraversamenti” disciplinari, metodologici, socio-culturali sono in realtà cammini chiusi, che servono a tornare al punto di partenza con una nuova, più forte legittimazione legata alla generazione di varietà, che ha però in questo contesto una valenza più strumentale che sostanziale. Più che di un reale dialogo disciplinare, si tratta di un’appropriazione, di una vera e propria annessione di senso, che funziona appunto secondo modalità codificate e legittimate dai dispositivi del Concettuale, e che opera più che altro a senso unico. L’artista sa di non poter veramente esplorare, seguire la deriva della corrente dell’esperienza, perché deve mantenere un controllo, una regia di fondo sul processo di sviluppo di un lavoro sempre più costruito attorno a calendari e scadenze che assomigliano a quelle della moda: primavera-estate, autunno-inverno, le fiere di stagione, le biennali di stagione, Miami-Londra-Basilea, Venezia-New York-Kassel, o Shanghai, o San Paolo, o Istanbul. E guai a non esserci.Una volta, qualche anno fa, durante uno dei tanti opening di una delle tante biennali veneziane, mi sono trovato a fare due chiacchiere in vaporetto con una giovane artista. Non esponeva quell’anno, ma ci teneva a farmi capire che ci stava lavorando, e che non si perdeva un party di quelli giusti, e voleva informarsi da me se per caso ce ne fosse qualcuno che le era sfuggito. La ritrovai all’inaugurazione di una biennale di Berlino, neanche questa volta esponeva, ma esibiva uno studiatissimo look con giacca-scultura geometrica trendy-di-nicchia, circondata da amici curatori che facevano graziosamente pendant con la giacca, una PR perfetta, misurata, attenta, professionale. Non le ho parlato, era molto impegnata, e non avrei saputo che dirle. Nei giri successivi, esponeva: a Skulptur Projekte, al Turner Prize (che ha vinto), a Documenta. Il suo lavoro è molto intimo, molto concettuale, molto interdisciplinare. È perfetto, se visto dalla prospettiva della strategia ottimale di adattamento al sistema, e i risultati lo confermano. Ma è anche un’illustrazione perfetta di quella autoreferenzialità, di quella circolarità a cui facevo riferimento: è un esercizio di stile perfettamente calcolato per “dire” la cosa giusta al momento giusto, è del tutto omogeneo ai rituali di appartenenza, alle convenzioni di senso, ai codici di riconoscimento di una micro-società che usa il mondo per parlare a sé stessa. Per l’artista perfettamente adattato, ogni contatto con il mondo “esterno” è un breve flirt, che dura lo spazio di un progetto, per poi passare al successivo, in un altro posto, con altre facce, usando altre parole, ma seguendo alla perfezione la stessa grammatica. Per il collezionista che compra l’opera che lo formalizza, è un’altra figurina da esporre nell’album. Per il resto, è una macchina ormai perfettamente oliata di cene placée, art brunches, eventi esclusivi che ha risolto in modo definitivo il vero problema dei super-ricchi di ogni latitudine: come ammazzare il tempo.
Attraverso l’applicazione giudiziosa dei dispositivi concettuali, gli artisti, e con loro i collezionisti che ne comprano le opere, si appropriano del mondo e lo mettono tra parentesi. Nulla sfugge — ogni patologia sociale, economica, psicologica è ammessa: carneficine su base etnica, danni dell’inquinamento globale o dell’ultima sciagura nucleare, torture psicologiche del quotidiano, astruse strategie di saccheggio della finanza internazionale (che spesso è la stessa che paga, soddisfatta, il conto della serata), ma rassicuranti nella loro tersa impaginazione formale, addomesticate negli spazi acquiescenti del museo o della casa-museo. Nulla sfugge, nulla è escluso ma, come dicevamo, si tratta di un flusso a senso unico, nel quale le vittime dei massacri, delle fughe radioattive, delle violenze domestiche, della spoliazione economica di interi paesi non avranno mai non diciamo una voce in capitolo, ma neanche una pallida percezione del gioco in cui sono stati coinvolti, del quale sono divenuti attori inconsapevoli. Come sarebbe possibile concepire delle forme più assolute, più radicali, di soddisfacimento di un desiderio di onnipotenza? Comprare non semplicemente le vite degli altri, ma la rappresentazione del senso di queste vite, senza risparmiare le sfumature più dolorose, personali, indicibili — e usare questi documenti per arredare la propria vita, sotto forma del muro principale del dining della casa di Gstaad, quello, appunto, che si usa per ricevere gli ospiti in pellegrinaggio alla collezione per le cene placée.
Al punto fermo del mondo che gira: il mondo è in crisi, ma questa arte, apparentemente, non conosce crisi, c’è anzi più voglia di comprare, il gioco diventa ancora più selettivo, più crudele, anche perché i nuovi arrivati sono quelli che hanno più fame di emozioni, e quindi sono disposti più degli altri a calcare la mano, a conquistarsi un posto al tavolo principale, costi quel che costi. Vogliono i nomi sicuri, vogliono giocare, sì, ma non per partecipare: per vincere. È questo mondo, sono questi rituali, che si collocano inconsapevolmente sulla linea del fuoco del cambiamento culturale. È un mondo apparentemente imbattibile: è ricco, potente, ha il pieno controllo della situazione. Come tutti quelli che lo hanno preceduto nella storia del mainstream dell’arte. Ma è già finito, anche se non lo sa. Il pendolo dell’arte va ormai inesorabilmente verso forme di condivisione, di apertura antitetiche a queste. È solo questione di tempo. In attesa del prossimo mainstream.