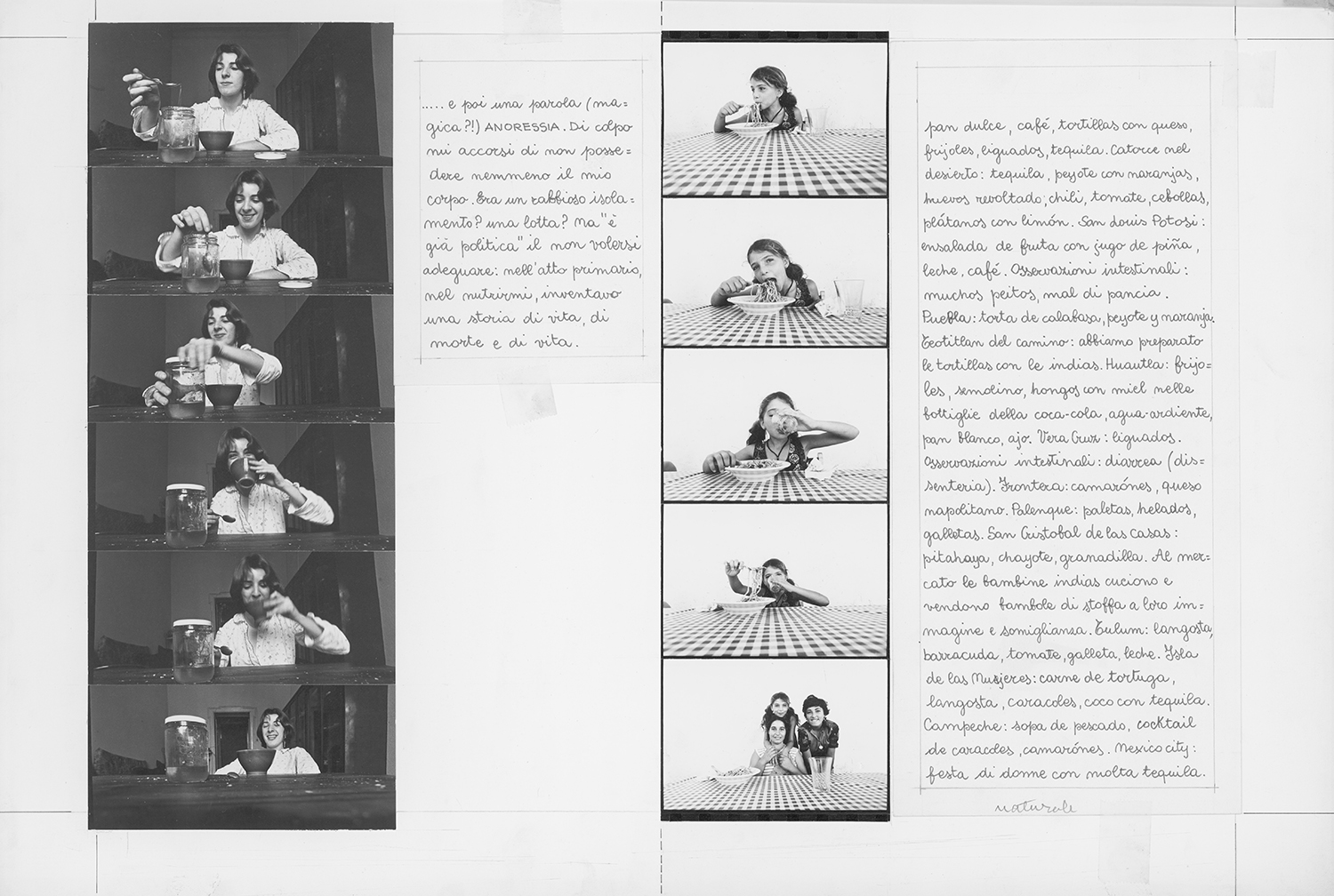La questione della presunta mancanza di una coscienza politica dell’arte italiana alimenta il dibattito sulle pagine di Flash Art alla fine degli anni Duemila. Ritornando sulle premesse del suo libro L’uccello e la piuma, Luca Cerizza invita ad abbracciare altre forme di racconto del rapporto tra l’artista e la società.
La questione della presunta mancanza di una coscienza politica dell’arte italiana alimenta il dibattito sulle pagine di Flash Art alla fine degli anni Duemila. Ritornando sulle premesse del suo libro L’uccello e la piuma, Luca Cerizza invita ad abbracciare altre forme di racconto del rapporto tra l’artista e la società.
Mentre scrivo questo testo sono a Londra, a installare una grande mostra personale di Gianfranco Baruchello che organizzo in un’istituzione dell’Est End. La mostra e il lungo saggio che l’accompagna si concentrano sulle espressioni più prettamente visive e meno scopertamente concettuali e politiche del lavoro di Baruchello. D’altro canto il testo vuole dimostrare come già nei contenuti della “cartografia mentale” di Baruchello, e nel modo in cui queste opere vengono fruite, sia rintracciabile una componente critica e politica molto incisiva. Se, nello stesso immaginario che popola numerosi suoi quadri, è piuttosto evidente una critica sarcastica verso la società e la politica, è anche nelle forme con cui queste opere sono prodotte ed esperite – la frammentazione continua, l’adozione della piccola scala, la necessità di tempi lunghi di fruizione, la difficoltà di riprodurre e veicolare l’opera sotto forma d’immagine – che mi sembra di leggere una resistenza alle forme più banali di spettacolo, consumo e mercificazione.
Parto da questo caso personale perché riprende e (ri)propone una possibile risposta a una delle domande che erano entrate in un libro che avevo scritto qualche anno fa (L’uccello e la piuma. La questione della leggerezza nell’arte italiana, et al/edizioni, Milano, 2010) e sul quale ora mi si chiede di tornare.
Quel piccolo libro, passato piuttosto inosservato e forse osservato male, operava una sintetica ricognizione di un quindicennio circa di arte italiana: dalla prima generazione post-Transavanguardia a quella successiva, più o meno a me coetanea e con la quale avevo più frequentazioni. Pressappoco l’era Berlusconi: da Tangentopoli a quei giorni.
Nel provare a tracciare alcuni caratteri specifici (?) della cultura artistica del nostro paese, il testo usava come guida le osservazioni sulla categoria della “leggerezza” come Italo Calvino l’aveva definita nelle sue famose Lezioni americane (1985, ma pubblicate postume nel 1988). Adattandole al contesto artistico leggevo la “leggerezza” nella sua valenza originale, come un principio critico che serve a mettere in questione le identità fisse, come strumento per ascoltare le possibilità del dubbio e della differenza, provando a sottrarla a una serie di semplificazioni e distorsioni che aveva subito e che l’avevano trasformata addirittura in un cliché.
Il punto forse più importante di tutta la faccenda era il rapporto tra l’artista e la realtà (e quindi anche la politica). Calvino lo interpretava usando il mito ovidiano di Medusa, ricordandoci come l’unico modo per rapportarsi alla Gorgone (che rappresenta la realtà) senza venirne soggiogati, è tenerla al nostro fianco ma guardandola indirettamente, attraverso la sua immagine riflessa. Così aveva fatto Perseo dopo averne tagliato la testa e così, suggerisce Calvino, dovrebbe fare l’artista.
Scritto durante la crisi economica seguita al crollo della Lehman Brothers e la lunga, penosa agonia dell’ultimo governo Berlusconi, il libro provava a rispondere a un’osservazione e una critica diffusa nell’ambito della cultura artistica internazionale e riassunta in un testo di Pier Luigi Sacco su Flash Art, cui avevano risposto, sempre sulle stesse pagine, Fabio Cavallucci, Italo Zuffi e Marco Scotini.[i] Era d’altronde un’osservazione che mi ronzava nell’orecchio con fastidiosa regolarità nei lunghi anni di vita e lavoro all’estero (prima ad Amsterdam, poi a Berlino) e suonava pressappoco così: “perché i vostri artisti sono così formalisti?”, “perché parlano raramente della realtà, della politica, della società?”, “perché il loro lavoro non si confronta con quello che succede nel vostro paese?”. Se Sacco attribuiva a questa mancanza l’assenza dell’arte italiana dalle grandi mostre internazionali, Cavallucci puntava il dito sull’ingerenza della politica sull’arte, Scotini sottolineava la necessità di una nuova prassi educativa e Zuffi replicava duramente ai primi due sostenendo che ogni opera degli artisti italiani era un atto politico e che era forse il sistema italiano a non saper leggere adeguatamente e sostenere quegli sforzi.
Confrontandosi con quelle questioni, il libro suggeriva come certi caratteri che attribuivo alla leggerezza calviniana avessero, come nelle intenzioni originarie dello scrittore, valore critico, soprattutto se tarati sulla situazione sociale e politica del nostro paese. In quel senso leggevo il lavoro di molti artisti di quelle generazioni. Ad esempio, collegavo l’azione di corruzione sulle immagini e le icone compiuta da Stefano Arienti anche alla rampante realtà mediatica italiana della seconda metà degli anni Ottanta, quando l’Italia era il paese europeo in cui venivano trasmessi più spot pubblicitari. Oppure scorgevo in una certa tendenza “folk” – la sensibilità a un immaginario popolare se non vernacolare, comune a Simone Berti, Lara Favaretto, Marcello Maloberti, Diego Perrone e altri – come un modo di resistere all’omologazione di una certa modernità globalizzata.
Le conclusioni del testo, sicuramente troppo sintetiche e frettolose, rilanciavano invece altre domande, come in una forma di antitesi a quella prima tesi. In definitiva mi chiedevo se, in una situazione economica, politica e sociale che sembrava a molti in disfacimento, quei caratteri di “sprezzatura”, densità, scetticismo, ironia, anti-spettacolarità e anti-autoritarismo che avevo individuato come segni comuni di molta arte italiana di quegli anni, avessero perso di efficacia o si fossero tradotti in fattori negativi e controproducenti nella realtà della società italiana odierna. Mi domandavo, insomma, se la leggerezza, nonostante le sue potenzialità, non si fosse rivelata “un’arma a doppio taglio, uno strumento da usare con estrema cautela e responsabilità, per la capacità di mutare in un atteggiamento di acquiescenza […] verso il reale”.[ii]
Queste domande, che tra l’altro riprendevano un dibattito allora piuttosto diffuso sul lascito delle Lezioni calviniane, nascevano da una personale insofferenza verso una società e una politica sempre più impresentabili – forse ancora più fastidiose se viste da lontano – cui la stragrande maggioranza dei nostri artisti, curatori e critici migliori non sembravano volere o potere rispondere nel loro lavoro. Domandavo, forse innanzitutto a me stesso, se quelle posizioni alle quali avevo tanto spesso aderito in linea di principio e, in particolare nel lavoro degli artisti, fossero ancora efficaci o lo fossero mai state. Avevo la sensazione che noi tutti continuassimo a ballare mentre la nave affondava. Che continuassimo a vivere un carnevale perenne dimenticandoci che ogni carnevale è solo un ribaltamento temporaneo e illusorio della realtà.
Sono passati alcuni anni: la società italiana, nonostante promesse e illusioni, non è cambiata poi tanto; le storture e ineguaglianze del mondo globalizzato che in quegli anni iniziavano ad avvertirsi, sono diventate sempre più evidenti. Insomma, il materiale non manca mai…
Nonostante si assista a una stagione artistica di generale riflusso verso posizioni meno scopertamente politiche, gli artisti italiani delle ultime generazioni continuano ad avere pochissimo spazio nella scena internazionale e nelle sue grandi mostre (per quello che possono ancora significare). E quelli che sono invitati alle famose rassegne di cui sopra, vivono e hanno studiato spesso fuori dall’Italia e/o prediligono contenuti più direttamente politici nel loro lavoro. Il nostro sistema artistico, nonostante sempre più individualità si siano formate all’estero e agiscano con profitto e competenza a diverse latitudini, non mi sembra più forte e coeso di prima.
Una delle possibili spiegazioni è quella del carattere fondamentalmente “privato” che opera in Italia: un sistema in cui gallerie e collezionisti giocano un ruolo importante nel determinare il profilo dell’arte che viene prodotta o “accettata”; dove le riviste sembrano seguire più o meno quelle indicazioni; dove le istituzioni pubbliche solo raramente svolgono un ruolo di contrappeso, e addirittura la maggioranza degli spazi non profit non sembrano discostarsi molto dal modello della galleria. In tutto questo scenario un’arte di matrice politica o, più generalmente, un ragionamento e una lettura critica sull’arte e il suo ruolo nel mondo, sembra avere uno spazio di azione molto ridotto.
 D’altro canto, è sicuramente vero che, e già lo rilevavo in quel libro, a molti artisti è passata la voglia di scherzare: le loro opere hanno acquisito un tono sicuramente più cupo se non apocalittico, declinazione nazionale di un più generale sentimento da fine Impero che circola in questi anni in Occidente e che da noi affonda in un sostrato cattolico e millenaristico (il Padiglione Italiano all’ultima Biennale di Venezia ne è l’esempio più eclatante). Ed è ancora vero che l’attenzione della maggioranza degli artisti italiani a guardare al mondo di sbieco, a partecipare più che ad analizzare, a “metaforizzare” più che a raccontare, a guardare ai generali più che ai particolari, a essere ambigui più che didascalici, ci solleva da espressioni pedanti, solo superficialmente politiche.
D’altro canto, è sicuramente vero che, e già lo rilevavo in quel libro, a molti artisti è passata la voglia di scherzare: le loro opere hanno acquisito un tono sicuramente più cupo se non apocalittico, declinazione nazionale di un più generale sentimento da fine Impero che circola in questi anni in Occidente e che da noi affonda in un sostrato cattolico e millenaristico (il Padiglione Italiano all’ultima Biennale di Venezia ne è l’esempio più eclatante). Ed è ancora vero che l’attenzione della maggioranza degli artisti italiani a guardare al mondo di sbieco, a partecipare più che ad analizzare, a “metaforizzare” più che a raccontare, a guardare ai generali più che ai particolari, a essere ambigui più che didascalici, ci solleva da espressioni pedanti, solo superficialmente politiche.
Sono passati alcuni anni e io continuo a farmi le stesse domande. Mantengo lo stesso sospetto e fastidio per un’arte che sia cronaca didascalica del presente, manifesto-troppo-manifesto di una tesi o di un principio, seppur eticamente condivisibile. Vorrei arrendermi senza condizioni alla magnifica densità e profondità dell’arte italiana al suo meglio, alla sua ambiguità polisemantica che guarda sempre Medusa di riflesso, ma penso anche che non farebbe male qualche volta essere espliciti, e che davanti a tanti scempi si potrebbe anche provare a guardarla in faccia questa brutta faccia.
D’altro canto, in questi anni di attenuata “militanza” generazionale, ho continuato a studiare un po’ di storia e ho continuato a guardare cosa e come si fa ad altre latitudini, anche molto distanti. E mi sono convinto di una cosa che già suggerivo timidamente in quel libercolo. Cioè che l’opera, d’arte o d’ingegno che sia, non è completata all’interno dello studio dell’artista ma va aiutata a camminare nel mondo. Questo vuol dire che, se è l’artista per primo a dover motivare il proprio lavoro verso gli altri (e questo coinvolge l’educazione all’arte ma anche una chiamata di responsabilità dell’artista), è poi come questo è raccontato, esposto e diffuso da critici, curatori, redattori di riviste e direttori di museo ad assicurarne, almeno in tempi corti, una vita migliore. Non è un esercizio retorico, roba da azzeccagarbugli o da televendite, ma un modo di collocare l’opera in un contesto sociale, politico, economico e culturale più ampio, per farne capire la portata. Questo avviene in altri sistemi, anche in apparenza più piccoli e di tradizioni meno gloriose, dove anche l’arte che appare più scopertamente formale, a-sociale, a-politica, è supportata da un’analisi e una consapevolezza più profonda della posta in gioco.
Non è un modo per appiattirsi sulle posizioni diffuse nei circoli più engagé, anche se il rischio c’è: è piuttosto un’operazione di verità che dovrebbe spiegare il senso di certi gesti nei contesti dove sono nati. Raccontare la diversità dai modelli più diffusi anche come forza critica e politica. Perché, nonostante la globalizzazione e la mobilità renda sempre più ambigui i confini e le identità nazionali e culturali – e per qualcuno potrebbe rendere tutto questo mio discorso obsoleto –, le differenze esistono e possono essere una forza, soprattutto in un sistema geneticamente più debole di altri.
Così, e faccio solo l’esempio di maggior successo, aveva fatto Germano Celant su queste stesse pagine cinquant’anni fa esatti,[iii] contrapponendosi a certa arte e cultura anglo-sassoni e sottolineando il carattere critico della differenza rappresentata dagli artisti che aveva incluso sotto l’etichetta di “Arte Povera”. Così si potrebbe leggere un potenziale critico, se non politico, anche in quegli artisti che non hanno una patente di militanza nel cassetto: da Carlo Mollino a Ettore Sottsass Jr., da Carol Rama a Maria Lai, da Massimo Grimaldi a Roberto Cuoghi. Ed è forse meglio se ci proviamo noi prima che lo facciano altri.
Allora l’esempio iniziale del lavoro di Gianfranco Baruchello, politico proprio quando è più formale, politico perché, pur facendo immagini, mette in crisi la nostra capacità di consumarle, suggerisce che è forse anche nei modi in cui un’opera vive nel mondo, che questo può acquisire un respiro più ampio. Anche se è quello di un novantatreenne…