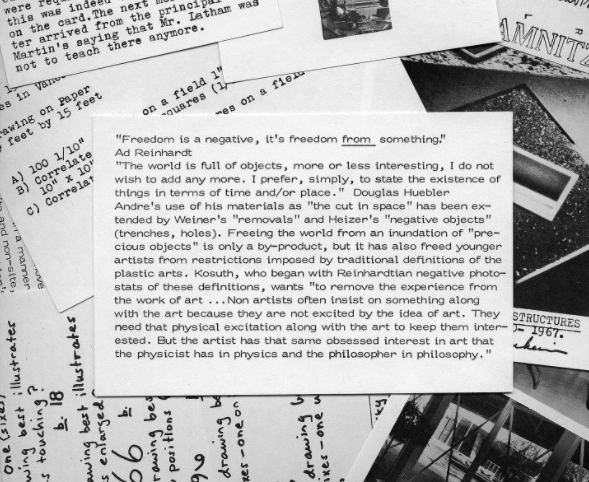La mostra “Tra. Edge of Becoming” e Palazzo Fortuny a Venezia, sede dell’esposizione, offrono un’occasione per ricordare il potenziale evocativo dell’arte, quanto il cosiddetto white cube possa apparire alle volte anonimo e insufficiente, e come uno sguardo all’indietro — rintracciabile anche in un allestimento che ricorda la messa in scena teatrale, con tanto di illuminazione rasente bandita negli allestimenti museali tradizionali — possa diventare propulsore per una rivisitazione e una riflessione in avanti.
Appartenuto dapprima alla famiglia Pesaro, Palazzo Fortuny in Campo San Beneto ospitò l’atelier fotografico, il laboratorio di design teatrale e tessile dell’eclettico artista Mariano Fortuny, imprenditore e intellettuale, vissuto tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, di cui rimangono visibili le opere e la collezione personale.
All’interno del Palazzo prende forma la mostra “Tra. Edge of Becoming” che, come narra il titolo, pone l’accento su una “preposizione” linguistica, preparando il visitatore a soffermarsi su quello che accade prima di un qualsiasi divenire; il “tra” indica anche un essere in mezzo, in questo caso un percorso visivo, attraverso il cui limite il team curatoriale invita lo spettatore a sporgersi. La mostra, ponendosi come un vero e proprio viaggio, riflette sul modo di vedere l’arte focalizzandosi sullo spazio intorno a tale azione, sul confine tra il vedere e il non vedere, sull’apertura, l’attraversamento e il limite di tale passaggio.
La sede espositiva, si potrebbe dire, è tutto, ma non saremmo onesti poiché alcuni lavori sono davvero straordinari. Seppur l’operazione composita manifesti talvolta alcune lacune, tuttavia esistono delle combinazioni davvero affascinanti, come l’Invisibile Object (1934) di Alberto Giacometti, e l’opera pittorica Red Hand, Green Hand di Michaël Borremans, (2010), collocati proprio all’entrata della mostra; oppure lo splendido lavoro di Marisa Merz, Senza Titolo (1980) al secondo piano; o il dialogo tra il lavoro di Chen Zhen e la testa di Giano del II secolo a.C.
Come non citare inoltre, tra tante, le opere di Auguste Rodin, Gerhard Richter, Osvaldo Licini, Francisco Goya e Gianni Colombo.
Distributi in un percorso che si svolge su quattro piani, i trecento lavori consentono, con una certa superbia, di perdonare gli artisti assenti. La mostra si compie in uno strano mescolarsi di opere autografe e anonime, di corpi scultorei e acefali, tra singolari busti e teche semi illuminate. Numerose le opere di matrice indù, classica e orientale e di artisti belgi che tracciano il ponte con la Fondazione del mecenate Axel Vervoordt di Anversa che, giunto alla sua quarta operazione a Palazzo Fortuny — a partire dal 2007 intraprese la trilogia “Artempo”, “Academia: Qui es-tu?” e “In-Finitum” — appare figura inscindibile da eventuali considerazioni sulla mostra. Egli è mentore del progetto, e figura accanto a un team curatoriale composto da Daniela Ferretti, alla direzione di Palazzo Fortuny, Rosa Martinez e Francesco Poli.
La straordinarietà della mostra risiede tuttavia nello stesso accostamento che vede avvicinate opere di formazioni storiche, geografiche, antropologiche differenti, capaci di innescare un completamento inaspettato quanto suggestivo. Se tale disposizione rammenta il cabinet de curiosités tanto in voga oggi negli spazi e musei d’arte — scelta atta a giustificare un’assenza di operazione curatoriale — in quel luogo si sente davvero che l’operazione curatoriale è stata condotta consapevolmente alla volta di una scoperta del sentire e del comunicare con e attraverso l’arte, al fine di dischiudere un’emotività che, mai come in questo caso, piace tanto al pubblico quanto al critico. La mostra si vede e si gode con un po’ di ingenuità. Evviva.