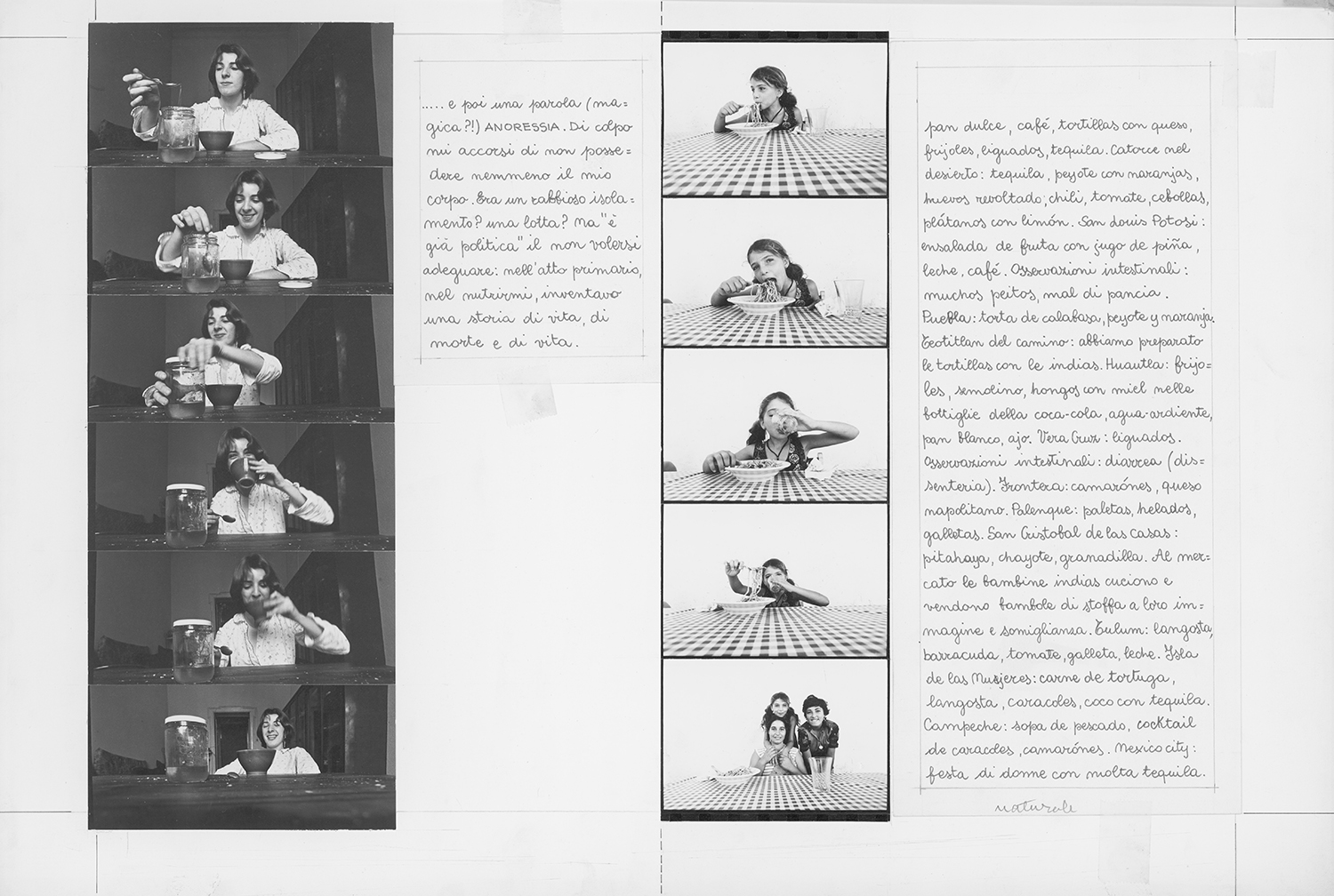Dove c’è un’ontologia non
c’è metamorfosi. Dove c’è una
metamorfosi non c’è identità.
Il sembiante è l’inganno che
ci fa credere che c’è qualcosa
là dove non c’è niente.
Nelle vulgate antologiche – soprattutto dopo la morte di George Maciunas, avvenuta nel 1978 – Fluxus è descritta come la più radicale e internazionale delle esperienze artistiche della seconda metà del Novecento; ma è questa solo una litote dettata dalla compiacenza, o meglio, una donazione, intendendo con essa un senso a posteriori frutto di un accordo scellerato tra artisti, critica d’arte e mercanti. Lo si deduce dalla povertà del gergo critico usato e dall’enfasi retorica impiegata, priva di logica e ricca di allocuzioni all’insegna del nonsense. Più semplicemente, il destino delle avanguardie storiche l’ha evidenziato in maniera inequivocabile: la riconsiderazione ha sempre avuto un’origine finanziaria mascherata da ripensamento critico.
Il corso della storia moderna, che ha scelto la cultura della conservazione (come struttura, più che come morale), ha poi imposto alle avanguardie che hanno chiuso il Ventesimo secolo, ciò che nell’arte militare era il loro immediato contrario, di mostrarsi profetiche, fingendosi capaci di essere metafisiche. Di contro, la grandezza di quelle che hanno esaurito la loro missione – anche e soprattutto attraverso il loro fallimento – sta nell’estinguersi quando il loro tempo è concluso. Come disse Marshall McLuhan: “Non si fanno né rivoluzioni, né predizioni, guardando nello specchietto retrovisore della storia”.
Delegittimando, per ipotesi, le apparenze – secondo il registro dei naufragi – la questione è ancora più radicale: e se Fluxus fosse soltanto un miraggio, il riflesso di una forma sintomatica portatrice di crisi?
Grazie all’ánghelos che lo annuncia, sappiamo di un naufragio che si verificò nelle Isole Vergini britanniche, sulla battigia di quella verde isola che giace “like a leaf upon the sea”.
Proviamo allora a considerare i fatti partendo dalle aporie di dettaglio.
Nella simbologia sessantottarda della “French culture”, lo zenzero – che dà il nome a una delle isole dell’arcipelago, Ginger Island – è un arbusto rizomatico che invera il movimento del desiderio, narrandolo come una struttura diffusiva e reticolare, anziché arborescente. Simile a uno Stoss [shock, scossa] che apre al mondo (Heidegger). Non possiamo sostenere che Maciunas condividesse questo simbolismo “argomentista”, ma sappiamo che era consapevole del fatto che quella “foglia sull’acqua” non era propriamente un’isola, ma un mito concepito per realizzare le proprie idee politiche, sull’esempio di Platone, così come un’aspirazione: mettere l’arte al servizio delle trasformazioni sociali.
Un’eutopia senza abitanti, quindi, popolata di sogni com’erano quelli, nel 1961, della A/G Gallery di New York, in cui Maciunas cominciò a sperimentare la natura di costruzione sociale dell’Ereignis, inteso come l’accadimento “che riconduce l’uomo in ciò che gli è proprio” (Heidegger): la vita vissuta.
Per la piccola storia, potremmo definire il Maciunas di quegli anni un materialista immanente – immanente perché era salpato dal Dvortsovaya naberezhnaya (il Lungoneva del Palazzo a San Pietroburgo) per approdare sulle rive del lago Walden di Henry David Thoreau – ma questa è un’altra topica, che lo vede protagonista, insieme al suo sodale Henry Flynt, nella definizione della forma di arte come di un sub-sistema sociale (Luhmann).
È anche il motivo per il quale Dick Higgins, in una delle tante polemiche della prima ora, lo paragonerà a un commissario politico e a un utopista categorico. E avrebbe avuto ragione se non fosse stato sedotto dalla funzione dogmatica dell’arte, giacché l’idea di estetica non obbedisce che a se stessa. Perlomeno da quando i post-kantiani l’hanno differenziata dalla conoscenza e dalla morale, condannandola a un pericoloso esercizio retorico, di coprire le contraddizioni negandole.
Più semplicemente, Maciunas aveva un’idea archetipica della temperanza morale e delle isole, immaginate come un topos culturale dell’altrove, trame di figuralità o, meglio, miti congetturali nei quali poeticamente abita l’uomo e lievita la teoresi.
Una sorta di plesso epigrammatico – che troviamo anche in John Cage – con le sue cacofonie cartografiche di luoghi nomadi nel mare des incertitudes, dove sperimentare l’utilizzo creativo della jouissance.
Ginger Island, dunque: una forma metonimica. L’espressione di un’enclave geo-artistica nella quale l’ailleurs rencontre l’aventure, lontano dagli inganni della performance – quest’arte effemeride che manipola gli eventi e semina paccottiglia visuale in forma di merce. Il luogo di una diarrea sociale che anticipa, in negativo, la società liquefatta di Zygmunt Bauman.
Va anche sottolineato come Fluxus, esprimendo nella forma analitica del sembiante la sua identità di “Cosa”, “sera toujours représentée par un vide” (Lacan). Se poi, come scrive François Regnault, “tout art se caractérise par un certain mode d’organisation autur de ce vide”, quest’organizzazione è nella forma di un Cabaret Voltaire nella globalizzazione. Da qui la premura con la quale Maciunas sperava di trasferire il movimento su un’isola, dove inaugurare un’università con una sola cattedra, di Soziologie der Cultur-Inhalte. Cattedra che avrebbe sviluppato un approccio inedito al mondo sociale, un approccio così radicale che sarebbe apparso come un oggetto di meraviglia, l’on and off ripetuto ad libitum di un interruttore. Con una certa approssimazione René Block lo definì fluxisme, un termine che richiamava i presocratici e che Silvio Ceccato avrebbe classificato un calzare – a dispetto di Heiddeger – una scarpa già calzata (Cfr., Il linguaggio con la Tabella di Ceccatieff, Hermann, Parigi, 1951).
Sul piano fenomenologico, si poteva rendere l’“inacceptable esthétique” (Benjamin)? Si poteva distinguere il potere dell’arte da quello della politica? C’erano passaggi a Nord-Ovest?
Probabilmente solo nelle lusinghe delle ideologie spettacolari. Nella cruda modernità l’estetizzazione della politica è di fatto un’espressione della “comunità del capitale” e del suo totalitarismo, com’è venuto alla luce nello sbriciolarsi del postmoderno – circostanza che fa intendere come il passaggio dal moderno al postmoderno sia stato favorito dalla “semiotizzazione del simbolico”. Evento nel quale, sedate le apparenze, il Lohengrin perde il cigno e l’arte il suo carattere epifanico.
Ne consegue che il valore dell’arte in quanto merce riposa oramai sul significante. Il significato, al contrario, è ripudiato, concorre solo a pubblicizzare gli apparati simbolici dello storytelling e a fingere una signoria sul principio di realtà. (La trappola dell’épochè, in questo caso, è d’indurre a pensare l’arte come conoscenza intuitiva, così che il reale diventi figlio della rappresentazione.) A questo proposito per il mercato dell’arte è essenziale che il significante non si lasci comprendere – da qui la benevolenza delle fondazioni verso certi gerghi elaborati dai chierici che ad esse vanno in pellegrinaggio. (Del resto la stagione dell’arte ingenua è tramontata [Hegel]).
Maciunas, in Madison Avenue, aveva verificato a sue spese come, nel paradiso dell’Erzeugnis, la cultura e l’arte, anche se pensate come dépense improduttive si rivelavano, loro malgrado, redditizie, seguendo le mode di “quella industria della cultura che nel 1964 venne allo scoperto, celebrando a Venezia l’avvento della Pop art”(Maciunas).
Per altri versi erano anche gli anni in cui, nonostante la latente vocazione leninista, Maciunas e Henry Flynt avevano imparato a maneggiare la dérive e il détournement, due tra gli strumenti più radicali dell’arte sperimentale, che mettevano di fatto Fluxus accanto all’Internazionale lettrista (lo si evince dalla preziosa raccolta, Visages de l’avant–garde, curata, nel 2010, da Jean-Louis Rançon) e all’esperienza dell’I.S. (Internazionale situazionista), di cui condividevano l’arte di creare delle situazioni nelle quali furono banalizzate molte delle pretese di “educazione sociale” alimentate dalla forma di spettacolo. “Nonostante” è in corsivo perché l’artista moderno è la luce mercantile di un mondo che Lenin non riuscì a elettrificare. Nella modernità, infatti, la decomposizione dei linguaggi artistici corre parallela a quella delle merci che essi concorrono a produrre.
In seguito, alcuni incauti sosterranno che tutto è arte (incauti, perché affinché tutto sia arte occorre che niente sia arte); altri che tutto è politica, tanto che la seduzione indotta dalla forma di spettacolo fece credere a certuni possibile, ad altri conveniente, una conversione antropologica dell’attività artistica (banalizzata ad habitus senza poteri teleologici), degradata ad apologia dell’empiria, ridotta a oggetto sociologico (Weber). (In ogni modo, quando si accosta la politica all’arte si commette un incesto – l’arte è già dalla parte del politico.)
Una deriva di “tutto è arte” la ritroviamo poi nell’affermazione per la quale “ogni uomo è un artista”, una miserabile sciocchezza che banalizza la poiesis e, attraverso un’emancipazione da operetta dell’azione, concorre a negare il conflitto sociale e le forme dell’identità.
Questo pacchetto di retoriche da maison tolérée compare, con sempre più frequenza, anche nei programmi delle diafane Shangri-La dell’arte globalizzata che assomigliano, essendo stati copiati, a quelli infigurabili inventati da Nicolas Bourriaud per il parigino Palais de Tokyo, con le loro sculture sociali pescate negli scarti dei grand magasin – che non sono affatto quei paesaggi della modernità di cui parla Georg Simmel. Per Bourriaud questo è uno dei tanti volti dell’arte situazionale (intesa come un punto di capitone che salda l’effimero allo spettacolo, con la pretesa di denunciarlo attraverso lo spettacolo; passare il tempo con un coyote è l’espressione meglio realizzata di quest’arte come zero semiotico.), mentre per Fluxus è la sfrontatezza della forma di merce diventata ipnotica; è la riduzione dell’arte a una strategia d’intervento codificata dalle ideologie, un passaggio condizionato, giacché il “registro dei valori” vacilla quando si banalizzano le frontiere cognitive.
Ecco perché, per i bagni turchi delle fondazioni artistiche, l’imperativo è di comminare esperienze inutili e contraddittorie, invece che trasmettere saperi. Va aggiunto che, essendo organismi costosi, dipendono dalla “produzione”. Ma tutti gli elementi che determinano questa produzione debbono essere spendibili sul mercato dello spettacolo o falsificabili: dopo il 1968 anche la ribellione ha un brand come prodotto fittizio del rancore e dell’indignazione.
Sono le tariffe di mercato che costruiscono la fenomenologia del valore! In sintesi, la forma di capitale realizza ciò che gli uomini vogliono. Questi desiderano ciò che il capitale impone loro.
Per tornare in argomento, life-like art significa che non conviene esplorare l’arte come uno strumento di analisi critica della vita corrente, quale è stata nei programmi dell’ineguagliabile Galerie Légitime (1969), che Robert Filliou portava con sé, nascosta sotto il cappello. Di Dioniso fatto a pezzi dai titani Atena salvò, occultandolo, un organo solo: il fallo, uno dei simboli nella cultura greca della zoé, della vita che è in noi e che non teme di dissolversi nel caotico.
Nel sito delle fondazioni basta una cornice
ad attribuire una proprietà estetica.
Queste proprietà, di fatto sono pre-confezionate
e si rendono visibili solo nei termini convenuti.
L’opera d’arte riflette l’inutilità a cui l’umanità dovrebbe pervenire.
Non utensile per uno scopo, ma scopo e lo scopo,
non potendo più essere utensile, si rivelerebbe inutile.
(Bernard Rosenthal)
Fluxpoly. Paese che vai, Parco della Vittoria che trovi. A New York si chiamava Wooster Street. Maciunas, esplorandola, al numero 80 scoprì un possibile falansterio sotto l’intonaco sbiadito. Per averlo bastavano 20.580 dollari, una “Fluxhouse Cooperative” e una filosofia economica che si conciliasse con il suo disprezzo per gli architetti. Trovò tutto questo da una parte nei principi del collettivismo, dall’altra nelle chimere ipotizzate da Buckminster Fuller al Black Mountain College. Non lo sapeva, ma aveva posto le fondamenta logiche dell’artificazione – per usare un’espressione di Nathalie Heinrich che fa rima con secolarizzazione – e anticipato l’ideologia dell’artista che vive nelle digital homestead coltivando connessioni e bio-sogni.
Più semplicemente aveva ri-ontologizzato l’arte nel senso che Luciano Floridi o Rosalind Krauss (con expanded field) danno oggi a quest’espressione. Oh, il candore dell’ermeneutica!
Nel 1965, insieme a Flynt, Maciunas aveva scritto e pubblicato un sorprendente manifesto, Communists Must Give Revolutionary Leadership in Culture. Questo manifesto ha due appendici: nella prima si esaltano i blocchi d’abitazione sovietici in cemento come modello per delle nuove aree residenziali; nella seconda ci sono i piani per una casa prefabbricata di centosettantacinque metri quadrati, senza fondamenta: less is more.
Perché tutto questo? Per Maciunas la gratuità dell’arte – che immaginava al di là di tutte le istanze di giudizio economiche e sociali – costituiva una necessità che cercò di conciliare mettendo insieme produzione e atto artistico.
Da qui il caso esemplare delle box, una piccola metafora massimalista dei Plattenbau comunisti, un fortunato esempio imprenditoriale del meno con il più, come nel pragmatico capolavoro One Year (1973-74), in cui accumula con dispetto (patico) imballaggi di prodotti alimentari, scatole di medicinali e articoli igienici consumati in un anno.
Da tempo aveva capito che l’astuzia delle fondazioni, che stavano dilagando nel mercato dell’arte, aveva il suo punto di forza nel favorire meccanismi creditizi arcaici, consapevoli del fatto che l’ordine della domanda non collima mai con l’ordine del desiderio. Di contro, la loro fortuna riposava (e riposa tuttora) sulla loro interessata compiacenza a favorire le rendite parassitarie che hanno generato un apparato di oligopoli picareschi.
L’arte è nella società (Ferrarotti) e quest’accumulazione sottopone all’attenzione della critica d’arte i suoi “derivati comunicativi”, il suo carattere di prodotto storico-sociale. Significa che i codici culturali sono quelli che mediano il valore mercantile dell’opera al significante della stessa. Per questo Fluxus fu deriso e abbandonato a se stesso, nonostante il fatto che più il ricordo di Dada affondava nel secolo, più risultava evidente che tutto il secolo era stato Dada.
Nella fattispecie, le condizioni che determinano la coesione di una poetica sono di natura intersoggettiva piuttosto che oggettiva (lo aveva osservato per primo Émile Durkheim nelle sue règles de la mèthode sociologique [Payot, Parigi, 1984]).
Licenziando Music for Everyman (1961) Maciunas affermò che qualunque cosa a Soho o su un palcoscenico sia definito Fluxus non può prescindere dal fatto che in primo luogo è “un progetto di situazione sociale con il pubblico”. Qualunque cosa.
Leggiamo nel manifesto programmatico del 1966: “Fluxus è la fusione di Spike Jones, di gags, di giochi, di vaudeville, di Cage e di Duchamp.” (Post festum possiamo aggiungere Tony Conrad e i Velvet Underground. Consentono di spiegare la presenza, fin dal tempo della A/G Gallery, di La Monte Young, più di quanto la spieghi la personalità, assolutamente determinante, di Richard Maxfield.)
Un modo per sottolineare che l’inutilità dell’arte è sociale e non estetica – soprattutto oggi, in una stagione di “post-produzioni”, dove la narrazione è il cellophane che avvolge la produzione di opere a mezzo di opere, occultando i criteri di utilità nascosti nell’interpretazione. In questo modo l’arte narrativa finisce per apparire un’invenzione della nostalgia attraverso l’eliminazione delle circostanze.
Maciunas aveva praticamente creato Soho, ma non ha saputo dargli i residenti. Si racconta che nell’appartamento in cui viveva c’era un’uscita segreta blindata; serviva a evitare i protagonisti economici del quartiere: il banchiere cinico, l’amministratore disonesto, il ricco stolto, l’artigiano avido.
Dov’erano i fronti possibili? Dove gli approdi sicuri? Per cavalcare la metafora aggiungiamo che lesionare la relazione produzione/consumo con un consumo che si muta in metaproduzione non significa aprire nuove prospettive all’azione artistica, ma soccombere a similitudini finanziarie.
Per Maciunas, come e soprattutto per George Brecht, la performance aveva i caratteri dell’ovvio ed era senza scopo. In altri termini è l’evento dell’esecuzione che le conferisce un carattere ontologico. Quanto a “senza scopo”, significa che essa coincide con le finalità della praxis. In questo senso non ha nulla da spartire con le neo-performance che dominano il mercato dell’arte oggi, nelle quali una confusa visione escatologica si mescola, interessata, con quella di spettacolo, e il cui obiettivo è di valorizzare l’illusione di una trascendenza delle “tracce visive”, che la ricordano economicamente nascoste nel loro ermetismo visuale. All’opera d’arte del Ventunesimo secolo, del resto, non è chiesto di più che di inverare i “capricci” (Marx) della forma di merce.
Ecco perché l’arte ha pieghe, strappi, anacronismi che la critica d’arte spesso fatica a comprendere. Non è pertanto raro che essa banalizzi il desiderio di desiderio, che spezza l’ambiguità che “non resiste al nulla per la cosa” (Bataille).
Fluxus non deve essere scandaloso.
Troppo facile. Non deve essere ridicolo.
Troppo contraddittorio. Deve essere insopportabile.
(Wolf Vostell a Gianni Emilio Simonetti, davanti a un caffè)
Sul mercato dell’arte domina sovrana
la legge di Say: è l’offerta che crea la domanda.
La storicità rappresenta una delle figure erosive dell’arte contemporanea, che si protegge da questa azione abrasiva assumendo la forma di sintomo, una metamorfosi che le consente di sfuggire alla laicità della gnosis e di conciliarsi con le ragioni dello spettacolo. Così, in un mondo di eventi che svaporano, l’arte diviene una macchina desiderante, “bio-arte”, elabora un percorso politico come rappresentazione.
Da qui uno dei compiti delle fondazioni artistiche: mettere a profitto la capitalizzazione sinottica del sintomo, non importa come. L’obiettivo è coagulare, migliorare e controllare l’immaginazione sociale per migliorare il marketing delle merci immateriali. Questo comporta che “le relazioni predominano sugli oggetti, l’arborescenza sui punti, il passaggio sulla presenza”. Un contesto nel quale “le forme tendono naturalmente a secernere delle narrazioni, cominciando da quella della loro stessa produzione e diffusione” (Bourriaud).
A questo proposito possiamo far risalire il moltiplicarsi delle fondazioni quando non fu più possibile occultare l’involucro vuoto dei realismi ideologici, impotenti di fronte all’evoluzione dello spettacolo integrato. (Le istituzioni in arte hanno tra i loro compiti mancini, di mutare la causa economica in un fine estetico che riproduca il valore, conforto ed equivalente di tutte le cose). Quando la contingenza estetica – espressa visivamente dalla crisi delle apparenze finanziarie (subprime) nell’autunno del 2008 – non poté più essere trattenuta dalla razionalità. È quello che Rainer Rochlitz ha sintetizzato con “dissolution dans l’absolu.”
Dal punto di vista di una storia del gauchisme è il ritorno della rivista Arguments, ma questa volta senza la “cagnara situazionista” a irridere Edgar Morin. I nuovi mandarini si sono fatti furbi, leggono James Clifford e sanno come trasformare gli “oggetti soggettivi” in beni commerciabili, come nel noto miracolo tedesco di un po’ di sego spalmato su una sedia. Le strategie argomentative, ha osservato Rainer Rochlitz, “utilmente attirano l’attenzione sull’irriducibilità del campo estetico”.
È un altro modo per dire che in arte l’irrazionalità è immanente, compare sempre sotto forma di un vizio.
La forma creativa del resto – questa tappezzeria della rappresentazione – è come lo spermatozoo: si auto-determina attraverso la performance! Per questo ciò che contraddistingue quella che molti hanno definito la new–art delle fondazioni non è tanto l’“insignificanza” ma la “designificanza”, una condizione per la quale le ideologie non possono essere minate per i loro fondamenti speculativi. Galleggiano sulla pellicola dello spettacolo.
Questa condizione appare del tutto evidente nell’arte soi disant concettuale, i cui critici hanno scambiato il dressage delle teorie per un déjeneur sur la forme, approfittando del fatto che in pittura l’espressionismo, dopo la globalizzazione, non è che una parodia dei nazionalismi.
Per questi critici la creatività è simile a un totem. Cosa comporta lo spiega l’arguzia di Èmile Durkheim: “La società produce l’arte perché essa serve a rafforzare la società, consolidando i vincoli interindividuali”.
In particolare, “la forma totemica” – come sono i parallelepipedi in compensato verniciato di Donald Judd o le lamiere arrugginite di Carl Andre – “estrinseca visivamente la convinzione che esista (una volta che è stato elaborato un codice) qualcosa di immateriale (di sublime). Una conformazione che sprigiona un’energia capace di simbolizzare le forme”.
Su questo punto conclude: “del resto, le credenze irrazionali non possono che definirsi sociali… come l’arte che è una variabile dipendente dalle variabili sociali favorevoli a delle istanze che sottintendono le lusinghe della comprensione”.
Lo scoprì qualche tempo dopo anche un appassionato del branding, Arthur Danto, nella trasfigurazione del banale, quando, per esaltare l’essenza dell’arte che trasuda dalle Brillo Box, scrisse: con queste scatole “tutte le possibilità dell’arte sono state realizzate e dunque, in un certo modo, la storia dell’arte è finita”. Come dire, Fatima è un’invenzione della massoneria.
Al contrario, in Fluxus l’arte come sintomo è nella forma di agency (Alfred Gell), opera come una struttura che introduce l’imprévu nella vita corrente. In questo modo, e soprattutto tra i suoi attori che sono stati i più impegnati nel sociale, la determinazione dell’arte finisce per corrispondere a un’ipotesi ludica e non a un concetto di funzione o di sostanza.
Lo si può leggere nel testamento che a suo tempo Père Ubu lasciò a Fluxus: l’impiego esemplare dell’ingegno è nell’inutilità artistica.
Del resto, l’azione artistica (come sintomo) non contiene il passaggio da un contenuto nascosto (segreto o autobiografico) a un contenuto manifesto, ma esprime un inganno.
 Nel definire l’arte come assimilabile a un sintomo definiamo la sua inanità e, nello stesso tempo, ciò che la dissimula. Ci sono espressioni nella narrazione artistica che generano soddisfazioni semantiche. Ci sono mutamenti che inghiottono la rappresentazione senza neanche un’increspatura logica. Dipende dalla coerenza inedita del sintomo che, sul piano della semiosi, è assimilabile a una gestalten innovativa del mercato dei segni (W. Köhler).
Nel definire l’arte come assimilabile a un sintomo definiamo la sua inanità e, nello stesso tempo, ciò che la dissimula. Ci sono espressioni nella narrazione artistica che generano soddisfazioni semantiche. Ci sono mutamenti che inghiottono la rappresentazione senza neanche un’increspatura logica. Dipende dalla coerenza inedita del sintomo che, sul piano della semiosi, è assimilabile a una gestalten innovativa del mercato dei segni (W. Köhler).
Questa “formatività” è responsabile di un’illusione critica pericolosa: che l’interpretazione sia in qualche modo de-strutturabile. “C’est ici qu’est le synthome, c’est ici qu’il faut sauter!”
Nelle istruzioni di Maciunas per un event, oggi famoso, vanno inchiodati gli ottantotto tasti di un pianoforte (Piano Piece #13 [For Nam June Paik] [1963]). Possiamo considerarlo un modo per profanare l’apparizione (rappresentazione) ierofanica di sei piccoli Lenin sulla tastiera di quello dipinto da Salvador Dalì (Partial Hallucination: Six Apparitions of Lenin on a Piano [1931]).
Qualche volta, però, l’iconoclastia ha risvolti paradossali. Duchamp per celebrare una porcellana sanitaria di serie profanò un liquido sacro, che Pierre Louӱs e Bataille hanno iscritto di diritto nella météorologie du désir, scienza che annovera tra i suoi affiliati la libertina Annie Le Brun. Un’ulteriore conferma che gli scapoli e le macchine celibi non pensano il desiderio, ridono dell’Olympia e non sanno “pisser dans le trou de la serrure de l’église!”
Come sappiamo, il sintomo porta alla luce la funzione dei fantasmi nell’affossamento dell’esperienza, ciò comporta che il pragmatismo, sopravvivendo alla povertà linguistica dello spettacolo, favorisce in qualche modo l’ortodossia della perfomance. Questo fa capire perché, a differenza di quelle che compongono un Fluxconcert, le performance siano sempre dei congegni finalizzati a banalizzare l’Ereignis della vita corrente (e la sua natura sociale), soffocandolo di luci, electronic dance music, esercizi ginnici e paillettes. Espedienti da tabarin per nascondere il volto totalitario dell’exformale, come è stato definita l’ideologia dei confini di genere.
Ci sono poi altre ragioni, come stigmatizza Rainer Rochlitz, perché l’alienazione ha fatto passi da gigante: non le interessa più agire sullo statuto dell’oggetto artistico trasformato in merce, ma interviene direttamente sul lavoro artistico che sempre più spesso può, e deve, essere assimilato a quello educativo dello spettacolo in politica. Educativo, perché il valore simbolico di un’opera d’arte è fortemente mediatizzato e facilmente inflazionabile e deflazionabile. Assomiglia, in modo straordinario, alla bolla dei tulipani olandese (1636-37)!
En passant. Il leninismo in Maciunas era presente come soggetto, ma nel mondo dell’arte di quegli anni Lenin compariva spesso come una delle icone di una contestazione da operetta o di un confusionismo ideologico. Sorvolando sui barricadieri immaginari, che in Italia Enrico Crispolti amava allevare quando ancora c’era qualcuno che pensava possibile e soprattutto credibile un realismo socialista, esemplari sono i Portraits of V. I. Lenin in the Style of Jackson Pollock (1980) di Michael Baldwin e Mel Ramsdem. Esemplari perché spiegano come non è l’apologia iconica della politica, ma il contenuto del politico che può diventare un fenomeno estetico e aspirare a trasformare il mondo in nome di imperativi utopici o di logiche morali.
Va anche aggiunto che Fluxus è immorale per la filosofia dell’estetica, perché non ha mai avuto uno stile e coltivò, soprattutto nei primi anni della sua storia, l’umorismo come una trappola per i pregiudizi e i luoghi comuni. Diceva Vostell: la bellezza è un atto immorale che l’azione morale rende creativo. Basta poco, la fotografia di un F84 virata in argento. Una pagnotta di pane avvolta nelle pagine di un quotidiano. Cementificare un’automobile. Un umorismo dagli interrogativi tragici che aveva l’obiettivo di deragliare l’ovvio rilevandone l’oscuro (Adorno).
Siccome partono dal niente,
in arte il reale è inaccessibile, il realismo ingannevole!
Oggi, le poetiche in arte si susseguono disegnando una mappa, quella del loro mercato. Devono produrre profitti. Questo trasforma ulteriormente la natura del sintomo, forzato a esprimere lo stadio supremo della rappresentazione: la forma economica. È una delle ragioni per la quale il mercato finanziario, sopravvissuto alle guerre di fine secolo, è più spregiudicato e creativo del mercato dell’arte, che da esso dipende.
In ogni modo, il compito di queste poetiche non è tanto quello di apparire innovative, ma di risultare spendibili come prodotto, perché per lo spettacolo è più facile gestire i bisogni immateriali che gli interessi materiali, soprattutto di fronte a un consumo di cultura che si risolve sempre in una metamorfosi di valori.
C’è tuttavia una Spaltung in questo insieme, che Fluxus ha cercato di allargare e che lo spettacolo non è in grado di contenere: è la difficoltà a reificare il materialismo delle passioni, che noi conosciamo in modo indiretto, come ciò che porta dalla conoscenza alla praxis. Questo luogo di scontro in cui il desiderio vive tra ciò che gli eventi pretendono di essere e quello che essi sono.
Per Fluxus, da questo punto di vista, i piccoli fatti dell’esistenza hanno sempre costituito delle prese di posizione politica che la “competenza artistica” ha tentato di tradurre in un impatto comunicativo e critico.
In questo senso, la società stessa era l’Ereignis, che Maciunas voleva nella forma paradossale di un festival, di una rumorosa fragilità (Hegel), consapevole che la questione sociale doveva svegliarsi dal proprio sogno e sfidare il carattere di fatticità dell’immediatezza – o, meglio, il suo desiderato realismo (Hume).
Questo ci consente di comprendere la ragione del carattere antiestetico di Fluxus, che ha fatto precipitare nell’assurdo il bisogno di un’interpretazione politica capace di far affiorare il contenuto della rivolta che la sua azione sociale aveva. Un contenuto che non era risolubile in un programma o in un manifesto, ma estrapolabile dall’irresolubile (Adorno).
Resta un interrogativo. La sovversione estetica può inquietare le ragioni del primato dell’economico sulle quali non ha apparentemente nessuna presa reale?
Fluxus (che ha condiviso questa domanda con Nelson Goodman), ha suggerito nei primi anni Settanta una nuova configurazione della sovranità dell’arte, confidando sulla facoltà di simbolizzazione estetica della sovversione, soprattutto nella metafora dell’esperienza fattuale della musica sperimentale, da John Cage a Walter Marchetti. In altri termini, ha proceduto a de-realizzare (banalizzandoli) i gesti, gli oggetti, le forme e i suoni della vita corrente, spalancando le porte della gabbia di una semiologia libertaria che ha restituito alla forma del potlatch la sua dimensione derisoria.
Possiamo annoverare a posteriori – come un’eredità di questa banda di déraciné – l’efficacie e irripetibile teatro di situazioni messo in atto nel febbraio del 2012 dalle Pussy Riot, tre giovani anarchiche che mostrarono come si può accelerare il processo di decomposizione dell’aura di un orribile e falso edificio religioso, il tempio moscovita del Cristo Salvatore, in cui un regime autoritario e anacronistico, per calcolo politico, s’inginocchiò davanti alle pretese di una religione reazionaria e, nello stesso tempo, battere sul suo stesso terreno la frivolezza dello spettacolo. Frivolezza che da una parte ha lo scopo di rendere friabile ciò che la logica della forma di produzione mercantile cristallizza. Dall’altra di far passare in secondo piano il fatto che la cultura dello spettacolo tende costantemente a respingere il gioco all’infanzia, perché le attività ludiche hanno il potere di banalizzare la forma di lavoro – minandone l’ideologia così come si sviluppò a partire dalla rivoluzione francese – e la sua Weltanschauung.
Come sanno i barricadieri del desiderio, nell’infanzia della nostra cultura, il linguaggio dell’Eros orfico è stato il gioco. Lo stesso gioco che ritroviamo in un altro groupe de fréres, nobili eredi di François Villon, conosciuto come Cercle des poètes zutiques, che dopo la caduta della Commune, cominciarono a riunirsi in uno scantinato dell’Hôtel des Etrangers.
Se questo è il contesto, come non considerare l’Album zutique (1872) come il primo manifesto artistico della derisione, prefazione a quello purgativo di Fluxus?
Glossando le parole, che Georg Simmel usò per se stesso nel suo testamento, concludiamo questo panegirico: l’eredità di Maciunas è stata in “denari contanti” divisa tra molti eredi “di cui ognuno ha investito la sua parte in modo conforme alla sua natura, senza interessarsi dell’origine di quella eredità”.