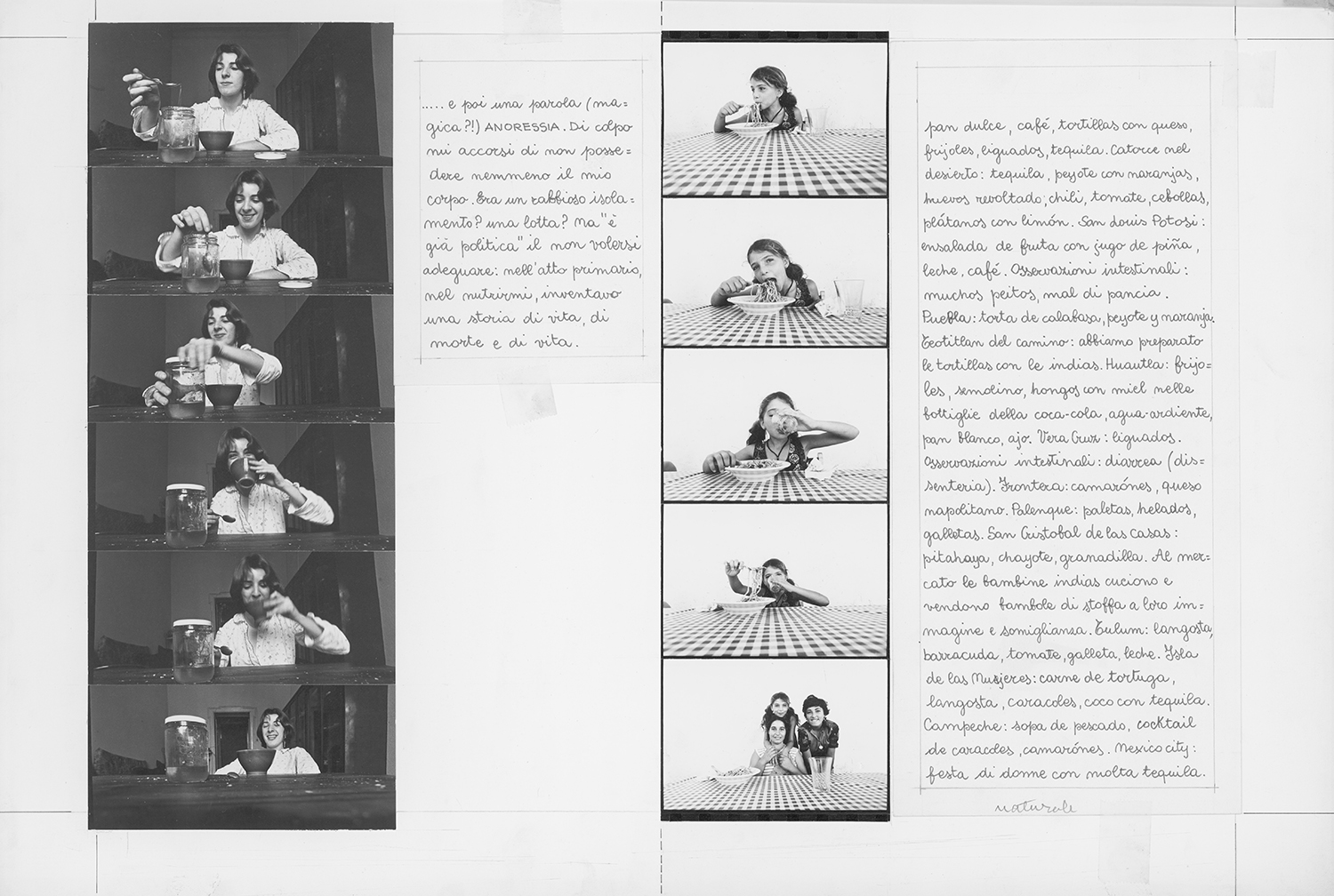Michele D’Aurizio: Sei testimone di molte decadi di produzioni artistiche e culturali in Italia e delle trasformazioni sociali che ne sono conseguite. In quest’attraversamento, hai abitato numerosi ruoli: architetto e professore di architettura, critico d’arte, artista, curatore, collezionista; ma anche animatore nei movimenti di liberazione omosessuale. Il valore dei tuoi contributi a ciascuno di questi ambiti discorsivi è storicamente riconosciuto. Tuttavia, credo che esista un valore anche nella tua stessa scelta di abitare numerosi ruoli e, in un certo senso, di finire per non abitarne nessuno.
Hai parlato di te in termini di “Jolly”. Il motto “non evolvo, viaggio” di Fernando Pessoa, a cui del resto ti sei spesso riferito, è vero anche di te. Nella tua pratica artistica, hai elevato lo scherzo, l’errore, il paradosso, la doppia-funzione e l’inversione di funzioni a procedimenti creativi. I tuoi procedimenti-scherzi “innescano circuiti che si staccano dalle anse dei ruoli creando campi disseminati di possibilità”.1
L’ambiguità e quello che hai chiamato “sbilanciamento” sono sempre stati la tua risposta all’esercizio del potere. Nei Diari di qua e di là hai scritto, parlando di te stesso in terza persona, che: “Egli voleva pensare che l’arte, oltre che la sessualità, era uno dei modi d’incrinatura di quel modo di porsi così centrale”.2 Nella “Lettera al lucente amico gay che vuol diventare scrittore” ammonisci dal guardarsi dal “grande progetto” e inviti a lanciarsi in uno “slalom gigante” tra i paradigmi della società.3
In un certo senso hai sempre rifuggito il potere. Nel 1985 hai avuto una rubrica su Flash Art in cui presentavi artisti emergenti, che però dopo un solo anno hai deciso di lasciare perché sentivi che stavi diventando una “persona di potere”.4
Ecco mi piacerebbe approfondire con te le forme, i modi di operare, le facce che il “potere” assume nell’arte e nella cultura.
Corrado Levi: Mi è molto chiaro che essere sfuggito al potere mi ha salvato da molte cose: dalla celebrità prima di tutto. Penso che il potere sia il modo maschile e patriarcale di essere degli uomini. Io con gli uomini, per questo fatto che la loro misura è il potere, mi sento estraneo e diverso. Non ho amicizie nel mondo maschile, non ci riesco. Ho molte amicizie alla Libreria delle Donne, per esempio – lì sono diverso, sì, ma non sono estraneo. Sono ricettivo. E questa è una fortuna, perché mi permette di sottrarmi da certe situazioni nel momento in cui ci sono dentro.
Anche con i giovani artisti emersi negli anni Ottanta, che ho supportato – appena diventavano famosi e cominciavano a valere dei soldi, mi tiravo indietro… O con gli artisti dell’Arte povera… Paolini l’ho accompagnato io stesso in macchina a Roma, per la sua prima personale alla Galleria La Salita [nel 1974]. E gli ho comprato un quadro: un grande pannello, due metri per due circa, con due tagli da cui emergevano i bordi di una fotografia incollata sul retro [Senza titolo, 1964] – il lavoro più difficile della mostra. Anni dopo, quando la Tate Modern di Londra fece una grande mostra sull’Arte povera [“Zero to Infinity: Arte Povera 1962 – 1972”, 31 maggio – 19 agosto 2001], mi chiesero in prestito quell’opera e mi invitarono all’inaugurazione e alla cena che ne seguì… E lì io trovai uno scollamento tra quel momento germinale che è la creazione e quella celebrazione del sistema dell’arte – uno iato incommensurabile, un cambio di tonalità, si direbbe in musica. Ma, ecco, a me le celebrazioni non interessano, anzi, non mi appartengono.
Ho aderito al Movimento Studentesco. E quello è stato un momento importante nella lotta contro l’autoritarismo. Ma soprattutto ho aderito al Fuori! [Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano]. La pratica dell’autocoscienza è stata la grande rivoluzione degli anni Ottanta, sia delle femministe che degli omosessuali, e la vera chiave di volta della mia esistenza. Perché il partire da sé è inattaccabile, ha questa ricchezza che la tecnologia, la politica non offrono…
E qui entra in gioco l’altro “modo d’incrinatura” che menzionavi: la sessualità. Io ho sempre lavorato sul corpo. Quanto ero a La Spezia, ho fatto un quadro lungo dieci metri per cui facevo posare individualmente dei marinai nudi. “Mettiti per terra sulla tela, come vuoi”, dicevo loro; “Sfiora la precedente immagine come vuoi”. Per quel quadro [Nudi incrociati (1983)], mi rifeci a un disegno del Pontormo in cui avevo riconosciuto una catena di corpi… E poi ho continuato a fare opere sul corpo. Ce n’è un’altra che amo molto, Radio amico (1986), la fotografia di uno splendido ragazzo nudo con una radio sul sedere…

MDA: Hai introdotto, in effetti, nell’arte italiana l’immagine e la funzione di un corpo sessualizzato e desiderante. Sulle pagine di Flash Art, Grazia Toderi scrisse che nella tua mostra allo Studio Cristofori di Bologna, nel 1992, “esiste un forte anelito vitale rivolto anche e ancora verso la fisicità dell’altro.”5
Ora, come hai già ricordato, la tua esperienza intercetta anche quella dei gruppi di autocoscienza. Su queste piattaforme si è cercato di sviluppare una discorsività intorno all’auto-riconoscimento della diversità e alla messa in crisi dell’ideale di mascolinità. Questi obiettivi passavano necessariamente attraverso un tentativo di riconoscere la spinta del desiderio (omo)sessuale e di assecondarla. E questi tentativi accadevano molto spesso attraverso le immagini (e quindi l’arte), perché la parola era screditata come strumento patriarcale.
È interessante notare come in anni recenti assistiamo a una rilettura dell’opera di Carol Rama – un’artista che hai sempre e ostinatamente promosso – proprio in termini di manifestazioni di corpi sessualizzati e desideranti. Paul B. Preciado scrive che le opere di Rama “vengono a de-generalizzare il corpo, a de-generalizzare la sessualità, a liberare la sessualità dall’autorità religiosa e statale.”6
In un salto a ritroso nel tempo, e passando da Carol Rama, potremmo scrivere una tradizione dell’arte italiana della sessualità liberata?
CL: Partirei da Filippo De Pisis, certamente. De Pisis scrisse: “Vado a Parigi perché non sono fascista”. Ce l’aveva con de Chirico e con tutti gli altri esponenti di quell’emergente arte del Novecento Italiano. De Pisis aveva una mobilità intellettuale che certamente derivava dalla sua omossessualità. Altrimenti non avrebbe fatto la sua straordinaria parabola. Anche nel suo ultimo periodo aveva capito che il mondo stava cambiando: è uno dei pochissimi artisti italiani ad aver colto il momento dell’esistenzialismo, con questi bianchi dove non c’era che un ricordo, appena appena smorzato, della sua poetica, quasi timoroso… Conosci quella sua bellissima poesia, “Vecchiaia”? “Amavo soprattutto la luce i colori / i fiori e lo slancio / e i palpiti e il canto. / Amo molto ora / anche l’ombra … E il silenzio leggero … che alla morte somiglia.” Aveva capito di essere completamente cambiato…
In una potenziale storia dell’arte italiana fondata sulla diversità, De Pisis sarebbe centrale. Poi ti direi Osvaldo Licini, perché Licini, pur non essendosi mai espresso sul tema della sessualità, ha la libertà che non ha Morandi, che non hanno altri; Carlo Levi per la sua materia effervescente, mi suggerisce un sentimento erotico; Carla Accardi, perché la sua pittura non ha un centro, è un po’ come un frattale; e Boetti per la sua frammentarietà, che ha qualcosa di lontano dalla centralità maschile, appunto.
E infine Carol Rama… Carol Rama non è femminista, e non è neanche gender, è oltre, è un’altra cosa. Prendi i suoi “Bricolage”, con le unghie, gli occhi di bambole… Tutto questo tocca il fondo dell’umano come non è stato mai esplorato, né da Louise Bourgeois né da altri. Rama ha spostato i limiti senza romperli – che è la vera forza rivoluzionaria, sia nella sessualità, nel comportamento, che nell’arte. Se si rompono i limiti, c’è solo la follia…
MDA: Hai teorizzato tante “altre” storie accanto alla grande narrazione del Modernismo. Hai individuato una “diversa tradizione”, una “tradizione del deragliamento”, una tradizione “tangenziale”, una tradizione “dell’infrazione” ecc. Come tu stesso hai notato, i parametri di questi indirizzi sono sfuggenti, perché per loro natura queste “altre tradizioni” non si consolidano; sono mutevoli perché espressioni di un “fuori” che è esso stesso mutevole. Nella postfazione a Una diversa tradizione, tuttavia, schematizzi in cosa consiste la diversità dei tuoi esempi.
CL: “Una diversa tradizione” è stato, prima di tutto, un corso che ho tenuto al Politecnico di Milano, tra il 1979 e il 1980. La postfazione alla raccolta delle lezioni la scrissi l’estate successiva. Certo, avevo rintracciato delle caratteristiche comuni ai miei esempi: la funzione del caso, a cui nessun’estetica classica aveva dato statuto; e quindi il venir meno del senso; l’esplorazione al negativo dell’intenzione; il venir meno dell’unità, del tempo spettatore, dello spazio spettatore, del linguaggio come “espressione di”, “denominazione di”…
Ecco, una componente importante di quel gruppo di scritti, che esplorai inizialmente con quello su De Pisis, era il cercare di dire una cosa critica con una sola parola. Mi dava fastidio l’articolare il discorso con un prima e un dopo, un perché e una conseguenza. È stato un tentativo di rinunciare alla verbosità delle parole che ho perseguito anche nel catalogo de “Il cangiate” e nel libro Mes amis! Mes amis! (Corraini, Mantova, 2007). Mi interessano molto questi scritti con sole parole che vorrebbero dire tutto e qualcosa d’oltre; che riassumono a pieno un modo di essere, ma suggeriscono anche un’apertura di prospettiva.
MDA: Che ruolo ha avuto la mostra “Il cangiante”, che hai organizzato al PAC di Milano nel 1986, nel tuo più ampio progetto di operatore culturale? Sulle pagine di Flash Art, Giancarlo Politi ha salutato “Il cangiante” come una mostra che ha avuto “il coraggio di mescolare il sacro e il profano, il bello e il brutto, il vecchio e il nuovo, mondanità ed eleganza, cultura e intelligenza, umiltà e presunzione.”7 Ma scriveva anche che l’avrebbe vista meglio a New York o a Colonia, perché lì si sarebbero conosciute le tendenze dell’arte internazionale mentre l’Italia manifestava solo arretratezza su quel fronte.
La mostra, infatti, presentava le opere di numerosi giovani artisti, e di tanti altri mai mostrati in Italia, accanto a opere di artisti italiani storici. Ma in un certo senso la “cangianza” di questa mostra, per me, risiedeva proprio nella scrittura curatoriale che non procedeva per sapere scientifico e lineare ma per intuizioni emozionali e trasversali. Nei Diari hai scritto che “Il cangiante” concentrava un’idea di “arte come scommessa, e non come verità”.8
CL: Installai, per esempio, un lavoro di Bruno Zanichelli, Bomb parei (1986), accanto a dei quadri di Francesco Clemente, Le pazienze (1974) – quindi l’opera dell’artista più celebre accanto a quella dell’artista sconosciuto. Con la particolarità però che Zanichelli e Clemente avevano la stessa età quando realizzarono le rispettive opere… E poi le Alghe (1986) di Stefano Arienti pendevano di fronte a un quadro di Mario Schifano, Compagni, compagni (1968). Però non affiancavo gli artisti emergenti a quelli più affermati per vedere se stavano bene insieme, ma perché entrambi si mettessero in gioco…
Secondo me, “Il cangiante” ha cambiato il modo di fare le mostre. Tutti, in Italia, hanno dovuto fare i conti con questa mostra. Ma io ho preferito non insistere, non ho mai curato altre mostre con un simile approccio.

MDA: A seguito della tua mostra allo Studio Cristofori, Gian Marco Montesano ti indirizzò una lettera aperta sulle pagine di Flash Art, nella quale interpretava il tuo intervento come in bilico tra l’espressione di un comunità désœuvrée e di ciò che definiva una “comunità amante”.9
In un certo senso, Montesano intravedeva (e ti addebitava) il rischio di un ruolo marginale che una comunità, per quanto stabile (finanziariamente, intellettualmente, demograficamente) corre nel momento in cui sceglie di conservare un carattere di differenza.
A questa lettera hai risposto portando ad esempio l’esperienza dei gruppi di autocoscienza, ovvero di “giovani che hanno cercato di riannodare le diverse possibilità dell’esperienza. […] Per cui il désœuvrément era il riconoscere l’estensione degli intervalli delle esperienze come fatto teorico.”10
CL: Il salto da una cosa all’altra obbliga a un salto conoscitivo. E allora – per tornare alla tua prima domanda – il mio essere stato, o essere presente, in diversi campi mi serve perché ogni campo ha la sua sintassi e la sua tradizione che certo considero valori, ma anche pericoli standoci dentro…
Certo, il movimento di liberazione omossessuale è poi virato verso i diritti civili, una direzione a cui io, Mario Mieli e gli altri del Fuori! eravamo completamente contrari: non ci interessava l’omologazione ai diritti maschili, che poi erano quelli del potere. La speranza per la diversità non può esaurirsi nel diritto, nei matrimoni omosessuali… Non è un desiderio per l’omologazione. Quando, allora, il movimento si avvicinò ai gruppetti extraparlamentari e altri andavano in India, io scelsi di rimanere sull’esperienza del corpo e scrissi il New Kamasutra. Didattica sadomasochistica (ES, Milano, 1979) – e sul corpo è l’esperienza che faccio tutt’oggi.
Albini e Mollino, che sono i miei due maestri di architettura, sono due non-omologati nella cultura. Ci sono libri sulla storia dell’architettura europea del Novecento in cui non compaiono, entrambi vittima di un tentativo di rigetto. E lo stesso vale per Carol Rama. Carol Rama non era amata; un po’ perché era donna, un po’ perché faceva loro paura – perché la sessualità non faceva parte della loro esperienza. Mollino, Sanguineti, Berio, invece, la stimavano… È l’unica artista che ha avuto due articoli di Giorgio Manganelli! Quindi, non gli artisti suoi coetanei, ma il massimo della cultura italiana l’aveva riconosciuta – e ne aveva riconosciuto la diversità, appunto.
MDA: Hai trascorso molto tempo negli Stati Uniti, periodi lunghi durante i quali hai anche praticato la tua arte e l’hai esposta. Eppure – e questo emerge soprattutto nei Diari – hai sempre rivendicato per te stesso una forte identità italiana ed europea. In un certo senso, è questo un apparato identitario nel quale ti sei riconosciuto proprio di fronte all’alterità americana…
CL: Quando andai a New York negli anni Ottanta avevo già scritto Una diversa tradizione. Quella mia esperienza intellettuale mi aveva permesso di riconoscere che l’East Village era un fenomeno politico. Io continuavo a dirlo a tutti: “Guardate che, quando arriverà anche qui l’interesse del capitale, sarete fottuti…” Ed effettivamente è finita così, perché la gente deve guadagnare.
Poi, c’è da aggiungere che gli americani sono sciovinisti. David Wojnarowicz, che era americano, ebbe molto successo – mostre, libri… Mentre Luis Frangella, che era argentino e altrettanto influente, anzi forse l’animatore del gruppo, è scomparso… Con gli americani bisogna fare in modo che loro abbiano bisogno di te. Con la Transavanguardia avevano bisogno di una controproposta alla loro arte concettuale; con Maurizio Cattelan di un’arte intelligente, spregiudicata e allegra…
Di fatto, c’era un momento in cui volevo fare il pittore e farlo là. Feci a New York una mostra che fu vista… “Ma perché non ti fermi qui”, mi aveva detto Annina Nosei. Ma io avevo capito che, se fossi rimasto, avrebbero colto quello che potevo dare della mia esperienza e cultura; ma sapevo che sarebbe stato difficile incidere sulla loro… Poi, in Italia, insegnavo architettura, avevo una famiglia…
Io ho potuto palesare la mia omosessualità con la mia famiglia, con i miei figli. E questo solo per dire che ho avuto momenti di coraggio, strappi, che non erano volitivi: erano inevitabili, delle necessità – così come adesso, di nuovo, questo cambiare…