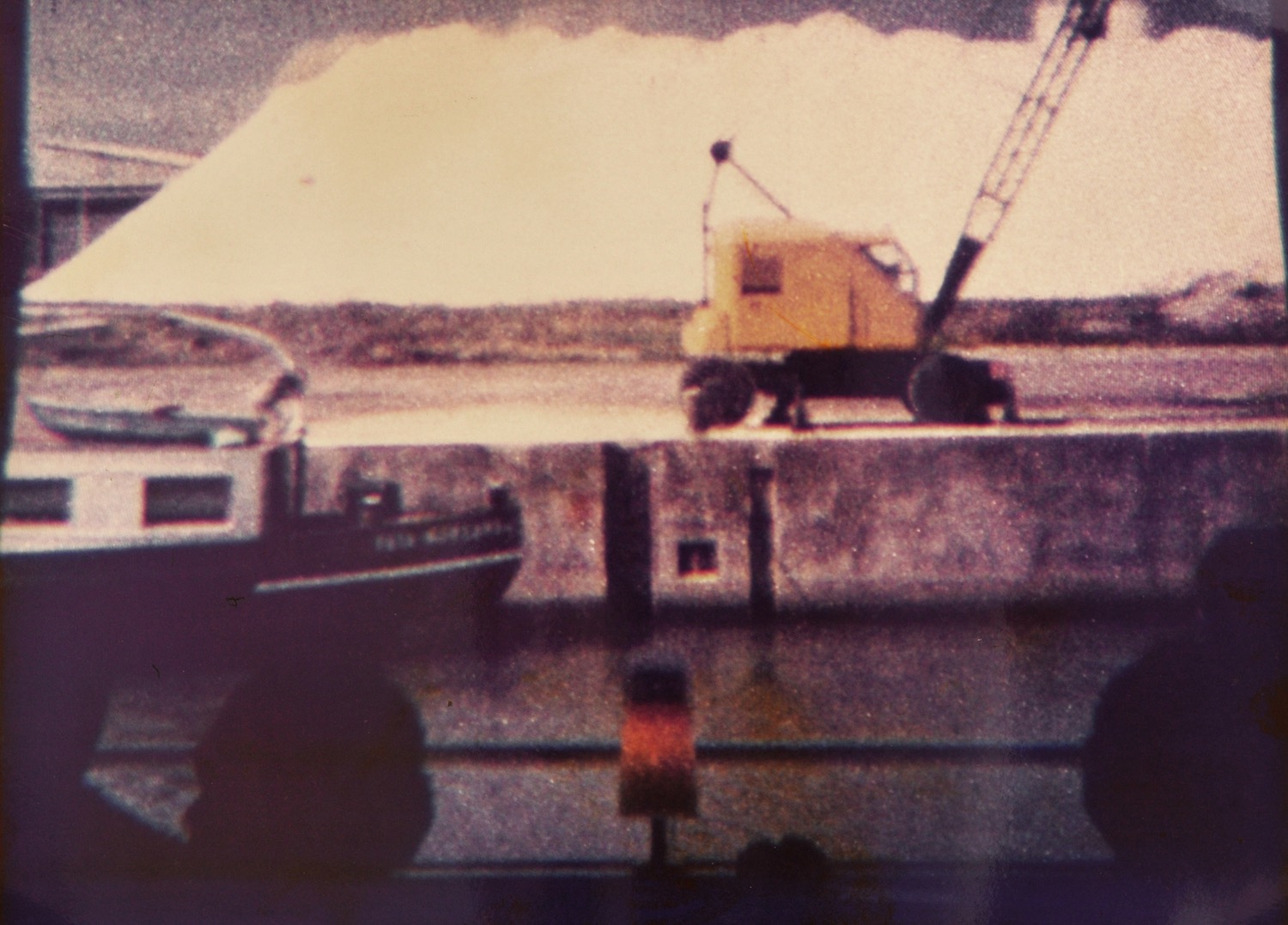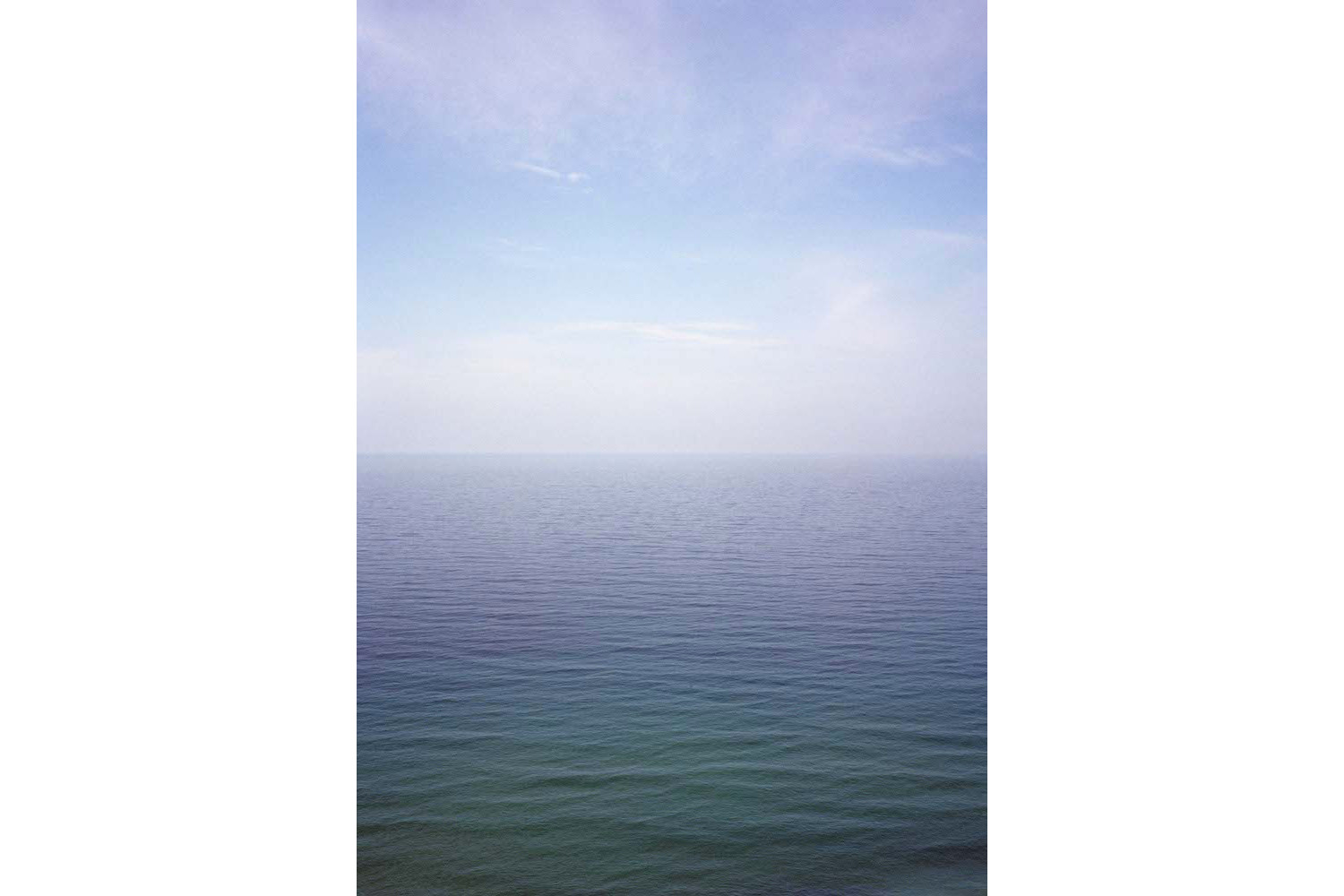Pubblicato originariamente in Flash Art no. 339 Maggio – Giugno 2018.
Il viaggio inteso come rituale ha in ambito artistico un’anima antica. Già Albrecht Dürer, verso la fine del XV secolo, registrò la sua prima scoperta dell’Italia con una serie di sublimi disegni del nostro paesaggio – disegni che, guardati con gli occhi del presente ricordano delle fugaci istantanee dal carattere fotografico. Dürer ha anticipato la tendenza del viaggio “d’artista” che conoscerà una storia prolifica soprattutto nell’usanza del Grand Tour: il viaggio d’iniziazione all’arte di ricerca attraverso la scoperta e lo studio della classicità italiana, che nei secoli ha generato un immaginario turistico e trasognato – ben distante dalla pratica contemporanea che invece impiega il viaggio come medium di verifica della realtà, esplorata in rapporto al corso del tempo e al flusso di coscienza.
Soprattutto è stata la fotografia – e con lei l’Arte concettuale – a inaugurare un lungo filone di ricerca, che ancora oggi reinventa il rituale del viaggio approfondendone l’esperienza del tempo, la memoria e l’identità dell’artista in rapporto ai luoghi visitati. Soffermandosi sull’analisi dei processi che si attivano, delle relazioni scaturite, dei comportamenti individuali e collettivi che genera, il viaggio muta lo sguardo interiore di chi lo vive e del pubblico che, attraverso la sua restituzione sotto forma di opera, è invitato a parteciparvi.

Nel 1971 Franco Vaccari (Modena, 1936) viene invitato dalla Galleria 2000 di Bologna a presentare una sua personale. Sono passati solo due anni da quando l’artista ha ideato la sua prima Esposizione in tempo reale, termine di sua invenzione che traduce istantaneamente l’idea di tempo come particella strutturale dell’opera e fattore di disvelamento di un processo fisico, cognitivo, comportamentale. Per la mostra bolognese, Vaccari realizza la sua prima “opera-viaggio”: Esposizione in tempo reale n. 2, Viaggio + Rito (1971), una registrazione fedele delle azioni abituali compiute dall’artista durante il tragitto in treno da Modena a Bologna per recarsi alla Galleria 2000: acquisto del biglietto e del quotidiano, lucidatura delle scarpe in stazione, salita e discesa dal treno, arrivo in galleria con un taxi. Le azioni sono registrate tramite polaroid da due fotografi-testimoni e gli scatti prodotti sono apposti da Vaccari alle pareti della galleria, assieme al biglietto del treno utilizzato, disposto in una piccola teca, come se fosse una reliquia.1 Tuttavia, il rito non si esaurisce in quest’ultimo gesto: i fotografi continuano a riprendere i movimenti dentro lo spazio espositivo, incorporando il pubblico di visitatori nell’irripetibilità dell’evento artistico e arricchendo le pareti di nuovo materiale. Poco prima della chiusura della mostra, Vaccari, che fino ad allora ne era stato l’“oggetto”, torna ad assumere un ruolo attivo: interrompe l’azione riprendendosi il biglietto e andandosene. L’operazione che, di primo impatto, poteva apparire come un gesto narcisistico ed elitario, era atta a risvegliare l’attenzione del pubblico, già ai tempi assuefatto dalla banalità spettacolare dei media, trasformando un’esperienza autobiografica in una biografia collettiva. I visitatori, le cui azioni alimentavano gli esiti dell’opera, si calarono nei panni di artefici di una finzione, che molto disse riguardo l’assorbimento passivo dell’informazione.
Con questo primo lavoro, Vaccari intraprende la serie dei “viaggi minimi”, tra cui anche Viaggio nell’Albergo diurno Cobianchi, Piazza Duomo (Milano, 1971) e Viaggio lungo la scalinata della torre di Graz (1975). Sul mito del viaggio praticato in quegli anni l’artista scrive: “Negli anni Settanta, all’interno dell’ideologia hippy, c’era l’idea mitologica del viaggio in paesi lontani, nell’estremo Oriente, soprattutto in India. Io trovavo che questo culto per l’Oriente non era altro che un impulso turistico, un malcelato consumismo culturale. Sono sempre stato interessato a concentrare la mia attenzione su spazi che possedevo fisicamente, come appunto la mia città. Così, un po’ in polemica con la mitologia dei viaggi esotici di allora, ho cominciato a costruire i miei viaggi minimi.”2
Il viaggio come osservatorio dei comportamenti sociali e recupero di uno “spettacolo” pubblico/privato troverà per Vaccari risvolti inaspettati nell’opera Viaggio sul Reno del 1974. Insieme agli amici artisti Guido Arra, Ugo La Pietra e Gianni Pettena, Vaccari naviga il fiume con una nave crociera, calandosi per alcuni giorni nel vissuto di un ambiente omogeneo, pianificato nei dettagli e dai rituali scontati, per verificare l’inautenticità di un’esperienza preconfezionata. Dentro uno spazio che garantisce un benessere effimero, Vaccari ritrova quel residuo minimo di autenticità nei momenti casuali della crociera, lassi temporali che testimonierà tramite fotografie sfocate o sgranate, causa la resa a bassa definizione dello sviluppo istantaneo della polaroid. Narrando ciò che resta ai margini dell’esperienza – la componente inconscia, casuale, paradossale di certe situazioni – Vaccari interviene sul recupero dell’inutile, dell’ovvio e dell’incerto in una dimensione di indubbia prevedibilità.
La verifica analitica del tempo ritorna in Esposizione in tempo reale n. 8. Omaggio all’Ariosto (1974) posta, questa volta, in un confronto tra modelli e codici sottesi alla teoria stessa dell’arte. Sempre nel 1974 Vaccari è invitato a partecipare con un’opera a tema alla collettiva “Omaggio all’Ariosto”, che avrebbe avuto luogo a Palazzo dei Diamanti, a Ferrara. Invece d’ispirarsi all’immagine storica del personaggio, l’artista decide di rimanere nell’ambito del reale, prendendo come spunto il cammino che Ludovico Ariosto compì a piedi, in pantofole, da casa fino a Ferrara. Partendo da Carpi, Vaccari ripercorre il pellegrinaggio in auto e con degli zoccoli ai piedi, registrando con la polaroid il suo passaggio nei vari centri abitati toccati dall’Ariosto: le istantanee sono poi incollate alle cartoline dei paesi attraversati, timbrate con il titolo dell’opera e inviate per posta a Palazzo dei Diamanti. In mostra furono esposte tutte le cartoline-polaroid arrivate, emblema di un’operazione tra fotografia, happening e mail art (tra le prime a essere compiute in Italia). Invece di partire da un modello per rappresentarlo coerentemente, Vaccari costruì un proprio modello del reale da porre a confronto con quello ereditato dalla storia: la verifica avvenne per frammenti (le polaroid), particelle minime di esistenza che documentano l’irripetibilità del momento. Il freddo inconscio tecnologico della macchina fotografica mostrò una realtà diversa dalla sua rappresentazione storica e più aderente al vissuto.

Anche nell’opera di Antonio Rovaldi (Parma, 1975) la pratica del viaggio assume il doppio significato di verifica del reale e analisi del linguaggio delle immagini, che tanto potere hanno sul nostro sguardo collettivo perché inibiscono sempre più una conoscenza non mediata del mondo. Sin dai suoi primi lavori Rovaldi ha esteso i confini della fotografia concettuale alla memoria e alla poesia del marginale, dell’incerto, del non-visibile, secondo una pratica di matrice, diremmo, situazionista, aperta all’attraversamento fisico del paesaggio, allo spaesamento, all’incontro con l’imprevisto, alla mancanza di prassi predeterminate o troppo orientate alla pura documentazione.
L’artista ha fatto del viaggio un suo personale modus operandi per affermare un modello sul tempo che unisce la verifica diretta della realtà e gli effetti sul suo vissuto interiore nell’incontro con l’incerto, l’inatteso, l’occasionale; muovendosi tra l’esplorazione in solitaria di luoghi non spettacolarizzati dall’immaginario culturale contemporaneo e la concezione del viaggio non come atto di consumo, ma come momento di riflessione sull’identità.
I suoi viaggi nascono in studio tramite ricerche storiche, approfondimenti di fonti geografiche e letterarie e la progettazione di itinerari; per poi passare alla verifica fisica dei luoghi, scandita dalla ripetizione dei gesti, dalla fatica dei non sempre facili spostamenti e dai pensieri che li accompagnano – fino al ritorno a casa, in studio, dove il viaggio continua a livello mentale. Una processualità che si trasforma in una geografia “elastica” – come la definisce lui stesso – che “si riadatta ogni volta al ritmo del nostro passo e al tempo dei nostri pensieri”.3 Una psicogeografia disegnata da fattori non controllabili: i cambiamenti meteorologici, l’incontro con l’accidentale, la marginalità di certi eventi, il tempo dell’attraversamento e della scoperta che confluiscono in uno sguardo inedito sul reale, volto a svelare la dimensione di quell’“infrasottile” tanto ricercato da Duchamp.
Un esempio calzante di questa pratica è Orizzonte in Italia (2011–15), un viaggio in solitaria lungo il perimetro della penisola italiana e della Sardegna, fatto in bicicletta, scattando centinaia di fotografie agli orizzonti marini. Una linea continua di mari e di cieli, ricomposta in un secondo momento in studio che, oltre a concretizzarsi in una mostra nel 2013 presso la galleria Monitor a Roma, ha preso anche la forma del libro d’artista (Humboldt Books, Milano 2015). Qui Rovaldi ha aggiunto alle fotografie degli orizzonti i suoi appunti di viaggio, sotto forma di annotazioni, memorie scritte, scatti ai paesi attraversati o a situazioni bizzarre.
In Orizzonte in Italia emerge una componente nuova del viaggio come pratica artistica: il senso dell’avventuroso, esperienza sempre più rara nel mondo occidentale. Rovaldi la ripresenta in un’altra sua opera-viaggio, che unisce due città lontane (una in Italia, l’altra negli Stati Uniti) accomunate dallo stesso toponimo, Modena. Invitato a presentare un lavoro inedito sul tema della Via Emilia per Fotografia Europea 2016, Rovaldi realizza Mo’dinna mo’dinna (I wanna go back home) (2016), una serie di fotografie in bianco e nero della sconfinata pianura americana, dove resiste questo piccolo borgo di case in legno dal nome Modena. Una camminata allegorica tra Est e Ovest, che mette in connessione due luoghi uno sconosciuto all’altro, amplificata dal sonoro di una voce fuori campo dell’unico abitante incontrato dall’artista nella Modena “del West”.
Altra opera di Rovaldi, Herr Erwin Brugger (2010) è un viaggio ancora diverso, più interiore e immaginifico, ispirato come per Vaccari da un fatto di cronaca – il ritrovamento nella neve del cadavere del poeta svizzero Robert Walser il giorno di Natale del 1958 – ripercorso con lo sguardo del presente insieme all’unico testimone: Erwin Brugger, il bambino che rinvenne casualmente il corpo di Walser. Come nell’Omaggio all’Ariosto, anche in quest’opera la vita reale incrocia la letteratura e la storia per dare corpo a una “terza memoria”: l’esperienza dell’artista che, grazie alla presenza del “testimone oculare” rivive un avvenimento del passato e innesca un gioco di specchi tra le sue fotografie, i ricordi di Brugger e gli scritti del poeta.
La presenza dell’altro, la verifica condivisa, la transmedialità autoriale, contraddistingue il percorso di Giovanna Silva (Milano, 1980), fotografa sensibile alle trasformazioni silenziose dei luoghi e ai rapporti con le persone. Silva ha reinventato il linguaggio della fotografia trasformando la pratica del reportage in un’esperienza di arte relazionale, espressa attraverso la forma del libro a più voci. Non un diario, ma una sorta di film muto, in cui i protagonisti incrociano impressioni, emozioni, esperienze come se fossero parti di un tutto unico.
Desertions (a+mbookstore edizioni, Milano 2009) è uno dei primi libri di questo genere, nato da un viaggio nei deserti americani insieme a Enzo Mari e Gianluigi Ricuperati. Del trio, Silva era “l’anima silenziosa” – come si autodefinisce nella prefazione4 – invitata a documentare nel corso del viaggio gli oggetti che il deserto abbandona. Composto da immagini in bianco e nero inframezzate da alcune a colori, il libro recupera un modo tanto antico quanto “nuovo” per la società odierna di vivere il viaggio, abbracciandone sia il carattere d’iniziazione che di scoperta.
Negli anni successivi, e dopo altri libri, la ricerca di Silva ha preso la forma di un progetto editoriale: Humboldt Books. Nata nel 2013 e ispirata alla figura dell’omonimo esploratore, la casa editrice di Silva è interamente dedicata a una diversa narrativa di viaggio creata dall’incontro di artisti e scrittori. Ad oggi, Humboldt Books ha prodotto numerose pubblicazioni sulla pratica del viaggio-opera, tutte uniche e diverse tra loro, frutto del lavoro di artisti – da Claudia Losi a Gabriele Basilico, da Ettore Favini a Carsten Höller, da Haris Epaminonda allo stesso Rovaldi – con cui Silva collabora in qualità di editore. Una metodologia di lavoro che si contrappone alla letteratura del viaggio di massa e che riporta in auge la preziosità dei materiali, i dettagli, la narrazione visiva alternativa.
Nei libri Tutta la solitudine che meritate. Viaggio in Islanda (Humboldt Books, Milano 2013) e Ontani a Bali (Humboldt Books, Milano 2016), Silva ritorna come autrice di una memoria visiva condivisa. Nel primo, insieme a Claudio Giunta, esplora l’Islanda alla ricerca di conferme e/o smentite sull’immaginario ammantato di mistero che circonda l’isola; nel secondo, la presenza di Luigi Ontani sull’isola asiatica per la realizzazione di un’opera, ha innescato una riflessione sul mito e la contemporaneità accompagnata dai testi di Emanuele Trevi.
Se in passato il viaggio era un rituale di formazione e ricerca, oggi Vaccari, Rovaldi e Silva lo hanno eletto a essenza stessa dell’operare artistico, confermando un noto adagio di Marcel Proust sull’importanza di giungere ad “avere nuovi occhi”.