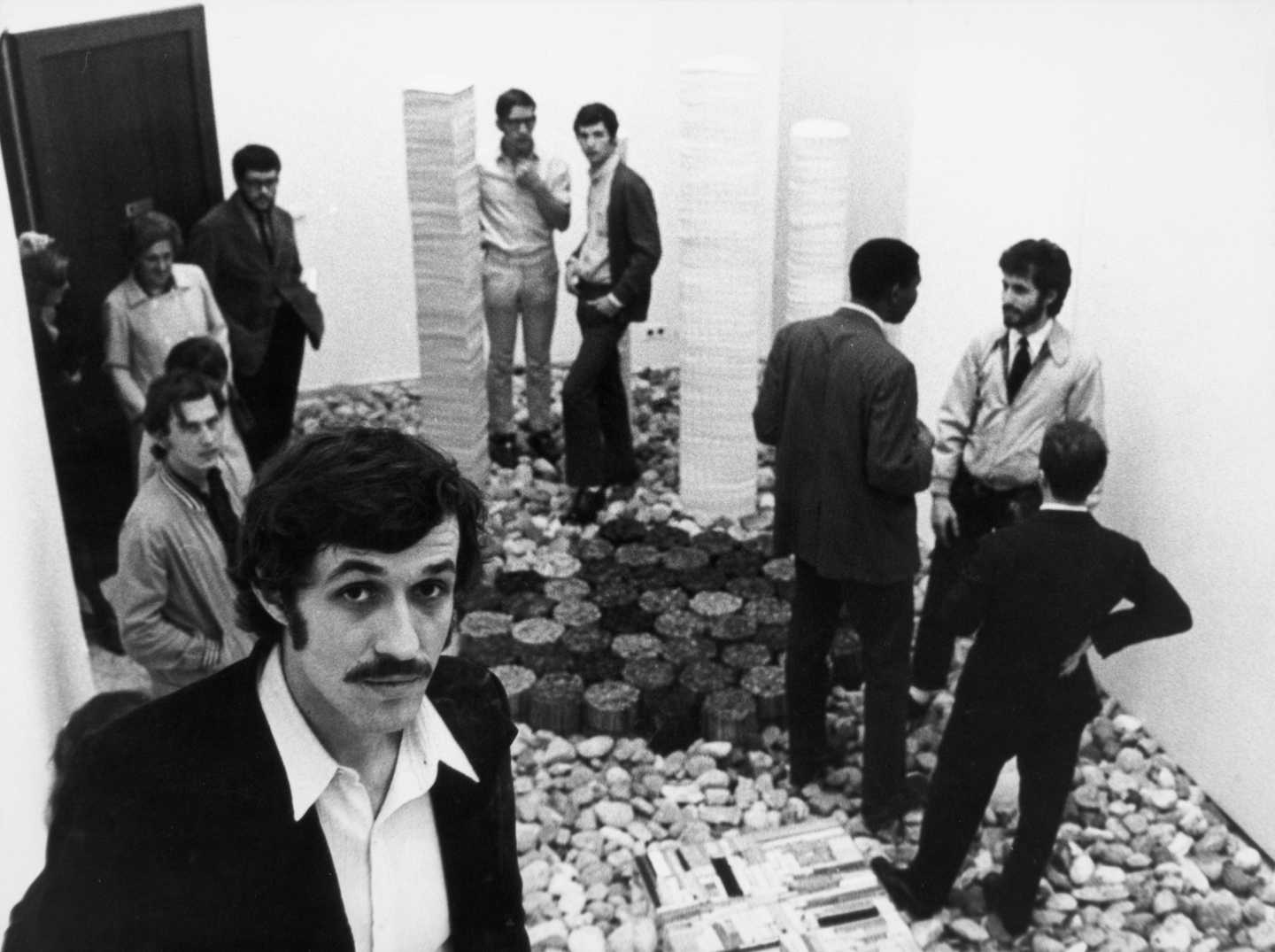Francesco Urbano Ragazzi: Un viaggio in Etiopia dopo un workshop alla Fondazione Spinola Banna nel 2010, un progetto con l’artista emiratina Alaa Edris durante il programma di residenza Mirroring e poi un lavoro sui boy-scout della Pennsylvania per il Padiglione di Bjarne Melgaard alla Biennale di Venezia. La tua spinta è la fuga?
Valentina Roselli: Iniziamo da “Banna Portraits”, il progetto che ancora adesso vivo in maniera più problematica. Quando ho frequentato il workshop in Piemonte ho avuto Peter Friedl come visiting professor. Nella sua visione, il capitalismo non produce più storia, ma solo artefatti, corpi e linguaggi. Mi sono chiesta cosa succede quando dei corpi senza storia si incontrano. Mi sono chiesta anche perché ritenevo importante di ritenere importante quel genere di argomenti. Così sono stata per tre settimane ospite di una tribù in una zona non toccata dal turismo nel sud dell’Etiopia. La mia idea iniziale era semplicemente quella di “stare”, di vivere in una dimensione di incontro puro, senza nessuna griglia socio-antropologica. Mi ero portata dietro una videocamera, la macchina fotografica e un quaderno: li ho usati solo come espedienti per cercare un contatto.
FUR: Da quell’esperienza, di cui stai ancora elaborando i materiali, hai iniziato a mescolare anche i segni riconoscibili della tua cultura a quelli di una cultura altra. È stato un modo per non rimanere neutrale nel contatto?
VR: Questo è accaduto soprattutto nella collaborazione con Alaa Edris, un’artista di Sharjah. Quando ho lavorato a “Sameage”, la nostra doppia personale, il primo bisogno è stato quello di uscire dai cliché in cui, in quanto donne, era facile cadere. In maniera naturale ci siamo scambiate video e foto di quando le nostre nonne erano giovani, per mantenere il confronto su un piano personale. Ho cercato di rintracciare alcune somiglianze tra i suoi input e i miei. Così ho sovrapposto una musica emiratina a un filmato di Adriano Celentano che balla, entrambi degli anni Settanta. Sembra che il molleggiato stia improvvisando una danza del ventre: invece nel montato originale canta Yuppi Du, una canzone in inglese maccheronico. Ho provocato una simultaneità.

FUR: Molti artisti della tua generazione preferiscono riflettere sulla memoria personale, più che sulla memoria storica. Secondo te perché?
VR: Personalmente, credo di controllare meglio la materia di cui parlo riferendomi a fatti che ho vissuto o che sono parte della mia vita indirettamente, attraverso i miei familiari. Ma sono solo punti di partenza da cui mi distacco presto: a chi importa la mia biografia?! Reperisco anche molti materiali su Internet, dove cose distanti nel tempo e nello spazio sono a portata di mano. Come se non fossero più né vicine né lontane.
FUR: Sembra ti stia occupando di un nuovo esotismo.
VR: Sì, mi interessa molto lo sforzo che ognuno fa per rappresentare e confermare la propria identità davanti allo straniero. I valori della cultura di appartenenza vengono stilizzati in modo quasi automatico.
FUR: Hai vinto il bando per gli atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa. Un’artista viaggiatrice ha bisogno anche di sedentarietà?
VR: Direi che qui sono come una marinaia. Ho strutturato il mio studio come una nave. C’è la cabina del capitano, dove proseguo la mia ricerca lavorando tra le altre cose sui 22 archetipi biblici — una sorta di linguaggio universale — e c’è il ponte, una piattaforma su cui avvengono una serie di incontri. A settembre ci sarà un festival di antropologia visiva e poi vorrei realizzare una collettiva assieme agli artisti che hanno avuto il mio studio prima di me (Squillacciotti, Blauer Hase, Genchi e Tadiello). Anche in questo caso, parto da una comunanza casuale per creare una genealogia tra identità altrimenti sconnesse.